In una mattina d’ottobre del 2003, Margaret Hayes – una vedova conosciuta nel suo tranquillo quartiere soprattutto per le famose crostatine al limone e per la sua gentilezza verso i gatti randagi – chiuse la porta di casa e uscì. Quella volta non aveva una meta precisa.
Era uno di quei rari giorni in cui la solitudine smette di essere soltanto un sentimento e diventa udibile. Lo scricchiolio di una sedia vuota. L’assenza di passi dietro di te. Un piatto che continui a preparare per due, anche se non ce n’è più bisogno.
Un’ora dopo, Margaret si trovava già davanti ai vecchi cancelli dell’orfanotrofio della città – un luogo che non visitava da anni, dai tempi delle feste di Natale in cui portava regali ai bambini privati del calore di una famiglia. Non aveva uno scopo preciso. Ma in quel momento, dietro a una porta logora, qualcuno la stava già aspettando: un bambino con un maglione rosso, troppo grande per lui. La pelle color cioccolato fondente e gli occhi… chiari, quasi trasparenti, come se racchiudessero gocce di cielo invernale.
“Come si chiama?” chiese Margaret.
“Non ha un nome. È stato lasciato qui due settimane fa. Nessun documento, nessuna richiesta. Nessuno è venuto a cercarlo. Molto probabilmente, un altro ‘bambino venuto dal nulla’,” rispose l’operatore.
Al polso del piccolo pendeva un braccialetto fatto in casa, un pezzo di stoffa decorato con bottoni e due lettere: “Ka.”
Margaret non aveva mai pensato di prendere un bambino con sé. E di certo non a sessant’anni. Non alla sua età. Soprattutto non un estraneo, silenzioso e senza passato. Ma disse:
“Posso portarlo con me?”
E con quella sola frase cambiò non solo la vita del bambino.
Lo chiamò Cairo. Nessuno seppe mai perché scelse quel nome. Forse perché evocava qualcosa di antico, potente, colmo di storie. Cairo non piangeva quasi mai, si ammalava di rado e già a due anni ripeteva qualsiasi suono con una precisione sorprendente. A cinque leggeva le etichette dei cibi e imparava la geografia osservando le mappe appese sopra il suo letto. A sette riparò da solo un vecchio tostapane, senza nemmeno sapere come funzionasse. Sembrava avere dentro di sé un ordine misterioso che gli adulti non riuscivano a decifrare.
Di notte, a volte, parlava nel sonno. Non in inglese. Non in balbettii infantili. In una lingua che ricordava un canto antico.
“Kafaro amma… Kafaro amma…”
Margaret una volta annotò quelle parole su un quaderno e le mostrò a un linguista universitario, che quasi fece cadere il caffè.
“Somigliano moltissimo a un dialetto perduto della costa africana. Si pensava fosse estinto da tempo.”
Lei non approfondì. Cairo era suo figlio, e questo bastava. Ma nel silenzio del suo cuore sapeva: quel ragazzo aveva radici più profonde di quanto potessero immaginare.
Gli anni passarono. Cairo crebbe: gentile, riflessivo, un po’ introverso – ma sempre attento, sempre in ascolto. Al liceo si appassionò all’elettronica, costruì una bicicletta a energia solare a sedici anni e ottenne una borsa di studio completa per studiare ingegneria e linguistica – un’accoppiata insolita, ma perfetta per lui. Voleva costruire cose, ma anche comprenderle.
Anche Margaret invecchiava. Forse più lentamente degli altri, perché l’amore per Cairo le dava uno scopo quotidiano. Non erano ricchi, ma le loro giornate erano piene.
Quando Cairo compì vent’anni, tornò all’orfanotrofio. Margaret pensava che volesse solo rivedere il luogo in cui la loro storia era cominciata. Ma tornò a casa con qualcosa di inatteso: una busta vecchia e impolverata, sigillata, con scritto “Ka” in una calligrafia familiare.
Il direttore dell’orfanotrofio l’aveva trovata dietro a un vecchio armadio, probabilmente caduta lì anni prima. Dentro c’era un piccolo quadrato di pelle – e una fotografia.
La foto ritraeva una donna dagli occhi luminosi e dal sorriso identico a quello di Cairo. In braccio teneva un neonato avvolto in un panno rosso. Sullo sfondo, una costa che Margaret non riconosceva.
Sotto la pelle, piegata con cura, c’era una lettera scritta in una grafia sconosciuta. Cairo la fissò per ore.
Quella notte Margaret si svegliò sentendo Cairo canticchiare. Quel canto antico, ancora una volta.
Ma non stava dormendo.
Era sveglio. Stava leggendo.
“Riesco a capirla,” disse, con gli occhi spalancati. “In qualche modo… so cosa dice.”
Nelle settimane successive smise di frequentare le lezioni. Passava ogni ora a decifrare la lettera. Margaret lo osservava, preoccupata. Mangiava poco. Dormiva meno.
Finalmente, una sera, si sedette al tavolo della cucina e disse sottovoce:
“Mamma… credo di sapere da dove vengo.”
Spiegò che la lettera era di sua madre biologica. Si chiamava Safiya. Apparteneva a una tribù nascosta chiamata Ka-Rim, che viveva su un’isola remota al largo della Guinea. La tribù si era rifugiata lontano dal mondo da generazioni, per custodire la propria conoscenza: storie tramandate su energia, equilibrio e una lingua capace di parlare sia alla mente che alla terra. Alcuni credevano che discendessero da antichi ingegneri.
Safiya aveva tentato di fuggire alle violenze della terraferma e aveva affidato Cairo alla speranza che qualcuno di buono lo avrebbe trovato. Scrisse quella lettera sapendo che forse non sarebbe mai arrivata a lui, affidandosi all’universo per proteggere suo figlio.
“Dice che il nome ‘Ka’ mi avrebbe guidato. Che ovunque fossi finito, lo avrei ricordato.”
Gli occhi di Margaret si riempirono di lacrime. “E tu lo ricordi?”
“Ricordo sensazioni. Suoni. Ma soprattutto… ricordo l’amore.”
Sei mesi dopo, Cairo partì per l’Africa occidentale. Non per ritrovare la tribù – ormai dispersa e perduta – ma per cercarne le tracce.
Tornò con manufatti. Scritti. Storie. Fondò una fondazione che univa tecnologia sostenibile e antica saggezza tribale, aiutando le comunità a produrre energia con risorse naturali.
Il suo primo grande progetto? Pannelli solari per orfanotrofi della regione. Il primo prese il nome di Hayes Home, in onore della donna che lo aveva cresciuto.
Oggi Cairo ha 33 anni. Margaret è morta due anni fa, serenamente, con Cairo accanto, che le teneva la mano e le sussurrava le stesse parole che lei un tempo aveva udito nel suo sonno:
“Kafaro amma…”
Non gli chiese mai cosa significassero.
Ma prima che esalasse l’ultimo respiro, Cairo glielo rivelò.
“Vuol dire: Tu sei il mio inizio.”
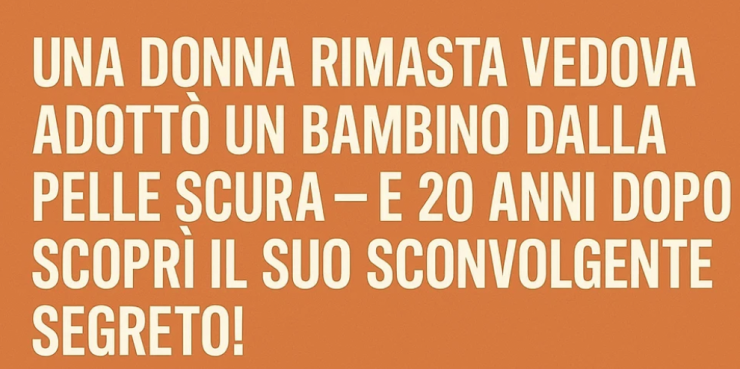



Add comment