Mia moglie, Lena, è morta nel sonno il 7 marzo. Hanno detto che era un aneurisma. Indolore. Improvviso. Un attimo era calda accanto a me, il suo respiro leggero sul mio collo. L’attimo dopo, era fredda. Immobile. Le labbra leggermente socchiuse, come se stesse per dire qualcosa.
Hanno detto che è stata una morte serena. Ma hanno mentito. Perché da quando Lena è morta, io mi sveglio con le sue urla. Sempre alle 3:17 del mattino.
È iniziato tre notti dopo il funerale. Ero ancora intorpidito, trascinandomi nei giorni come un fantasma. La gente continuava a portare cibo che non toccavo, lasciando condoglianze che non leggevo mai. Le notti erano le peggiori. Fu allora che il silenzio calò. Un silenzio che faceva male, interrotto solo da scricchiolii e sussurri, e la casa sembrava improvvisamente troppo vuota.
La terza notte il silenzio si ruppe. Mi svegliai di soprassalto, madido di sudore. L’orologio segnava 3:17, rosso nel buio. All’inizio pensai fosse il vento. Ma poi la sentii.
Un urlo. Crudo. Disumano. Proveniva dalla nostra camera da letto. La stanza dove era morta. Quella in cui non avevo più messo piede da quando i paramedici l’avevano portata via.
Pensai di stare sognando. Ma accadde di nuovo. E ancora. Non era solo quell’urlo. Poi iniziarono i piccoli segni. Una mattina trovai lo spazzolino di Lena bagnato. Il suo profumo aleggiava nel corridoio. Giurai che il letto fosse stato usato: lenzuola stropicciate, il cuscino affossato.
Temevo di impazzire. Il dolore può ingannare la mente. Così installai una telecamera. Un baby monitor economico, puntato verso la porta della camera. Non lo dissi a nessuno. Non volevo sentire frasi del tipo: “Devi parlare con qualcuno”.
Il giorno dopo, con le mani tremanti, guardai il filmato. Alle 3:16: nulla. Alle 3:17: la porta si spalancò. Non lentamente. Non con un cigolio. Con violenza. Come strappata dall’altra parte. Poi, l’audio: un urlo. Forte, assordante, pieno di dolore. Ma nessuno entrò. Solo quell’urlo. Poi la porta si richiuse, piano.
Smettei di dormire. Passavo le notti a cercare risposte. Fantasmi, poltergeist, varchi dimensionali… nulla sembrava spiegare. Perché questo non era un semplice fenomeno di infestazione. Era qualcosa di peggiore.
Lo specchio del corridoio si frantumò dall’interno. Il gatto di Lena, Clover, si piazzava ogni notte davanti alla porta della camera, urlando fino a farsi sanguinare la gola. E poi l’odore. Marcio. Terra bagnata. Muffa. Sangue vecchio. Dopo le 3:17, si diffondeva nel corridoio. Sempre più forte.
Provai a fuggire. Feci le valigie, presi una stanza d’albergo. Quella notte ricevetti una telefonata dalla reception: “C’è… qualcuno nella sua camera. Una donna. Urlava”. Ma la stanza era vuota. Sul cuscino, però, trovarono la fede nuziale di Lena. Era chiusa a chiave a casa, nei suoi effetti personali.
Tornai indietro. Forse per illudermi di darle pace. Entrai finalmente in camera. L’aria era pesante. Sul tappeto, accanto al suo lato del letto, c’era un’impronta. Piccola, nuda. Ma intrisa d’acqua. Il tessuto gocciolava, formando una pozza scura.
Installai due telecamere: una sulla porta, una dentro. La mattina dopo, il filmato mostrava statico, urla, e un’unica inquadratura limpida. Lena era seduta sul bordo del letto. Fradicia. Coperta di fango. La bocca spalancata in un urlo muto. Gli occhi neri. E dietro di lei, una figura alta, sfocata, con mani ossute sulle sue spalle. Senza volto. Solo denti. Centinaia di denti, che sorridevano.
Chiamai un prete. Rifiutò di entrare. Disse che non era un’infestazione: “È un passaggio. Ora è una porta”.
E aveva ragione. Perché dietro la testiera trovai un buco nel muro. Niente cartongesso, niente travi. Solo oscurità. Un tunnel stretto, nero, che puzzava come l’urlo di Lena. Lo sigillai con assi e chiodi. Ma quella notte mi svegliai soffocando nel fango. Acqua nera che colava dai capelli. Allo specchio, per un attimo, i miei occhi erano viola. E dietro di me… lei.
Andai alla tomba. Scavai finché le mani non sanguinarono. La bara era piena d’acqua. Vuota. Non c’era più lei. Qualcosa indossa la sua forma. Qualcosa la usa come porta.
E non è più sola. Ora sento altre voci. Risate di bambini. Sussurri in lingue sconosciute. Passi bagnati oltre la porta. Una notte bussarono. Tre colpi lenti. Poi un sussurro: “Lasciala entrare”.
Ho tentato di andarmene. Ma la strada si piega sempre. Alle 3:17 il cielo si oscura, l’auto si ferma, e mi ritrovo a casa. Il buco cresce. E respira.
So che domani entreranno. Lei davanti. E dietro… tutti i sorrisi.
E io li aspetterò. Perché la amo ancora. Anche adesso. Anche se sarà la fine di tutto.
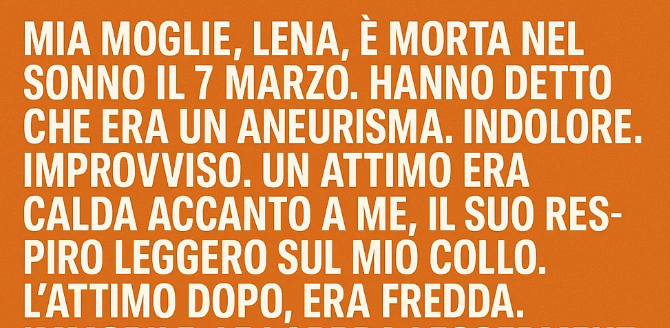
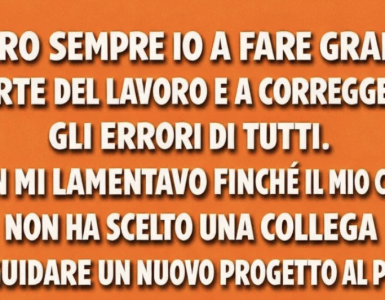

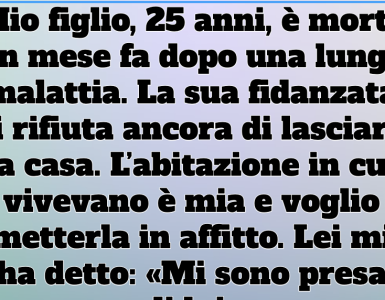
Add comment