Mia matrigna comprava a me e a sua figlia gli stessi vestiti.
La cosa curiosa è che avevamo anche lo stesso nome.
Un giorno siamo andate con lei in un salone di bellezza e la parrucchiera ci ha chiesto:
«Sono gemelle? Come si chiamano?»
Mia matrigna ha detto il nostro nome.
La parrucchiera ha chiesto: «Perché hanno lo stesso nome?»
E lei, con assoluta calma, ha risposto:
«Perché volevo che fossero uguali in tutto.»
Avevo dodici anni. Sua figlia, anche lei di nome Daniela, ne aveva undici.
La mia vera mamma era morta quando avevo nove anni. Un anno dopo, mio padre conobbe Bianca. Si sposarono in fretta, e lei portò con sé sua figlia.
Mi chiesi se lui vedesse in Bianca un rimpiazzo per mia madre.
Ma quando le vidi in salotto, con quei vestiti verdi identici, capii che lei aveva altri piani.
Bianca era… precisa. Amava la simmetria. Linee dritte, tazze abbinate, scarpe disposte per colore.
Credo che dare lo stesso nome a sua figlia e alla figliastra fosse solo una manifestazione in più della sua ossessione.
All’inizio era solo confuso. Quando qualcuno in casa gridava “Daniela!”, ci voltavamo entrambe.
Così ci inventammo dei soprannomi: io diventai “Dani A”, perché ero la più grande, e lei “Dani B”.
Ma anche quei nomi cominciarono a sparire quando Bianca insistette:
«Ora siete sorelle. Niente A e B. Solo Daniela. Le mie due bambine perfette.»
Ci vestiva uguali. Ci iscriveva alle stesse attività pomeridiane. Ci fece persino tagliare i capelli allo stesso modo.
All’inizio non mi pesava troppo: i vestiti erano carini, e io stavo ancora cercando la mia voce dopo la morte di mamma.
Ma col tempo, iniziai a sentirmi come una copia. E cominciò a pesarmi.
Dani B invece ne era entusiasta. Le piaceva avere una sorella “in coordinato”. Era solare, vivace, adorata dagli insegnanti.
Io? Io ero silenziosa. Amavo leggere, disegnare, guardare la pioggia cadere dal tetto.
Non mi sono mai sentita uguale a lei, per quanto Bianca si sforzasse di renderci identiche.
Col passare degli anni, tutto divenne più strano. Bianca continuava a insistere con l’idea delle “gemelle”, anche quando ormai non era più divertente.
Feste di compleanno identiche, una sola linea telefonica da condividere, e addirittura tentò di farci mettere nella stessa classe.
Peccato che non fossimo nemmeno nello stesso anno scolastico.
Mi è rimasto impresso quel momento al salone di bellezza:
«Volevo che fossero uguali in tutto.»
Non era amore. Era controllo. E da lì iniziai a notare le crepe.
Cominciai a scrivere in un diario. In segreto, ovviamente.
Scrivevo di come mi sentivo un’ombra nella mia stessa vita. Di come mio padre sembrasse sempre più distante, ripetendo: “Bianca sa cosa è meglio.”
E di come Dani B, pur essendo dolce, non capisse che io non volevo essere lei.
Poi, a quattordici anni, accadde qualcosa che ribaltò tutto.
Stavamo rovistando in soffitta per un progetto scolastico, e trovai un raccoglitore impolverato con scritto “Documenti di Daniela”. Pensai fosse mio.
Ma dentro c’erano delle carte d’adozione. Le mie carte d’adozione. Datate sei mesi dopo il matrimonio di Bianca e papà.
Rimasi a lungo seduta lì, senza fiato.
Mia mamma era morta. Mio padre si era risposato.
E poi… ero stata adottata? Ma io ero sua figlia. Non è così?
Quando lo chiesi a mio padre, lui rimase scioccato. Poi in silenzio.
E infine disse una frase che non dimenticherò mai:
«Bianca pensava che fosse meglio così. Più pulito. Voleva un nuovo inizio.»
Un nuovo inizio. Come se fossi un vecchio libro da rilegare con una copertina nuova.
Non ero adottata da un’altra famiglia — ero sua figlia biologica.
Ma Bianca mi aveva adottata legalmente, creando l’illusione di essere la madre di entrambe le “Daniela”.
Cancellando mia madre nel processo.
Non lo dissi subito a Dani B. Non ero sicura che potesse capire.
Lei vedeva Bianca attraverso un filtro rosa. Ma poi, pian piano, le cose iniziarono a cambiare.
Smettei di indossare i vestiti scelti da Bianca.
Mi iscrissi a un liceo diverso da quello di Dani B.
Un giorno, dopo scuola, mi tagliai i capelli cortissimi, senza chiedere il permesso.
La tempesta in casa fu devastante.
Bianca pianse. Disse che stavo distruggendo la famiglia.
Mio padre, per la prima volta, disse: «Forse vuole solo essere sé stessa.»
Era la prima volta che lo vedevo comportarsi davvero da padre.
Anche Dani B cominciò ad allontanarsi. Non perché non mi volesse bene, ma perché anche lei iniziava a vedere le crepe.
Una notte mi sussurrò:
«Non ti sembra di recitare in una commedia scritta da Bianca, senza conoscere la tua parte?»
Ridiamo. Poi piangemmo.
E poi arrivò il colpo di scena.
A sedici anni, Bianca ricevette una diagnosi di cancro al seno.
Fu aggressivo. In un anno, se n’era andata.
Potresti pensare che mi sentii sollevata, ma non fu così.
Mi sentivo confusa. Arrabbiata. Colpevole.
Aveva cercato di plasmarmi, sì. Ma mi aveva anche cresciuta, quando mia madre non poteva più farlo.
Non era crudele in senso classico. Solo… persa nel suo bisogno di controllo.
Al funerale, in molti ci dissero: «Siete fortunate. Vi ha voluto tanto bene.»
Sorrisi e annuii, ma dentro volevo gridare:
Ha amato me, o l’idea che aveva di me?
La sorpresa più grande arrivò con la lettura del testamento.
Ci lasciò una lettera ciascuna.
La mia era lunga. Confusa. Ma dentro scrisse qualcosa che ancora oggi tengo piegato nel portafoglio:
«Ho cercato di farti diventare mia figlia modellandoti in qualcuno che potessi comprendere.
Ma tu eri già qualcuno, e io non riuscivo a vederlo.
Spero tu possa perdonarmi.
Spero che tu viva in modo forte e unico, come desideri.
Ti ho chiamata Daniela perché pensavo che l’uguaglianza portasse unità. Mi sbagliavo.»
Quella lettera mi spezzò. E mi guarì.
Dopo il liceo, io e Dani B ci siamo allontanate.
Lei si è trasferita. Io sono rimasta, ho iniziato l’università, mi sono appassionata alla fotografia.
Ci scrivevamo ogni tanto, ma avevamo bisogno di tempo per diventare persone intere.
Poi, due anni fa, mi chiamò.
«Sono incinta,» disse. «E… vorrei chiamarla Daniela. Ma solo se tu sei d’accordo.»
Scoppiai a ridere, con le lacrime agli occhi:
«Solo se non dovrà mai condividere il telefono con nessuno.»
Da lì ci siamo ritrovate.
Piano. Con conversazioni vere, senza vestiti abbinati, senza aspettative.
Solo due persone con lo stesso nome, lo stesso passato, e finalmente — futuri diversi.
Qualche mese fa l’ho visitata. La piccola Daniela, oggi di due anni, ha ricci ribelli e un mento testardo.
Non sopporta sentirsi dire “no” e canta stonata tutto il giorno. È perfetta.
Una sera, le facevo il bagnetto mentre Dani B preparava la cena.
Mi ha schizzato d’acqua e ha riso: «Zia Nela!»
Era la prima volta che sentivo il mio nome da lei.
Non Daniela. Solo Nela.
E ho capito: i nomi sono solo nomi. I vestiti sono solo vestiti.
Conta chi diventiamo, quando finalmente qualcuno ci vede per ciò che siamo.
Bianca non ha mai conosciuto quella versione di me.
Ma, nei suoi modi sbagliati, mi ha aiutata ad arrivarci.
A chiunque si sia mai sentito costretto a rimpicciolirsi per entrare in un’idea altrui —
non devi farlo.
Non sei una copia. Non sei un rimpiazzo. Sei te stesso.
E questo basta. E avanza.
Condividilo se anche tu hai lottato per trovare la tua voce — o se finalmente l’hai trovata. Metti “mi piace” se credi che nessuno debba mai spegnere la propria luce per sentirsi amato.
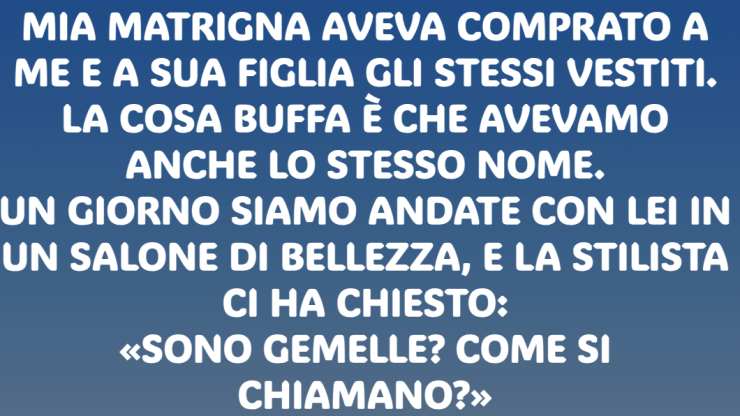
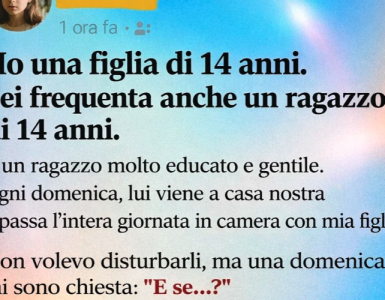

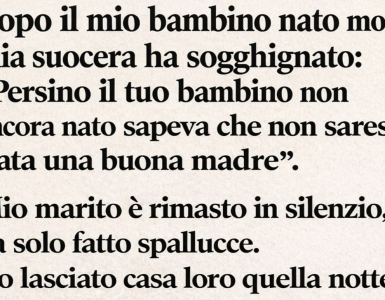
Add comment