Era la prima volta che incontravo i genitori di Luca, il mio fidanzato. Ero nervosa, avevo scelto con cura cosa indossare: una camicetta color panna, semplice ma elegante. Ma bastò entrare nella loro casa perché ogni sicurezza svanisse.
Il padre di Luca evitava chiaramente di guardarmi negli occhi. O forse, evitava di guardarmi in generale. La madre, invece, mi squadrò per bene prima di lasciarsi sfuggire un mezzo sorriso e dire con una punta d’ironia:
“Beh, mio figlio è proprio fortunato.”
Mi irrigidii. Non capivo se fosse un complimento o una provocazione. In ogni caso, non risposi. Mi limitai a sorridere, anche se dentro volevo scomparire.
Fu solo quella sera, una volta tornata a casa, che capii. Mentre mi spogliavo davanti allo specchio, mi fermai di colpo: la camicetta era completamente sbottonata al centro. Avevo passato l’intero pranzo con metà reggiseno in vista.
Mi sentii morire dalla vergogna.
Scrissi subito a Luca: “Perché non mi hai detto niente?!”
La risposta arrivò dopo pochi minuti: “Giuro che non me ne sono nemmeno accorto… Ero troppo in ansia per come ti avrebbero trattata.”
Quella frase mi fece sorridere. Per un attimo.
Poi tornai a guardarmi allo specchio. E notai quel livido appena visibile sulla clavicola, che da giorni mi dava fastidio. E che avevo cercato di ignorare.
Non avevo ancora parlato a Luca della visita che avevo fatto alla clinica il mese prima. Una mammografia, solo per precauzione. Avevo pensato fosse colpa dello stress, degli ormoni. Ma ora… se sua madre aveva notato la camicetta aperta, aveva notato anche quello?
Il giorno dopo chiamai la clinica. La receptionist controllò i dati e poi si bloccò:
“In realtà c’è una nota… doveva tornare per un controllo due settimane fa.”
Rimasi gelata.
“Nessuno mi ha detto nulla.”
La donna si scusò, spiegando che c’era stato un errore con i contatti. Una confusione tra due pazienti.
Chiesi allora il nome dell’altra paziente.
“Silvia Rossi.”
Mi mancò il respiro. Silvia Rossi era la madre di Luca.
Magari era solo un caso. Ma non riuscivo a togliermi dalla testa quel sorrisetto, quello sguardo strano durante il pranzo.
Quel weekend, li invitai entrambi da noi per una “cena riparatrice”.
Silvia si presentò con una camicia di seta e un sorriso forzato. Suo marito portò una bottiglia di vino. Luca era agitato, correva avanti e indietro per la cucina.
A metà cena, guardandola con calma, le dissi:
“Ho ricevuto una chiamata dalla clinica. Dicevano che avevano sbagliato numero. Ma a riceverlo… sei stata tu, Silvia.”
Il suo volto si irrigidì per un istante, poi scrollò le spalle:
“Capita. Magari hanno confuso i dati.”
“Non credo. Tu… hai lavorato lì, vero?”
Rumore di forchetta che sbatte sul piatto. Nessuna risposta.
Luca si alzò di scatto.
“Qualcuno vuole il dolce?”
La tensione era insostenibile.
Quando rimasero soli, gli chiesi:
“Tua madre ha mai chiesto informazioni sulla mia salute?”
Esitò. Poi annuì.
“Mi ha chiesto se avessi avuto problemi di salute in passato. Le ho detto di no. Ma perché me lo chiedi?”
Lo guardai negli occhi.
“Perché ha ricevuto al posto mio la telefonata della clinica. E non è un caso.”
Qualche giorno dopo, Luca venne da me, pallido.
“Me l’ha confessato. Ha chiamato fingendosi te. Voleva sapere se c’era qualcosa che non andava prima che ci sposassimo.”
Non riuscivo a parlare.
“Dice che era solo per proteggermi. Ma le ho detto che ha superato un limite.”
“Non si è fidata di me,” mormorai.
“Non si fida di nessuno,” rispose.
“Ma io mi fido di te.”
Si sedette accanto a me e mi prese la mano.
“Se vuoi andarcene, solo noi due, lontani da tutto questo… lo facciamo. Niente matrimonio, niente drammi. Solo tu e io.”
Lo guardai. C’era amore nei suoi occhi. Ma anche un peso.
“Non voglio andarmene,” dissi. “Ma abbiamo bisogno di confini. Grandi.”
Andai al controllo.
Non era nulla di grave. Solo una formazione benigna, alcune cisti innocue.
Il medico mi sorrise: “Ha fatto bene a tornare. Meglio una visita in più che una in meno.”
Mentre tornavo a casa, realizzai una cosa.
Le persone fanno sciocchezze quando hanno paura. A volte superano confini che non dovrebbero. Ma per andare avanti, davvero, serve chiamare le cose con il loro nome. E decidere chi vale la pena perdonare.
Non perdonai subito Silvia.
Ma quando si presentò a casa mia, con un mazzo di fiori e un vero, sincero:
“Scusami. Ho sbagliato.”
Capì che da lì si poteva ricominciare.
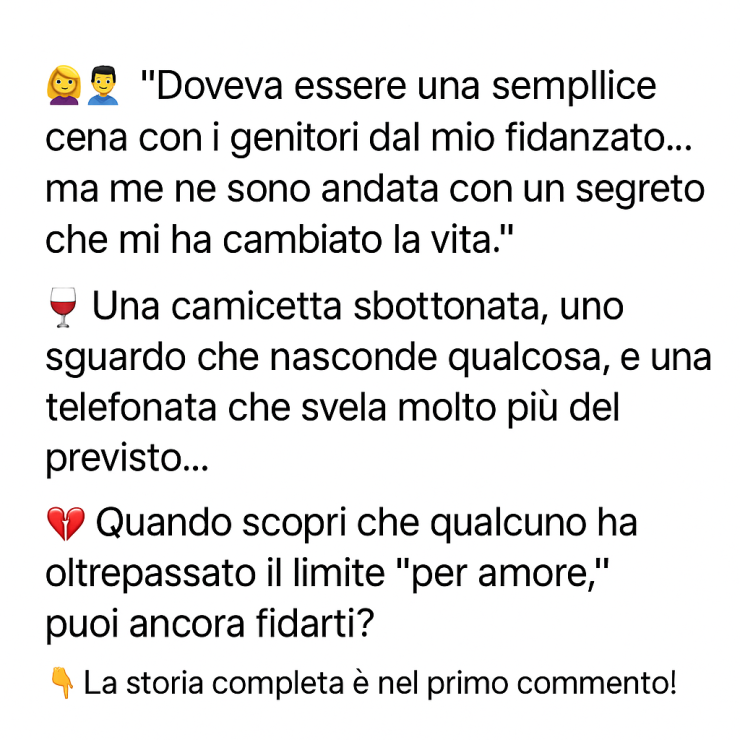

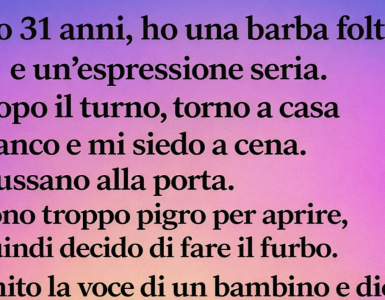
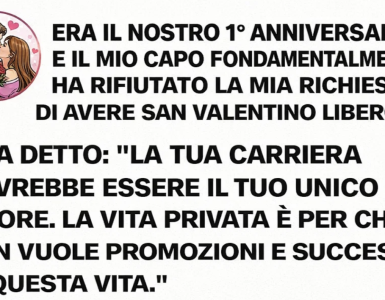
Add comment