Sono tornata a casa e il mio ragazzo stava dormendo.
Sono andata in bagno e sono rimasta sconvolta nel vederlo sotto la doccia.
Presadall’ansia ho urlato:
«C’è qualcuno nella nostra stanza!»
Lui è diventato pallido e mi ha detto di correre in macchina, chiuderla a chiave e chiamare il 112.
Più tardi quel giorno, sono rimasta orrorizzata quando ho scoperto che la polizia non aveva trovato nessuno in casa.
Nessun segno di effrazione.
Nessuna impronta di fango.
Niente è sparito.
Solo una porta sul retro lasciata aperta e il mio ragazzo che giurava di essere stato a letto tutto il tempo.
Ma so quello che ho visto.
Ho visto un uomo che sembrava proprio lui.
Stessa corporatura.
Stesso tatuaggio vicino alle costole.
Stesso sorriso storto dietro il vetro smerigliato della doccia.
Non stavo vedendo allucinazioni.
Non avevo bevuto o altro.
Ero lucida.
E ora mi dicevano che era solo un’illusione dovuta allo stress.
Si chiama Rayan.
Stiamo insieme da quasi quattro anni.
Abbiamo iniziato a convivere dopo dieci mesi di frequentazione.
È sempre stato calmo, gentile.
Uno di quei tipi sempre un po’ scarichi, sempre con una tazza di caffè in mano, sempre a canticchiare jazz in silenzio.
Niente di lui mi ha mai spaventato.
Fino a quella notte.
Non ho dormito per due giorni di fila.
Rayan diceva che dovevo essere stanca e avevo sognato.
Che aveva sentito parlare di «falsi risvegli» e che il cervello inganna nei primi cicli del sonno.
Ma non mi convinceva.
Io non stavo dormendo.
Ricordo di aver parcheggiato, entrata, appoggiato la borsa, superato le sue scarpe.
Era reale.
E la cosa peggiore?
Quella non era l’unica cosa strana che è iniziata ad accadere.
Tre notti dopo mi svegliai alle tre e sentii passi in casa.
Lenti, scricchiolanti.
Sbadigliai a Rayan, gli dissi:
«Hai sentito?»
Era già sveglio.
Guardava il soffitto, occhi spalancati.
Trattenemmo il respiro.
Poi sentimmo l’acqua del rubinetto della cucina aprirsi per tre secondi e poi chiudersi.
Niente piatti, niente cassettiobotta, solo l’acqua.
Rayan si sedette e prese la mazza da baseball che teniamo sotto il letto.
«Resta qui,» disse, ed uscì piano dalla stanza.
Lo seguii comunque.
Non c’era nessuno. Di nuovo.
Nessuna finestra aperta.
Nessun calzino fuori posto.
Ma il rubinetto continuava a gocciolare.
A quel punto ero esausta.
Gli dissi che servivano delle telecamere.
Lui acconsentì.
Due giorni dopo ne montammo tre—portone, soggiorno e cucina.
Tutte con sensori di movimento e collegate al mio telefono.
Per quasi due settimane non successe più nulla.
Niente rumori strani.
Nessun estraneo in casa.
Tutto così silenzioso che quasi giurai di aver immaginato tutto.
Quasi.
Finché una sera, tornai tardi dal lavoro e Rayan non c’era.
Aveva scritto un messaggio dicendo che aveva un appuntamento dal dentista, ma alle nove di sera non era ancora tornato.
Guardai le telecamere.
Quello che vidi mi gelò il sangue.
Alle 18:17, Rayan entrò in casa con una busta della spesa.
Sembrava tranquillo.
Appoggiò la borsa, si tolse le scarpe e andò in cucina.
Alle 18:41, entrò di nuovo.
Stessa borsa.
Stesso ingresso.
Stesso abbigliamento.
Sbadigliai.
Scorsi indietro.
Rividi il video.
Il primo Rayan non era mai uscito.
Era in cucina mentre il secondo entrava.
Lo chiamai subito.
Non rispose.
Chiamai tre volte prima che mi scrivesse:
«Sono ancora dal dentista. Sono in ritardo. Torno presto.»
Non sapevo cosa pensare.
Mi sentivo male.
Non mi sentivo al sicuro, ma non volevo lasciare la casa e lui—chiunque fosse lui—da solo lì dentro.
Gli scrissi:
«Ehi, puoi mandarmi una foto tua dal dentista? Tipo della tua poltrona o qualcosa del genere?»
Non rispose.
Rimasi impalata sul divano finché non sentii la porta aprirsi.
Mi alzai con lo spray al peperoncino in mano.
Rayan entrò—calmo come sempre, con una busta di cibo da asporto tailandese.
«Ehi tesoro,» disse come se niente fosse.
Lo guardai fisso.
«Dove sei stato?»
«Dal dentista,» disse, posando il cibo. «Poi sono passato a prendere questo.»
«Perché non rispondevi al telefono?»
Tirò fuori il cellulare dalla giacca.
«Era scarico. Ho lasciato il caricabatteria al lavoro.»
Stavo per perdere la testa.
«Okay,» dissi, «allora chi è entrato alle 18:17 con la spesa?»
Lui sbatté le palpebre, confuso.
«Cosa?»
Gli feci vedere i video dalle telecamere.
Il suo volto si spense.
Cadde pesante sullo sgabello e sussurrò,
«Non capisco.»
E poi, la parte più incredibile, disse:
«Quella busta sembra contenere il latte che ho comprato giovedì scorso. Ricordo l’ammaccatura sull’etichetta.»
A quel punto il mio stomaco si chiuse.
Rayan rimase in silenzio per un lungo momento.
Poi si alzò e andò nell’armadio del corridoio.
Frugò in una vecchia scatola che non apriva da anni.
Tirò fuori un vecchio laptop. Nero. Ammaccato agli angoli.
Si sedette a terra, lo collegò e lo accese.
Gli chiesi:
«Cosa stai facendo?»
«Devo controllare una cosa.»
Quello che aprì sembrava un foglio di calcolo.
Nomi. Indirizzi. Appunti in una lingua che non riconoscevo.
Non disse nulla per quasi dieci minuti.
Solo scorse e cliccò.
Finché sussurrò,
«Credo di sapere cosa sta succedendo.»
Alzò gli occhi verso di me.
«C’è qualcosa che non ti ho mai detto.»
A quanto pare, prima di incontrarmi, Rayan lavorava per una startup che offriva servizi di sorveglianza privata a clienti molto ricchi—ultra ricchi.
Persone che non vogliono solo la sicurezza della casa—vogliono la sicurezza della vita.
Persone che seguono i propri coniugi, rivali in affari, persino i propri figli.
Lui era un analista tecnologico.
All’inizio nulla di sospetto.
Poi hanno sviluppato qualcosa chiamato “Clonazione del Profilo”.
Un software che raccoglieva dati—foto, movimenti, abitudini, registrazioni vocali—e li usava per creare doppi digitali quasi indistinguibili.
Ma non si fermava al digitale.
Incaricavano dei freelance di “rappresentare” le persone reali—comparivano in caffè, aeroporti, indossavano abiti simili.
Tutto per confondere chi stava spiando.
Per sfumare tempi e tracce.
«Esche,» disse.
«Ho aiutato a progettare il software, ma me ne sono andato quando ho capito che veniva usato senza consenso.»
Gli chiesi senza mezzi termini:
«Pensi che ti abbiano clonato?»
«Non lo so,» disse.
«Ma quella busta di latte… non è di oggi.
E non faccio la spesa da più di una settimana.»
Non dormii quella notte.
La mattina dopo Rayan controllò i log delle telecamere e trovò altro.
Alle 2:36 della stessa notte, i video si erano interrotti per esattamente 47 secondi.
Tutte e tre le telecamere.
Niente altro in casa aveva fatto blackout.
Solo quelle.
A quel punto decidemmo di andarcene.
Non per sempre. Solo una pausa.
Facemmo le valigie e andammo a stare da mia cugina Farah dall’altra parte della città.
Lasciammo la casa vuota.
Impostammo gli allarmi. Aspettammo.
Due giorni dopo fu rilevato un movimento in soggiorno.
Rayan guardò il video.
Quello che vedemmo terrorizzò.
Era lui.
Ma non del tutto.
Stesso volto.
Stessa giacca che aveva donato il mese prima.
Ma la postura era… strana.
Si muoveva in modo diverso.
Più veloce.
Più impulsivo.
Non si sedeva.
Girava a vuoto in cerchio.
Apriva ogni cassetto.
Toccava i muri come per ricordare qualcosa.
Poi guardò dritto nella telecamera.
Rayan trasalì.
«Sei tu?» chiesi.
«Non lo so,» rispose.
Arrivarono di nuovo i poliziotti.
Ancora nessun segno di effrazione.
Nessuna impronta.
Niente sparito.
Quella notte ricevetti una telefonata da un numero sconosciuto.
La voce di una donna.
Disse:
«Non mi conosci, ma sono stata con Rayan.
E se stai vedendo cose… doppi… significa che non hanno mai smesso di lasciarlo andare.»
Le chiesi il nome.
Riattaccò.
Rayan negò tutto.
Disse di non aver visto nessuna ex da anni.
Non sapeva chi fosse quella donna.
Ma il seme era seminato.
E se non era stato un caso?
Se fosse stata una punizione?
Un avvertimento?
Decidemmo di andare a trovare una sua ex collega—Sasha, una programmatrice che aveva lasciato la stessa azienda un mese prima di Rayan.
Sasha era in condizioni pessime.
Viveva in un piccolo monolocale con tende oscuranti e scorte di cibo in scatola.
«Sapevo che sarebbe successo,» disse quando lo vide.
«Ci hanno fatto costruire qualcosa di troppo potente.»
Ci disse che dopo aver lasciato l’azienda, il profilo di Rayan era stato segnalato. Non cancellato.
«Chiunque esca con quel tipo di accesso—non ti lasciano andartene così.»
Era finita lì.
Dovevamo sparire del tutto.
Abbiamo abbandonato i telefoni.
Eliminato i social.
Siamo andati a stare da mia zia nell’Ontario rurale—niente telecamere, niente internet, nessuna traccia.
Tre mesi passarono.
Nessun doppio.
Nessun glitch.
Abbiamo ricominciato a dormire.
A ridere.
Poi una sera arrivò una lettera.
Senza francobollo.
Senza mittente.
Dentro c’era una chiavetta USB.
Rayan la collegò.
C’erano sei video.
Ognuno lo mostrava—in città diverse—a fare cose diverse.
Uno che mangiava sushi a Tokyo.
Uno che correva vicino al Tamigi.
Uno che scendeva da un taxi a São Paulo.
Tutti con la data del medesimo giorno.
Ripresi da telecamere stradali.
L’ultimo video era il più inquietante.
Mostrava me.
Entrare nel nostro caffè preferito a casa.
Da sola.
Eppure lì non ci mettevo piede da mesi.
Volevo piangere.
Ma Rayan mi tirò a sé e disse:
«Ora basta.»
Trovò i metadati dei video e rintracciò una società di Berlino—un gruppo di ricerca AI che aveva acquistato silenziosamente la sua vecchia azienda.
Usammo i risparmi, volammo lì e incontrammo un giornalista, Ilias, che seguiva quella società da un anno.
Quando gli raccontammo tutto, lui disse:
«Non siete i primi.
Ma potreste essere gli ultimi.»
Ci aiutò a denunciare tutto.
Fece scoppiare il caso.
Pubblicò nomi, codici, video.
La storia divenne virale in pochi giorni.
E così i cloni sparirono.
Come se la minaccia fosse sempre esistita nell’ombra.
Un anno dopo, stiamo ancora guarendo.
Viviamo in una città più tranquilla.
Abbiamo un cane.
Io insegno yoga.
Rayan lavora il legno.
A volte controlliamo ancora le finestre.
Ci fermiamo quando vediamo qualcuno di familiare in strada.
Ma stiamo bene.
Credo che la cosa più spaventosa non fosse essere spiati.
Ma non sapere chi o cosa stesse dietro lo sguardo.
Ora sappiamo.
E abbiamo imparato una cosa importante:
La verità lascia sempre tracce.
Bisogna solo avere il coraggio di seguirle.
Se ti sei mai sentito che qualcosa non va, che il mondo è cambiato senza dirti niente—non sei pazzo.
Stai solo facendo attenzione.
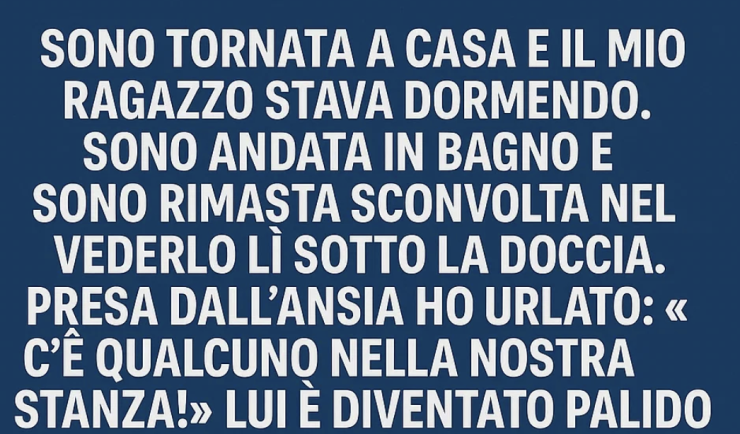
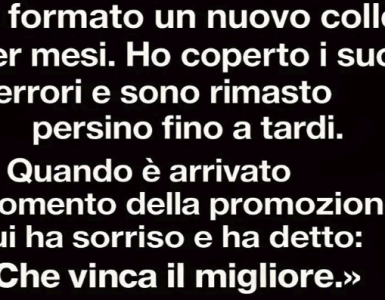


Add comment