“Ho fatto un colloquio per una posizione da sales manager. Mi hanno chiesto di vendere una penna. Era la terza volta quel giorno che mi veniva chiesto, così ho guardato il costoso pennarello tra le mani e ho detto:
‘Sapete una cosa? Questa penna non vale nulla… finché non avete un motivo per scrivere.’”
Quella frase catturò subito la loro attenzione. I due intervistatori—uno in blazer grigio, l’altro intento a scorrere qualcosa sul telefono—alzavano entrambi lo sguardo. Continuai a parlare.
“Forse vostra figlia è appena stata accettata al college e dovete scriverle un assegno. Oppure state firmando i documenti per la vostra prima casa. O magari state scrivendo ‘Mi dispiace’ a qualcuno che lo merita. Questa penna non si vende da sola. La vita lo fa.”
Ci fu un lungo silenzio. Poi l’uomo in blazer sorrise. “Va bene,” disse. “Non è… la presentazione che mi aspettavo.”
Pensai di averla rovinata. Uscì dall’edificio con la sensazione di aver appena fatto un TED Talk a due manichini.
Ma quel giorno qualcosa cambiò. Non nella stanza del colloquio, ma dentro di me.
Ero disoccupato da sette mesi. Non una disoccupazione divertente, ma una disoccupazione da povero: vendevo mobili su Facebook per racimolare qualche soldo, evitavo le telefonate della compagnia elettrica. Quell’intervista era una delle sei che avevo fatto quella settimana. Continuavo a dire alle persone che ero “tra un ruolo e l’altro”, come se fossi un manager in viaggio, non qualcuno licenziato da un lavoro di medio livello in una catena di forniture cartacee che era fallita da un giorno all’altro.
Quel lavoro non era stato glamour, ma ero bravo. Numeri, persone, arrivare presto, restare fino a tardi. E improvvisamente, niente contava più. Avevo inviato novanta curriculum, ricevuto forse dieci rifiuti cortesi e un mare di silenzio.
La storia della penna? Accadde di giovedì. Il venerdì ricevetti una chiamata—non da loro, ma da un’altra azienda che avevo completamente dimenticato. Una startup. La responsabile HR, voce nervosa e troppi “ehm”, disse che le piaceva il mio curriculum e voleva incontrarmi. Non per vendite, ma per un ruolo chiamato “client experience liaison”. Non avevo idea di cosa significasse, ma dissi subito sì.
Indossai lo stesso completo del colloquio della penna, anche se la fodera si stava staccando dal polsino. Non importava. Importava come mi avevano fatto sentire: visto, ascoltato, come se non cercassero solo un robot delle vendite.
Il colloquio si svolse in un piccolo magazzino riconvertito—metà ufficio tecnologico, metà caffetteria. Spazio aperto, sedie colorate, tre cani che gironzolavano come se fossero i padroni del posto. La fondatrice era una donna di nome Charita, sulla quarantina, dreadlocks lunghe, occhi limpidi. Non mi chiese di vendere una penna. Mi chiese come avrei gestito un cliente arrabbiato alle 22 perché una spedizione non era arrivata.
Le dissi la verità.
“Mi scuserei. Anche se non fosse colpa nostra. Prima ascolto, poi risolvo. La gente vuole essere ascoltata prima di essere aiutata.”
Annui lentamente. Poi mi chiese se andasse bene lavorare con un “contratto in prova” di 60 giorni. Paga: 23 dollari l’ora—meno di prima, ma meglio di niente. Accettai.
Iniziai lunedì.
Quel lavoro non cambiò la mia vita dall’oggi al domani. Ma qualcosa cominciò a succedere, lentamente. Cominciai a ricordare chi ero prima del licenziamento—prima delle bollette, dei dubbi, della spirale mentale che mi faceva sentire un fallimento solo per mangiare cereali alle 14.
Cominciai a restare fino a tardi di nuovo, non perché dovessi, ma perché mi piaceva essere utile. Sistemai il loro sistema di help desk usando un foglio Excel che avevo costruito al vecchio lavoro. Aiutai gli stagisti a scrivere email migliori. Perfino organizzai un pranzo condiviso un mercoledì a caso, che poi divenne tradizione mensile.
Ma la cosa più importante? Dopo circa tre settimane, Charita mi chiese di aiutarla con un pitch deck per un incontro con investitori. Aveva visto la mia presentazione a un cliente su Zoom e disse che avevo “una buona energia calma”.
Lei però non era calma. Nervosa, sudata, balbettava le parole.
La fermai e dissi: “Dimentichiamo le slide. Dimmi solo quale problema stai risolvendo e perché ti importa.”
Lei mi guardò sorpresa. Poi lo fece.
Quella sera restammo due ore dopo che tutti se ne erano andati, a parlare della sua startup, della sua famiglia, di quando lavorava al customer service di una compagnia aerea e quanto lo detestasse. Io ascoltavo, facevo domande, prendevo appunti. Nient’altro.
La mattina dopo ottenne il finanziamento.
Non grazie a me—ma forse un po’ perché l’avevo aiutata a credere nella propria voce.
Dopo i 60 giorni, mi chiamò nel suo ufficio. Pensai mi avrebbe ringraziato e detto che il contratto era finito. Invece, scivolò un foglio sul tavolo.
Era un’offerta a tempo pieno. Stipendio più alto di quello che guadagnavo al lavoro precedente, titolo migliore, benefit.
E sul margine, scritto a penna blu, c’era:
“Grazie per avermi aiutata a scrivere il prossimo capitolo.”
Quasi piansi.
Da lì le cose presero velocità. Sei mesi dopo, fui promosso a Head of Client Strategy. Assunsi tre persone, tutte disoccupate da un po’. Uno di loro, un ragazzo tranquillo di nome Marwan, mi confidò di essere stato rifiutato 22 volte di fila. Gli dissi: “So cosa si prova.”
A pranzo scherzavamo sulla storia della penna. “La vita vende la penna,” dicevamo. Divenne un piccolo mantra. Lo stampammo persino sulle tazze come regalo natalizio per il team.
Ma ecco il colpo di scena—la parte che non mi aspettavo.
Un giorno, quasi un anno dopo, ricevetti un messaggio su LinkedIn. Era il tipo in blazer grigio del primo colloquio. Si chiamava Tolan. Scrisse:
“Ciao, non so se ti ricordi di me, ma l’anno scorso ti ho intervistato alla Prestique Group. Volevo solo dirti che penso spesso a ciò che hai detto della penna. Probabilmente non lo sapevi, ma l’azienda stava chiudendo e ci avevano detto di continuare comunque a fare colloqui—per ‘mantenere l’apparenza’. Totalmente assurdo. Ma il tuo discorso mi è rimasto in testa. Spero tu stia bene.”
All’inizio non sapevo cosa provare—sorpresa, gratificazione, forse un po’ di rabbia. Ma soprattutto… calma.
Gli risposi:
“Grazie per averlo detto. Quel giorno avevo l’impressione di parlare al muro. Ma onestamente, perdere quel lavoro è stata la cosa migliore che non mi sia mai successa.”
Rispose qualche ora dopo. Aveva lasciato Prestique poco dopo e avviato la sua consulenza. Poi—e qui viene il bello—mi chiese se volevo fare da consulente per uno dei suoi clienti.
Io.
Il ragazzo che a mezzanotte provava elevator pitch davanti allo specchio, ora veniva chiesto per la sua esperienza.
Ovviamente dissi sì.
Non era un progetto enorme. Solo tre chiamate Zoom in un mese. Ma ben pagate. E ne seguirono altre. La voce si sparse e presto ricevetti incarichi per aiutare fondatori a migliorare il contatto con i clienti, costruire pitch deck e formare nuovi assunti sulla comunicazione empatica.
Uno di questi incarichi si trasformò in un ruolo di advisory board. Un altro mi portò ad Austin per parlare a un summit per piccole imprese. Non indossai un completo—sneakers e giacca di jeans. Ma iniziai il discorso con la storia della penna. Tutti risero, qualcuno si commosse.
Perché capivano.
Siamo stati tutti lì. In basso. Invisibili. Chiedendoci se le parti migliori di noi serviranno ancora.
Ma a volte, il rifiuto è una reindirizzamento.
A volte, ciò che pensi ti serva—quel lavoro, quella chiamata, quell’approvazione—è solo un’esca prima che si apra la vera porta.
E a volte, il punto più basso diventa la storia che salva qualcun altro.
Qualche settimana fa abbiamo assunto un neolaureato. Nervoso, continuava a muoversi le mani in riunione. Gli chiesi se stava bene.
“Onestamente,” disse, “sento di non appartenere a questo posto. Tutti hanno esperienza. Io cerco solo di non combinare pasticci.”
Mi avvicinai e dissi:
“Lascia che ti racconti di una penna.”
Quindi sì.
Quel colloquio fallito—quello da cui uscì pensando di aver esagerato—mi ha dato tutto.
Un lavoro. Un mentore. La possibilità di aiutare altri. Anche un piccolo side hustle.
Ma soprattutto, mi ha restituito la mia voce.
Quindi se stai leggendo questo e ti senti bloccato, invisibile o indietro—non è finita. Non sei finito. Stai solo prendendo forma.
Non stai vendendo una penna. Stai vendendo la tua storia. E qualcuno là fuori ha bisogno di ascoltarla.
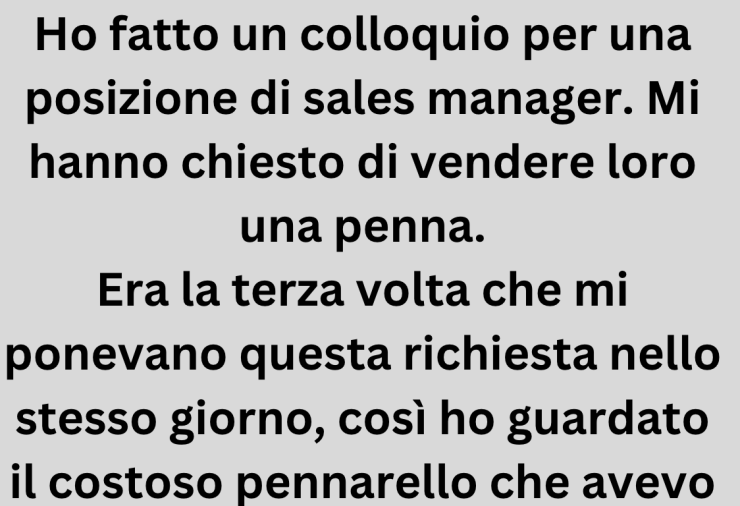
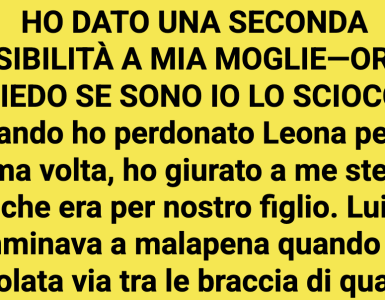


Add comment