Avevamo ristrutturato il nostro appartamento una volta, e avevamo assunto un uomo per posare le piastrelle.
Quando arrivò, mia madre ed io lo fissammo sorpresi: non aveva affatto l’aspetto di un piastrellista, né tantomeno di un operaio edile. Gli chiedemmo quale fosse la sua professione, e lui rispose con un mezzo sorriso:
«Ve lo dirò domani.»
Il giorno seguente si presentò con un thermos di caffè, una piccola radio di plastica e un libro di poesia classica in farsi. Mia madre alzò le sopracciglia; io cercai di non fissarlo troppo. Lui colse i nostri sguardi e disse con naturalezza:
«Ero professore di letteratura, a casa mia. A Teheran.»
Lo disse come se parlasse del tempo, poi si inginocchiò e iniziò a mescolare la malta con la calma di chi lo ha sempre fatto. Si chiamava Behram. Avrà avuto circa cinquant’anni, alto, dal fisico asciutto e con un volto che sembrava scolpito nella pazienza.
Per i primi giorni non sapevamo come interpretare quella rivelazione. Un professore che posa piastrelle? Qualcosa non tornava. Mia madre, che aveva un senso dell’orgoglio e dell’etichetta quasi sacro, cominciò a portargli il tè nel pomeriggio — cosa che non aveva mai fatto per nessun altro lavoratore.
Al quarto giorno, iniziò a fargli delle domande. Prima timide: cosa insegnasse, da quanto tempo vivesse qui, se gli mancasse l’Iran. E Behram rispondeva con tono pacato, a volte interrompendosi per lisciare una piastrella o pulire la malta in eccesso.
Scoprimmo che era fuggito dopo le proteste. Non disse di quale anno, solo che aveva lasciato tutto: il suo lavoro, i suoi libri, l’appartamento, persino una sorella. Viveva lì da due anni, facendo lavoretti saltuari: piastrellista, imbianchino, qualsiasi cosa pagasse in nero. Nessuna licenza, nessun documento.
Mia madre rimase in silenzio per il resto del giorno. Quella sera, mentre cenavamo, mi disse:
«Sai… tuo padre doveva diventare medico.»
Rimasi interdetta. Conoscevo quella storia, ma non con quel tono.
«Ha rinunciato, per me. Perché potessimo sposarci e lasciare Il Cairo. Era il primo della classe. Ma diceva che là non saremmo sopravvissuti.»
Annuii. Non ne parlammo più. Ma qualcosa in lei cambiò.
L’ultimo giorno di lavoro di Behram gli preparammo il pranzo: una semplice zuppa di lenticchie e pane piatto. Ma aveva il sapore di qualcosa di più profondo. Dopo mangiato, mia madre gli porse una busta e disse:
«È più di quanto avevamo pattuito, ma non è carità.»
Lui la aprì, guardò l’importo e fece solo un cenno.
Ma la storia non finì lì.
Passarono alcuni mesi. La vita andava avanti. Il bagno era perfetto. Ogni tanto mia madre lo nominava ancora, mentre piegava il bucato o mescolava qualcosa sul fornello:
«Chissà se insegna di nuovo. Aveva quella presenza, lui.»
Sei mesi dopo, bussò alla porta.
La stessa calma nel volto, ma stavolta con una cartellina e un sorriso un po’ nervoso. Mia madre lo accolse come si accoglie un parente tornato da lontano.
«Sto studiando per una certificazione al college,» disse. «Per insegnare agli adulti — inglese e alfabetizzazione, perlopiù. Ma chiedono una lettera di referenza, da qualcuno che mi abbia visto lavorare.»
Mia madre non esitò. Quella sera stessa scrisse la lettera, la stampò e aggiunse pure il nostro numero, nel caso volessero verificare. Due settimane dopo, lui chiamò per dire che era stato accettato.
Poi non lo sentimmo più per un po’.
Il vero colpo di scena arrivò quasi un anno dopo, quando mia madre si ammalò.
Cominciò a perdere l’equilibrio. Disse che era solo vertigine. Poi arrivarono i tremori alle mani. Alla fine non riusciva più a tenere bene una penna. I medici fecero gli esami: Parkinson, stadio iniziale.
Mia madre lo affrontò come solo le madri sanno fare — con una rabbia silenziosa. Mi impedì di cancellare un viaggio in Marocco, insistendo che poteva cavarsela. Così le prenotai un’assistenza part-time: due volte a settimana, qualcuno che la aiutasse con la spesa e le faccende.
Il primo giorno dell’assistente, ero in videochiamata. Mia madre mi mostrò lo schermo e disse:
«Indovina chi è?»
Strizzai gli occhi. Era Behram.
A quanto pare, il centro comunitario dove aveva iniziato a insegnare gestiva anche programmi di assistenza per anziani, perlopiù volontari. Quando vide il nome di mia madre nella lista, chiese di essere assegnato a lei. Disse che le doveva qualcosa.
Ma non si limitava ad aiutarla: portava di nuovo libri di poesia, le leggeva versi mentre lei riposava, prendevano il tè e discutevano sulle traduzioni. Le insegnò perfino qualche frase in farsi, che lei adorava.
Quando tornai, trovai mia madre — con le mani tremanti — che recitava Hafez come se lo avesse sempre conosciuto.
Un pomeriggio restai in cucina ad ascoltarli ridere in salotto. Era una risata piena, profonda, che non sentivo da prima che mio padre morisse.
Quando Behram se ne andò, mia madre mi guardò e disse:
«Mi ricorda come suona la dignità.»
Non trovai parole.
Un mese dopo, Behram portò con sé una ragazza, Niloufar — sua figlia. Non ne aveva mai parlato prima. Era appena arrivata dalla Turchia, dopo due anni di pratiche e attese. Dolce ma brillante, voleva studiare ingegneria biomedica.
Chiese a mia madre se Niloufar potesse stare con lei qualche volta, “per praticare l’inglese”, disse. Ma credo volesse mostrarle cosa fosse la forza.
E funzionò in entrambe le direzioni. Mia madre si illuminava quando c’era lei. Facevano cruciverba, leggevano articoli di giornale, guardavano vecchi film in bianco e nero.
Cominciò a scrivermi meno dei sintomi e più delle “vittorie di vocabolario di Niloufar”.
Un giorno le trovai in cucina a preparare dolci persiani, con i grembiuli addosso e una discussione accesa sulla noce moscata. Mi si sciolse il cuore.
Behram continuava a lavorare, a insegnare part-time, a tradurre documenti. Piano piano, la sua vita sembrava ricomporsi.
Niloufar ottenne una borsa di studio, piccola ma sufficiente. Prima il community college, poi un programma di trasferimento. Behram si commosse nel raccontarcelo; mia madre lo abbracciò e disse:
«Ma certo. È la figlia di suo padre.»
Poi arrivò la vera sorpresa.
A Natale, Behram consegnò a mia madre una busta spessa. Dentro, una lettera del Centro di Formazione per Adulti: era stato assunto a tempo pieno. Con benefits, pensione, una classe tutta sua.
Mia madre pianse. Non un pianto drammatico — solo lacrime che scivolavano tranquille, mentre teneva quella lettera come fosse sacra.
«Ecco cos’è la giustizia,» sussurrò.
Morì la primavera successiva.
Fu una fine serena. La malattia era avanzata in fretta, ma facemmo in modo che fosse comoda. Behram veniva spesso. Niloufar quasi ogni giorno.
Al funerale, vidi più di venti persone del centro comunitario. Behram aveva parlato di lei. Disse che era “una donna che non chiedeva cosa fossi stato, ma chi scegliessi di essere ora.”
Niloufar mi consegnò un biglietto piegato, scritto da mia madre. C’erano solo due righe:
«Non sai mai chi stai aiutando, quando mostri un po’ di rispetto. Continua a farlo.»
Lo porto ancora nel portafoglio.
Sono passati alcuni anni. Niloufar ha terminato la laurea triennale. Sta facendo domanda per il master, con lettere di raccomandazione dei professori — incluso Behram, che ora dirige un programma di tutoraggio per nuovi immigrati.
Io e lui ci vediamo ancora una volta al mese, per il tè. È diventata una tradizione.
Alcune persone entrano nella tua vita solo per svolgere un lavoro. Posare piastrelle, riparare un tubo, pulire una stanza.
Ma altre arrivano con una luce silenziosa, e prima che tu te ne accorga, hanno cambiato tutta l’atmosfera.
Se mi chiedi cosa ricordo di più di quella ristrutturazione, non sono le piastrelle.
È che mia madre incontrò qualcuno che le ricordò quanta grazia esiste ancora nel mondo.
E in cambio, lei gli ricordò che il valore di una persona non svanisce solo perché sta cercando di sopravvivere.
Sì, credo nel karma. Nelle seconde possibilità. Nella giustizia poetica.
E credo che una casa non si costruisca solo con i muri, ma con momenti come questi.
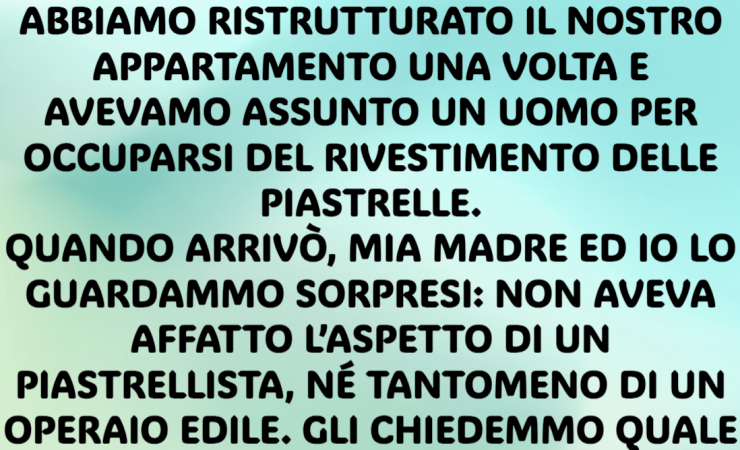


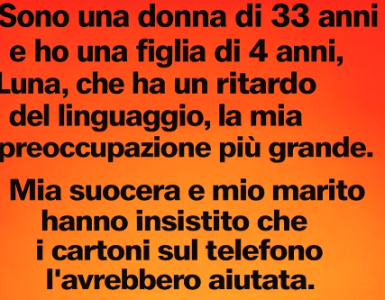
Add comment