Doveva essere una gita breve: solo io e mio cugino Ryan. Aveva preso la licenza di pilota l’anno scorso e comprato un vecchio aereo da un tipo di Anchorage che “gli doveva un favore”. Diceva spesso cose del genere—vaghe, ambigue, che non tornavano mai del tutto.
Sono salito a trovarlo con uno zaino leggero e senza alcuna idea precisa di cosa avremmo fatto. “Atterreremo su un letto di fiume, pescheremo, ci rilasseremo e lunedì saremo di ritorno,” mi aveva detto, lanciandomi una Red Bull come se avessimo ancora diciassette anni. Questo succedeva due settimane fa.
Ora sono seduto su ghiaia fredda, con il telefono scarico, e ho contato almeno tre zaini diversi con vestiti da donna all’interno—nessuno dei quali mi appartiene. Quando ho chiesto a Ryan di chi fossero, ha risposto: “Ah, roba rimasta dall’estate scorsa.”
Ma qualcosa non quadrava. Innanzitutto, Ryan non era nemmeno venuto qui l’estate scorsa. Me lo ricordavo bene: era rimasto a casa, al verde, a dormire sul divano di sua madre e a lamentarsi per il costo del carburante. E poi, quei vestiti non sembravano affatto “vecchi”. Non erano logori né ammuffiti. Sembravano recenti—piegati con cura, come se qualcuno li avesse messi lì da poco.
Quella notte ho cercato di non pensarci. La natura selvaggia ha già di per sé il potere di renderti paranoico: ogni ramo che si spezza sembra un orso, ogni folata di vento qualcuno che ti si avvicina di nascosto. Ma poi, rovistando in uno degli zaini alla ricerca di una torcia, ho trovato una fotografia.
Era una Polaroid. E mi ha gelato il sangue.
C’ero io. Seduto dentro una tenda che non avevo mai visto, con un sorriso forzato come se qualcuno mi avesse appena detto “sorridi!”. Indossavo la stessa giacca che avevo addosso in quel momento. Ero pettinato allo stesso modo di due settimane prima. Ma quella tenda? Non c’ero mai stato. Ne ero certo.
Mi si è gelato lo stomaco. Il primo pensiero è stato che Ryan avesse scattato la foto per farmi uno scherzo. Il suo senso dell’umorismo era sempre stato un po’ contorto. Ma più fissavo l’immagine, più dentro di me qualcosa sussurrava che non si trattava di uno scherzo.
La mattina dopo l’ho affrontato. Ho cercato di sembrare tranquillo, tenendo la Polaroid come se non fosse nulla di importante. “Ehi, quando hai scattato questa?” ho chiesto.
L’ha guardata mezzo secondo, poi ha scrollato le spalle. “Probabilmente l’ultima volta che siamo stati qui.”
“Ma io non c’ero, qui,” ho risposto. La voce mi si è incrinata un po’, perché all’improvviso non ero più sicuro di nulla.
Ryan si è sistemato un amo sulla visiera del cappello e ha sorriso. “Ci sei stato, cugino. Magari te ne sei solo dimenticato.”
Dimenticato? Come si fa a dimenticare un’intera escursione?
Ho insistito, ho cercato di farlo parlare, ma continuava a rispondere con quei sorrisi ambigui. Quei sorrisi che possono voler dire due cose: o ti stanno mentendo o stanno cercando di tranquillizzarti. O entrambe.
Da quel giorno, tutto ha cominciato a crollare. Ho iniziato a notare dettagli strani: come Ryan mi allontanava sempre da certe zone del campo, come si agitava quando mi allontanavo troppo, come c’erano tracce vicino al fiume che non sembravano le nostre.
Una sera, mentre lui stava pulendo dei pesci, mi sono allontanato di nascosto. Ho seguito le tracce attraverso la vegetazione fino a scoprire qualcosa che non avrei mai dovuto vedere.
Un altro accampamento. Nascosto.
Era spartano, solo un telo appeso tra due alberi, ma all’interno c’erano altri vestiti, resti di cibo e un quaderno. Le mani mi tremavano mentre lo aprivo. Nella prima pagina c’erano nomi scritti alla rinfusa—nomi e cognomi, iniziali. Alcuni avevano delle date accanto. Altri una “X”.
A metà pagina, ho visto il mio nome. Per intero. Con la data di quel giorno accanto.
Ho lasciato cadere il quaderno come se scottasse. Il primo impulso è stato fuggire, ma poi ho sentito dei rami spezzarsi alle mie spalle. Ryan. La sua voce è arrivata secca tra gli alberi. “Non dovevi vederlo.”
Mi sono girato di scatto, il cuore impazzito, e per un attimo ho pensato che mi avrebbe aggredito. Invece si è fermato, la mascella serrata.
“Cos’è questa roba?” ho chiesto.
Non ha risposto subito. Alla fine ha mormorato: “Non capiresti.”
“Prova a spiegarmelo,” ho detto, ma la voce mi tremava.
Ha sospirato, passandosi una mano sul viso. “Non è quello che pensi. È solo che… a volte qui arriva gente. Persa, in fuga da qualcosa, non lo so. Io tengo traccia. Tutto qui.”
“E perché c’era il mio nome?”
Ryan non ha battuto ciglio. Mi ha guardato con un’espressione a metà tra la compassione e l’avvertimento. “Perché, prima o poi, tutti dimenticano.”
Quella notte ho dormito pochissimo. Continuavo a ripetermi quelle parole nella testa: “tutti dimenticano, prima o poi.” Cosa diavolo significava?
La mattina dopo mi sono svegliato e Ryan era già vicino all’aereo, intento a fare rifornimento. “Torniamo indietro,” ha detto freddamente.
Non ho protestato. Ho preso lo zaino e sono salito a bordo, le mani sudate al punto che ho rischiato di far cadere la fibbia.
Il volo di ritorno è sembrato interminabile. Mi aspettavo che si voltasse, che dicesse qualcosa, che spiegasse. Invece ha volato in silenzio, con lo sguardo fisso sull’orizzonte.
Quando siamo atterrati sulla pista sterrata vicino ad Anchorage, sono praticamente saltato giù ancora prima che l’aereo si fermasse del tutto. Gli ho detto che l’avrei chiamato più tardi, ma lui ha solo annuito, come se sapesse che non l’avrei fatto.
Per giorni non sono riuscito a scrollarmi di dosso quella sensazione. La foto. Il quaderno. Il mio nome con la data di quel giorno. Era come se fossi entrato in una versione della mia vita che non mi apparteneva.
Poi è arrivata la vera svolta.
Una settimana dopo, mentre svuotavo la valigia, ho trovato qualcosa nella tasca della giacca. Un’altra Polaroid.
Questa volta, non c’ero solo io nella foto. C’era anche Ryan. Entrambi seduti in quella stessa tenda che non avevo mai visto. E dietro di noi, sfocata ma riconoscibile, una terza figura. Una donna.
La stessa donna a cui appartenevano i vestiti negli zaini.
Sono rimasto pietrificato, fissando la foto fino a vedere sfocato. Le mani mi tremavano così tanto che l’ho fatta cadere a terra.
E in quel momento ho capito: non stavo dimenticando nulla. Stava succedendo qualcos’altro. Qualcosa che Ryan non mi aveva raccontato.
Non sono più tornato da lui. Ma ogni tanto, ancora oggi, ho la sensazione che troverò altre Polaroid nascoste tra le mie cose. E quando succede, mi chiedo se riconoscerò i luoghi in cui sono state scattate.
A volte, mi chiedo perfino se riconoscerò me stesso.
C’è una cosa, però, che ho imparato. Il mondo è pieno di segreti. E a volte, anche le persone più vicine a noi portano verità che non siamo pronti ad ascoltare. Ma per quanto sia inquietante, non si può distogliere lo sguardo. Non si possono ignorare i segnali solo perché fanno paura.
Ancora oggi non so cosa stesse facendo davvero Ryan in quei boschi, né perché il mio nome fosse su quel quaderno. Ma so una cosa: fidati del tuo istinto. Se qualcosa ti sembra sbagliata, probabilmente lo è. E a volte, la cosa più spaventosa non è ciò che non sai—ma ciò che quasi riesci a convincerti a dimenticare.
E se anche tu hai vissuto un momento in cui il tuo istinto ti diceva una cosa mentre il mondo cercava di convincerti del contrario, mi piacerebbe conoscere la tua storia. Condividila. Perché a volte, parlare è l’unico modo per ricordarci che non siamo pazzi, dopotutto.
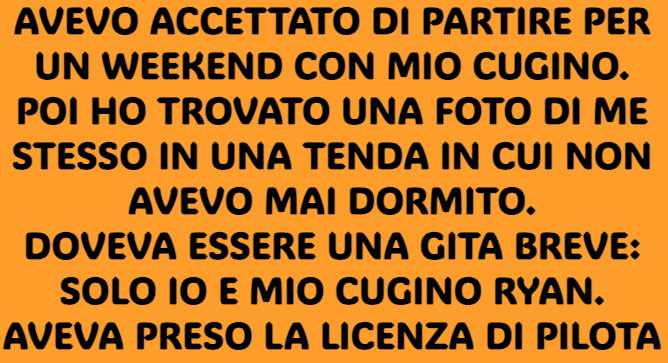



Add comment