La gente continua a ripetere che avere bambini sia la cosa più bella. Io annuisco, spingendo il bimbo avanti e indietro sull’altalena. Dentro però non sento allegria. Penso alle amiche sole, libere, e qualcosa si stringe nello stomaco. Quando cala il buio, immagino di riempire una valigia. Nessuno sa dove vado. Il treno parte. La città svanisce
Chiamarmi Elena è solo l’inizio. A trentaquattro anni, giro tra pannolini e caffè freddo sul tavolo della cucina. Due figli mi riempiono le giornate: uno che corre ovunque, l’altro che chiede sempre perché. Stanno bene, parlano senza fermarsi, ridono forte. La gente pensa che sia tutto semplice, naturale.
Invece ogni gesto sembra scelto al microscopio. Impasto dolci mentre canto canzoni assurde, nascondo indizi per giochi complicati, cambio voce quando apro un libro illustrato. Su Instagram posto le foto dei nostri weekend con didascalie tipo: “La mia ragione di vita”, “Cuore di mamma”. Le mie amiche single mi dicono: “Beata te, Elena, hai creato una famiglia stupenda, io mi sento così sola”.
A volte vorrei cambiarmi con loro senza pensarci due volte. Tornare a quei giorni prima che tutto cambiasse mi sembra l’unica via d’uscita. I miei bambini significano il mondo, chiaro. Proteggerli da chiunque provasse a far loro male sarebbe istintivo come respirare. Eppure questo ruolo non fa per me. Stancano le richieste continue, lo sforzo mai concluso. Sempre quel frastuono intorno, senza un attimo di tregua, dall’alba fino a quando cala il buio. Più niente è come prima, ora mi chiamano soltanto Mamma, mentre Elena, colei che disegnava palazzi e girava il mondo con Dostoevskij tra le mani, sembra sparita nel vento.
Pulisco pannolini, spezzo bocconcini minuscoli, canticchio motivi stonati di serie animate come se fossero preghiere quotidiane. Il nome sul biglietto da visita? Rimasto in un cassetto polveroso, sotto vecchie fotografie sbiadite. A volte vorrei urlare, altre invece resto zitta, fissando il vuoto oltre la finestra della cucina. Chi ero una volta pare lontana anni luce, cancellata dai panni sporchi ammucchiati sulla sedia. Nessuno domanda dell’architettura o delle mie letture notturne.
Solo richieste continue: latte versato, scarpe perse, giochi sparsi ovunque. Mi riconoscono per quello che faccio, mai per chi sono stata davvero. La voce dentro si affoga nei suoni ripetitivi del microonde che segna tre minuti ogni due ore.
A volte il peso sembra quasi dolce. Non è il denaro a tenermi qui, bensì le piccole cose: una mano che cerca la tua al buio, certe canzoni cantate stonate in cucina. Quando Chiara parla di treni presi senza biglietto di ritorno, resto zitta. Sorrido come se dentro non ci fosse un vuoto crescente. Le risposte pronte sulle labbra, tipo quanto sia fortunata ad avere qualcuno che dipende da me. La verità? Pagherei per sparire una settimana. Senza spiegazioni. Anche solo per vedere se qualcuno si accorge che manco.
L’affetto qua attorno assomiglia a una rete morbida, certo, però stringe lo stesso. Dentro di me urlo: “Non sai quanto sei fortunata! Non sai cosa darei per avere il tuo silenzio, il tuo tempo vuoto!”.
Quello che mi trasforma in qualcosa di mostruoso è sognare la fuga. A volte, mentre sono seduta su una panchina e i bambini corrono là fuori, penso a me stessa in piedi. Poi vedo le mie gambe muoversi verso l’uscita del parco. Fuori dal cancello.
Dentro la macchina. Il motore acceso. La strada davanti senza indirizzo fisso. Oltrepassare il confine. Un nuovo cognome. Una vita nuova. In un posto dove non devo rispondere a quel nome: mamma. A un tratto tutto appare vero, come se non fosse soltanto un pensiero. Poi qualcuno dei due si lascia andare a terra, comincia a singhiozzare, grida forte il nome di sua madre – e in quel momento svanisce ogni illusione. Vado verso di lui senza pensarci, gli parlo piano, gli sfioro la fronte con le labbra.
Le mie mani fanno quello che devono fare, movimenti ripetuti mille volte, mentre invece dentro sono lontana, chiusa in quella camera inventata dove nessun rumore arriva. Lo so, non me ne andrò mai. Responsabilità addosso, come un respiro che non smette. Fino in fondo porterò questo peso, senza voltarmi. Curerò loro, aprirò libri insieme, starò lì mentre crescono. Eppure sento: quel che ero prima è svanito quando il primo ha aperto gli occhi.
Adesso ogni gesto gira intorno a due vite arrivate senza permesso, e che piano piano hanno mangiato la mia.
Sono Elena. Ho trentaquattro anni. Crescere bambini mi riempie il cuore, certo, però ogni tanto penso a come sarebbe stato vivere senza pannolini né sveglie alle cinque del mattino. Immagino me stessa con un bicchiere di vino sul divano di casa mia, tranquilla, mentre fuori scende la neve. A Natale arriverei con pacchetti colorati, risate e zero responsabilità. Poi via, porta chiusa alle spalle, niente tracce, nessun disordine da sistemare dopo.

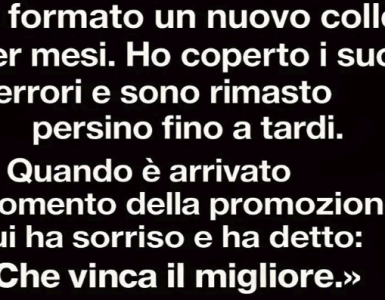


Add comment