Mi presento: sono Marco. Quarantatré primavere sulle spalle.
Solo adesso realizzo una cosa strana.
Per metà della mia vita ho riversato rabbia addosso a chi, invece, non faceva altro che proteggermi. L’unica anima capace di restare mentre la respingevo ogni giorno. Persino nell’odio trovava un modo per tenermi vivo.
Solo ora ho terminato di portar via le cose dall’appartamento di mia sorella Elena. Un locale piccolo, venti metri quadrati giusti, in una zona fuori mano a Torino. L’odore là dentro non va via: tabacco vecchio, silenzio pesante.
Elena non c’è più da tre giorni. La macchina si è infilata nel guardrail mentre tornava dopo il terzo giorno lavorativo uno dietro l’altro. Faceva turni lunghi in un deposito, tra pacchi e corsie vuote.
Quel giorno al cimitero c’eravamo solo noi tre, più un amico di famiglia. A me sembrava inutile partecipare.
Per tanto tempo ho usato quel soprannome: la vigliacca. Lo dicevo tra i bicchieri del cenone quando nessuno ne parlava. Usavo quella parola fissando il vuoto dove avrebbe dovuto esserci lei.
Mia madre spariva piano, inghiottita da qualcosa che i dottori sapevano spiegare ma non curare. Restavo soltanto io accanto al suo letto. Lavavo le lenzuola sporche. Firmavo documenti con mani tremanti. Rinunciavo a progetti mentre gli altri vivevano normalmente.
«Elena se n’è andata a farsi la sua vita» dicevo a tutti.
«È scappata dalle responsabilità, ci ha abbandonati nel fango per rincorrere la sua libertà».
Circa sessanta minuti fa mi sono imbattuto in una vecchia scatola da scarpe, nascosta sotto il letto disordinato. Dentro non c’erano anelli, né foto di vacanze lontane, nulla che parlasse di agiatezza.
Solo bollette d’invio stipendio. Una quantità sconvolgente. Ognuna datata, regolare, dall’inizio del 2011 fino a ieri.
Leggevo, e le forze mi abbandonavano.
Non risultavo io sui bonifici, bensì una clinica svizzera. Il nome lo conoscevo bene: era l’ospedale che dava a mia madre quei farmaci fuori registro, quelli mai autorizzati dal servizio sanitario.
Secondo i dottori, proprio quei trattamenti le avevano lasciato altri dieci anni. Dieci anni interi trascorsi ridendo insieme, davanti ai film d’epoca, parlando senza fine.
Pensavo quei medicinali fossero arrivati per caso, tra carte e regole. Mi sembrava di aver beccato la sorte giusta quel giorno.
Invece non era affatto fortuna.
Dietro c’era soltanto Elena.
C’era anche un quaderno minuscolo.
Solo qualche frase, tracciata da una mano incerta, provata:
*«Lui oggi mi ha scritto parole pesanti. Mi chiama mostro perché non sono riuscita ad arrivare alla festa per la mamma. Senza quel lavoro extra dopo cena, avrei dovuto rinunciare al viaggio in treno. Quando sbaglio un turno, salta l’affitto del mese dopo.
Preferisco essere vista male, basta che lei riesca ad alzare ancora il petto. Se conoscesse il prezzo di ogni fiato, lascerebbe perdere quel senso di colpa verso gli altri. E invece devo sperare che combatta.»*
Quella camera vuota l’ho guardata bene. Le sue scarpe, rotte sotto, le ho notate subito.
Non era fuggita per cercare fortuna, mia sorella. Aveva accettato giornate pesanti, nessuno vicino, fame vera, solo per coprire gli anni in cui stavo io con mamma.
Lei ha accettato di essere il cattivo della storia.
Ha accettato i miei sputi, il mio disprezzo, il mio silenzio punitivo, pur di non dirmi:
«Marco, sto morendo di fatica per permetterti di stare vicino a lei, perché so che tu sei quello fragile, quello che non sopporterebbe di vederla morire subito».
Mentre io giocavo al salvatore tra queste pareti, lei combatteva nel fango portando sacchi sulle spalle. Nel momento in cui accoglievo carezze da mia madre, io le scaricavo addosso parole piene di spine.
Adesso che non è altro che polvere chiusa dentro vetro, resto immobile fra stanze vuote che gridano il suo nome. Ho un cartone tra le mani, così pesante da piegare anche il granito dei morti.
Chiamarmi Marco è facile. Quarantatré primavere addosso, nessun vanto.
Per anni ho puntato il dito contro qualcosa di sacro, convinto fosse errore. Solo adesso fiuto quell’aria rara: non profumo dolce di chiesa, ma celle senza calore e un respiro trattenuto, per impedire che il mio si rompa del tutto.
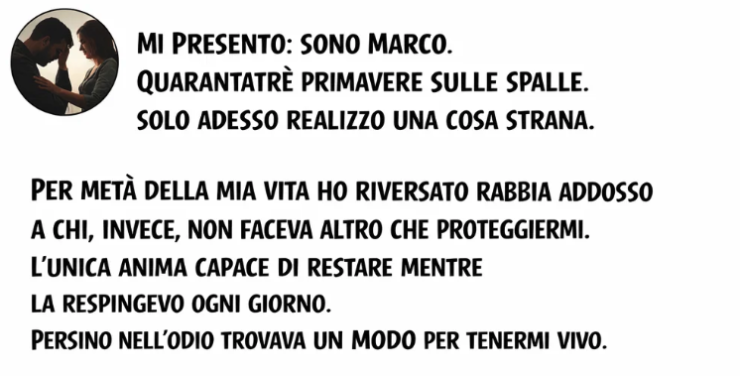



Add comment