Allarme fake news sulla salute, 8 milioni di italiani vittime di bufale
49 milioni di italiani soffrono di piccoli disturbi (dal mal di testa al raffreddore), di cui 17 milioni con grande frequenza: un enorme fabbisogno sanitario che, senza il ricorso ai farmaci da banco, finirebbe per scaricarsi sul Servizio sanitario nazionale. Per l’automedicazione spendiamo il 39% in meno della media degli altri grandi Paesi europei. Ma servono una comunicazione corretta e l’educazione alle scelte di salute.
Allarme fake news in sanità. Sono 15 milioni gli italiani che, in caso di piccoli disturbi (dal mal di testa al raffreddore), cercano informazioni sul web. Ma 8,8 milioni sono stati vittime di fake news nel corso dell’anno. In particolare, sono 3,5 milioni i genitori che si sono imbattuti in indicazioni mediche sbagliate. Dati allarmanti per la salute: se il medico di medicina generale (53,5%) e il farmacista (32,2%) restano le principali fonti di informazione, decolla il ricorso ai diversi canali web (28,4%). Il 17% degli italiani consulta siti web generici sulla salute, il 6% i siti istituzionali, il 2,4% i social network. In particolare, tra i millennials sale al 36,9% la quota di chi usa autonomamente il web per trovare informazioni su come curare i piccoli disturbi. Il pericolo è fortemente percepito dagli italiani: il 69% vorrebbe trovare sui siti web e sui social network informazioni certificate sulle piccole patologie e sui farmaci per curarle da assumere senza obbligo della ricetta medica. È quanto emerge da una ricerca del Censis realizzata in collaborazione con Assosalute e presentata oggi a Roma. Una comunicazione corretta e l’educazione alle scelte di salute emergono come elementi fondamentali per un pieno riconoscimento dei benefici individuali e collettivi dei medicinali di automedicazione.
I piccoli disturbi della salute che peggiorano la vita degli italiani. Complessivamente, sono 49 milioni gli italiani che soffrono di piccoli disturbi che ne compromettono la piena funzionalità quotidiana nelle relazioni sociali e sul lavoro. Di questi, 17 milioni soffrono con grande frequenza di piccoli disturbi che incidono pesantemente sulla loro vita. Quelli più diffusi sono il mal di schiena (40,2%), raffreddore, tosse, mal di gola e problemi respiratori (36,5%), il mal di testa (25,9%), mal di stomaco, gastrite, problemi digestivi (15,7%), l’influenza (13,9%), i problemi intestinali (13,2%). Rispetto a dieci anni fa, sono aumentate le persone alle prese con il mal di schiena e i dolori muscolari (dal 32,4% al 40,2% degli italiani), raffreddore, tosse, mal di gola (dal 34,7% al 36,5%), mal di stomaco e gastrite (dal 12,4% al 15,7%), problemi intestinali (dal 5,1% al 13,2%) e congiuntiviti (dall’1,5% al 3%). Sono numeri che descrivono un enorme fabbisogno sanitario che, senza il ricorso ai farmaci da banco, finirebbe per scaricarsi su un Servizio sanitario nazionale già in difficoltà.
Aumenta la tendenza all’automedicazione. Il 73,4% degli italiani è convinto che in caso di piccoli disturbi ci si possa curare da soli. La percentuale è aumentata nel tempo, visto che nel 2007 era pari al 64,1%. Per il 56,5% ci si può curare da sé perché ognuno conosce i propri piccoli disturbi e le risposte adeguate, per il 16,9% perché è il modo più rapido.
Ma nel rispetto dei consigli di medici e farmacisti. Si curano da soli con farmaci da banco, senza bisogno della ricetta medica, 46 milioni di italiani. Di questi, 15 milioni lo fanno spesso. Il ricorso al farmaco è informato, consapevole e maturo. La prima volta che si assume un farmaco senza obbligo di ricetta per curare un piccolo disturbo, il 70,4% degli italiani chiede consiglio al medico o al farmacista, l’83,1% legge sempre il foglietto illustrativo e il 68,4% afferma di comprenderlo appieno. Trascorsi alcuni giorni dall’assunzione del farmaco, se il disturbo persiste l’88,5% si rivolge al medico e il 36,2% al farmacista. L’automedicazione con i farmaci da banco non è mai uno sregolato libero arbitrio soggettivo, si fonda sempre su indicazioni mediche. E gli italiani non usano i farmaci come semplici beni di consumo: la spesa pro-capite per farmaci senza obbligo di prescrizione in Italia è pari in media a 40,2 euro all’anno, nel Regno Unito sale a 69,6 euro, in Germania a 80,1 euro, in Francia a 83,1 euro e il valore pro-capite medio tra i grandi Paesi europei è di 65,7 euro. Gli italiani spendono per i farmaci senza obbligo di ricetta il 39% in meno della media degli altri grandi Paesi europei.
I vantaggi dell’autocura. Sono molteplici i benefici del ricorso ai farmaci senza obbligo di ricetta per guarire dai piccoli disturbi. Benefici per i malati, perché 17,6 milioni di italiani sono guariti dai piccoli disturbi grazie a un farmaco da automedicazione almeno in una occasione durante l’anno e così hanno potuto svolgere normalmente le loro attività. Per il Servizio sanitario nazionale, perché 17 milioni di italiani hanno evitato di scaricare l’onere delle cure sul sistema pubblico grazie ai farmaci da banco. Per l’economia, perché 15,4 milioni di lavoratori sono rimasti sul posto di lavoro proprio grazie all’effetto di un farmaco da automedicazione.
Questi sono i principali risultati della ricerca del Censis: «Il valore socio-economico dell’automedicazione», realizzata in collaborazione con Assosalute (Associazione nazionale farmaci di automedicazione, che fa parte di Federchimica), che è stata presentata oggi a Roma da Francesco Maietta, Responsabile dell’Area Politiche sociali del Censis, e discussa da Maurizio Chirieleison, Presidente di Assosalute, Stefano Vella, Presidente dell’Aifa, Marco Cossolo, Presidente di Federfarma, Paolo Misericordia, Responsabile nazionale del Centro Studi della Fimmg, Antonio Gaudioso, Segretario Generale di Cittadinanzattiva, Francesco Brancati, Presidente di Unamsi, e Massimiliano Valerii, Direttore Generale del Censis.
Alcune premesse di carattere metodologico
Prima di affrontare il dibattito sulla liceità delle fake news e sull’opportunità per il legislatore – italiano ed europeo – di intervenire in questo terreno, pare utile muovere da un’osservazione preliminare, che riguarda lo statuto giuridico delle notizie “false” in sé considerate.
Invero, all’interno del testo della Costituzione e delle disposizioni, specialmente di diritto penale, dedicate all’esercizio della libertà di parola, non sembrano rinvenirsi indicazioni che depongano per una collocazione del falso nell’alveo del giuridicamente illecito. Paolo Barile, maestro anche del diritto dell’informazione, più di trent’anni fa sottolineava come «neppure la diffusione di notizie false può essere considerata illecita in sé e per sé»; infatti, «il “fine d’inganno” può essere illecito solo in quanto costituisca il fulcro di un’attività illecita che contrasti con altri principi costituzionali». Nella medesima logica, anche le disposizioni incriminatrici vigenti che puniscono una condotta consistente nella circolazione di informazioni non veritiere, invero, non colpiscono tale comportamento in sé, ma lo ammantano di rilevanza penale nella misura in cui, per esempio, provochi allarme sociale o nocumento all’ordine pubblico. Analoga è la ratio che fa prevalere i diritti della personalità (onore, reputazione, identità personale, dignità) nel conflitto con il diritto di cronaca, qualora quanto narrato non corrisponda al vero.
Si ritiene, dunque, opportuno percorrere una scelta di metodo, ovvero l’adesione alla c.d. “teoria del bene giuridico costituzionalmente protetto”, che reprime comportamenti illeciti in ragione dell’idoneità a pregiudicare un bene di rilievo costituzionale che l’ordinamento vuole tutelare. Già aderendo a questa posizione è possibile discostarsi da quelle ricostruzioni che assumono, al contrario, una concezione del falso come elemento in sé illecito e generativo di responsabilità in capo a chi lo dissemini: in questa direzione appare muoversi senza particolari freni il disegno di legge Gambaro a cui si è accennato.
Si deve, poi, svolgere un’ulteriore fondamentale premessa, che si lega all’osservazione dei mutamenti che si sono prodotti nell’ambito del settore dell’informazione.
L’evoluzione digitale ha provocato importanti trasformazioni, realizzando una disintermediazione rispetto agli operatori dell’informazione che, in precedenza, potevano vantare una sorta di oligopolio nella creazione e diffusione di notizie. Del resto, già in precedenza l’invenzione della stampa aveva allargato l’ambito dei soggetti in condizione di esercitare, con la scrittura, il proprio diritto di parola e fenomeni analoghi si sono verificati alla nascita di ogni ulteriore mezzo di comunicazione. I nuovi media estendono ulteriormente la cerchia dei soggetti, addivenendo a un riconoscimento pressoché universalistico del «diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione», che induce a marginalizzare, almeno in parte, il ruolo degli operatori professionali dell’informazione cui era affidato, in precedenza, il controllo delle notizie (laddove per controllo si intende la produzione, l’accertamento, la verifica e tutte le attività complementari e collegate).
L’abbattimento dei costi e la relativa facilità con la quale chiunque può oggi attivare un sito Internet e condividerne i contenuti hanno determinato una apertura pressoché incondizionata, in cui ciascun utente, un tempo mero ricettore di informazioni, può divenirne oggi produttore, pur non disponendo del bagaglio di competenza e di esperienza che dovrebbe essere proprio di un giornalista professionista.
Queste trasformazioni sollecitano l’esigenza di riflettere sulla persistente attualità dei principi e delle regole di derivazione liberale ovvero sulla necessità di rivisitare alcuni punti fermi e consolidati per reagire allo sviluppo e alla diffusione sul web di un fenomeno profondamente diverso da quelli finora conosciuti.
In altri termini, occorre interrogarsi se le differenze tra media tradizionali e nuovi media siano così profonde da pretendere l’elaborazione non solo di nuove norme puntuali ma addirittura di nuovi paradigmi.
L’impressione è che, a discapito della recente attualità del dibattito sulle fake news, le radici del problema siano antiche e che le questioni specifiche da affrontare non cosìnuove, a fronte di un mezzo (Internet) che esiste da venti anni e uno strumento (i social network) che conosce una diffusione decennale.
Fake news: un tentativo definitorio
Un altro fattore di cruciale importanza, per depurare il dibattito da possibili fraintendimenti, riguarda la definizione del perimetro delle fake news. Esistono infatti diversi tentativi di concettualizzazione di questa categoria, mediante l’astrazione di caratteristiche comuni che la rendono predica bile rispetto a un ambito più o meno ampio di contenuti veicolati sul web.
Riteniamo corretto muovere da un dato empirico, ossia la falsità delle notizie. Per fake news si dovrebbero intendere senz’altro le notizie false, le menzogne. Si tratta di un fenomeno che precede senz’altro lo sviluppo di Internet e delle nuove tecnologie, ma che da questi sviluppi ha derivato una più marcata rilevanza nel dibattito pubblico: nell’epoca della post-verità, infatti, non esistono più esperti di indiscussa autorevolezza (a prescindere dal rispettivo campo di competenza ed esperienza) e le emozioni, le pulsioni e i desideri, anche in conseguenza delle dinamiche di polarizzazione ben descritte da Cass Sunstein, finiscono per prevalere o comunque occupare un posto non meno importante dei meri fatti. In questo scenario, una possibile tassonomia delle fake news propone di distinguere tre categorie di contenuti.
La prima categoria comprende le falsità costruite ad arte da gruppi di potere, talvolta dagli stessi governi stranieri (specialmente di Stati la cui tenuta democratica pare vacillare). Queste notizie sono create e diffuse deliberatamente con l’obiettivo di modificare l’agenda pubblica, manipolando l’informazione e la formazione dell’opinione pubblica anche tramite il ricorso all’utilizzo di tecnologie sofisticate (compreso l’utilizzo di account coordinati o gestiti da robot che funzionano in base ad algoritmi): a riguardo di questa tipologia, il saggio di Franco Pizzetti compreso in questa sezione monografica illustra dettagliatamente le modalità operazionali della disinformazione e le relative criticità connesse. Quale risposta rispetto a questa categoria di fake news? La reazione più opportuna appare la previsione di obblighi di trasparenza e di identificazione della fonte di provenienza, cui dovrebbe correlarsi la possibilità di isolare e segnalare le notizie generate artificialmente tramite robot. In quest’ottica, a essere colpita non è tanto la categoria delle fake news in quanto tali, bensì la fonte di produzione delle medesime, vale a dire gli account deliberatamente creati e funzionali alla diffusione di notizie false.
Una seconda categoria di un’ipotetica tassonomia comprende le notizie false o di dubbia autenticità che circolano in rete suffragate dalla condivisione tra utenti (la vox populi). Può trattarsi di innocuo chiacchiericcio ma anche di contenuti che inducono a comportamenti poco provveduti: l’esempio classico è dato dalla ricorrente affermazione secondo cui i vaccini andrebbero contrastati in quanto espressione del potere di mercato delle imprese farmaceutiche. Queste notizie non incontrano specifici divieti, almeno in via generale, nel mondo “della materia”. Questione aperta è se le caratteristiche proprie di Internet debbano indurre a una diversa risposta e all’elaborazione di regole nuove, in ragione del maggior carattere diffusivo della rete. Resta comunque che nella nostra organizzazione sociale, lo Stato fornisce l’istruzione, educa al senso critico e promette una informazione obiettiva attraverso il servizio pubblico e plurale attraverso il sistema dei media, cartaceo, audiovisivo e digitale. Se poi la profilassi delle malattie di un figlio viene attuata sulla base delle opinioni ascoltate in una piazza, reale o virtuale che sia, forse non tutte le responsabilità sono da attribuirsi alla rete…
Da ultimo, la terza categoria include tutte le notizie false che ledono interessi individuali o collettivi. In presenza di contenuti di questo tipo, dovrebbe essere agevole, percorrendo alcuni insegnamenti giurisprudenziali già corroborati, applicare alla rete le medesime regole che vietano la condotta offline. La vera sfida in questo contesto appare l’individuazione di opportune misure che consentano di conoscere chi è responsabile della diffusione delle notizie false, di qualificarlo agli occhi dell’opinione pubblica (come foriero di menzogne), di poter replicare alle falsità diffuse, di rimuoverle una volta accertata l’illiceità e di chiedere conto dei danni provocati.
Un problema sempre esistito
Agli albori di Internet, quando ancora si utilizzavano i modem 56 Kbps e la rete non aveva ancora pervaso ogni segmento della dimensione sociale e professionale degli individui, venne alla luce un “servizio antibufale”, che tuttora esiste e funziona. Ai tempi, questo servizio serviva perlopiù a sconfessare un uso improprio e che oggi definiremmo probabilmente scellerato per la privacy, della posta elettronica, eletto a veicolo di “catene di Sant’Antonio”, richieste di aiuto per raccolte fondi o magici quanto improbabili effetti moltiplicatori della propria ricchezza o, se volete, molto più realisticamente, credulità.
Ai non pochi sprovveduti dediti a un utilizzo quasi ludico e certo disinvolto delle email, veniva così dischiuso l’orizzonte di una verità in cui nessuna sventura era destinata a colpire i temerari che avessero “bloccato” queste catene o in cui, per esempio, la richiesta di aiuto di rivelava falsa o tristemente inutile.
Non solo i “servizi antibufala” ma anche l’incremento della familiarità con il mezzo e la crescente alfabetizzazione digitale (cui purtroppo fa da contraltare un non altrettanto ingente tasso di alfabetismo funzionale) hanno permesso di superare, nei primi anni di diffusione di Internet, questo fenomeno.
Viene dunque da chiedersi se anche oggi, a fronte di una nuova ondata di “bufale”, stavolta per il tramite diretto (anche) del web, lo sviluppo di una maggiore capacità di discernimento da parte degli utenti non prometta un eguale superamento del problema della circolazione di fake news. In fondo il parallelismo sembra trovare conferma: mentre la circolazione delle prime “catene” era affidata a un uso incauto, pressoché elementare, della posta elettronica, la circolazione di notizie infondate si alimenta al giorno d’oggi del “web partecipativo”, in cui non solo è possibile attivare canali o piattaforme di condivisione, che formalmente si presentano come siti di controinformazione ma rappresentano un ricettacolo di notizie del tutto approssimative, non veritiere o tendenziose, ma al contempo è dato agli utenti interagire attivamente con i contenuti, condividendoli, commentandoli e così contribuendo, in alcuni casi, anche a forme “virali” di circolazione.
Questa ipotesi ricostruttiva sembra confermare le parole di Mill, e confortare così l’idea che soltanto un apporto sempre più ampio di informazione consente di migliorare complessivamente la qualità dell’ecosistema informativo.
Questa chiave di lettura evoca del resto l’elaborazione della dottrina e della giurisprudenza statunitense in materia di libertà di espressione, e la metafora del marketplace of ideas, in cui la cartina di tornasole dell’autorevolezza dell’informazione è data dalla sua capacità intrinseca di suscitare un riscontro all’interno dell’opinione pubblica. Sicché, in una visione squisitamente di stampo liberale, anche le notizie infondate, mendaci o comunque non verificate meriterebbero di circolare, in quanto la loro scarsa attendibilità sarebbe destinata a trovare conferma nella incapacità di fare presa sull’uditorio. Al contempo, proprio l’esistenza e la circolazione di informazioni di cattiva qualità, tendenziose o non verificate permetterebbe di esaltare il carattere qualificato dell’informazione professionale.
La possibilità di utilizzare questo impianto dogmatico sembra suffragata dall’atteggiamento della giurisprudenza della Corte suprema statunitense, che non ha modificato il suo tradizionale approccio garantista nell’ambito della casistica relativa a ipotesi di limitazione della libertà di espressione in rete, dalla sentenza Reno v. ACLU del 1997 in poi.
E, del resto, l’esistenza di un contesto policentrico, composto da più gatekeepers (non solo i siti informativi ma anche le piattaforme di condivisione come i social network), contribuisce in certa misura ad attenuare i potenziali effetti lesivi derivanti dalla circolazione di notizie infondate, in primis creando un contesto di concorrenzialità tra le fonti ma soprattutto rendendo sempre più plurale e pluralistico l’assetto degli attori coinvolti nel mercato dell’informazione, non più circoscritto a un novero di operatori qualificati, alla stregua di veri e propri intermediari, il cui ruolo di “oligarchi” dell’informazione avrebbe potenzialmente aggravato l’effetto di una potenziale condotta diffamatoria. In altri termini, lo scenario di un’informazione disintermediata, in cui talvolta gli utenti divengono creatori-fruitori, sembra attenuare gli effetti negativi connessi alla diffusione di notizie false o lesive di interessi rispetto all’epoca in cui la circolazione delle medesime era affidata a un gruppo più ristretto di soggetti che, spartendosi il mercato, intercettavano un pubblico più ampio rispetto a quello che i singoli gatekeepers possono oggi contare, sebben complessivamente più ampio. Discorso diverso vale forse per l’hate speech, dove la maggiore diffusività del discorso dell’odio su Internet alimenta il concretizzarsi di un evento lesivo, in quanto suscitando approvazione il messaggio presenta una maggiore capacità di tradursi in un effetto incitativo o di istigazione alla commissione di atti di violenza. In questo quadro, il test del clear andpresent danger coniato dalla giurisprudenza statunitense potrebbe forse iniziare a vacillare. Va tuttavia rimarcata la differenza tra le due fattispecie, ancorché correlate in alcune circostanze, e segnatamente laddove le campagne d’odio si nutrano anche della diffusione di notizie prive di fondamento. Se peraltro, a rigore, l’hate speech già rientra nel perimetro delle norme vigenti quando l’utilizzo di un linguaggio d’odio tracimi – come non infrequentemente accade – in condotte diffamatorie o ingiuriose, che attentano all’onore e alla reputazione degli individui, insidiandone in definitiva anche la dignità, nel caso delle fake news le coordinate del problema appaiono diverse, sol che si pensi, per esempio, al ruolo delle piattaforme online, che a fronte della conclamata natura illecita di determinati contenuti possono essere richiesti (e obbligati) di procedere alla relativa rimozione, senza timore, verosimilmente, di essere tacciati come censori privati19 o comunque come titolari di una responsabilità di tipo editoriale nella selezione dei contenuti.
Appare però dominante, non tanto nelle trattazioni dei giuristi, quanto nei dibattiti a livello mediatico e politico, una tendenza a confondere i diversi piani in cui queste problematiche devono essere collocate.
Il tema di questo Convegno si incentra sulle fake news e sull’allarme sociale che esse ingenerano. Occorre dunque definire preliminarmente cosa si intenda per fake news.
Si tratta di una questione che non è possibile risolvere facendo riferimento a definizioni semplici e sufficientemente condivise del significato di questo termine.
Si può però dire che rientrano in questa categoria le notizie che riguardano fatti o vicende false, in quanto mai accadute, o false perché riferiscono di vicende realmente accadute in modo da indurre in errore di valutazione o di comprensione chi ne venga a conoscenza.
Qui sorge subito una prima questione di particolare importanza: per qualificare una notizia come fake è sufficiente che essa sia “falsa” o racconti in modo “falso” o “deformante” fatti realmente accaduti, o occorre invece che a questi elementi in qualche modo “oggettivi” si aggiungano anche elementi “soggettivi” quali la finalità perseguita e la consapevolezza della falsità della notizia o del modo con il quale essa è data?
Secondo la maggior parte dei commentatori e degli studiosi, a definire le fake news non concorrono però soltanto questi elementi perché una notizia sia considerata un fake occorre anche verificare non solo la finalità per la quale essa è diffusa e la conoscenza della falsità da parte di chi la dà o la diffonde, ma anche che essa sia diffusa per una finalità consapevolmente perseguita.
Questo aspetto complica molto la definizione di cosa si debba intendere per fake news perché introduce nella nozione non solo l’elemento soggettivo della consapevolezza della “falsità della notizia”, ma anche quello della intenzionalità della sua diffusione, legata a una finalità specifica.
Il principio di finalità applicato al concetto di fake news è però estremamente sfuggente. I fini perseguiti da chi, consapevolmente, diffonde notizie false in quanto riferite a fatti mai accaduti, o false in quanto riferite a fatti accaduti ma rappresentati in modo falso o fuorviante, possono essere i più diversi e i più distanti tra loro.
Vi sono fake diffuse per pubblicizzare un prodotto commerciale; per aumentare il numero degli ascoltatori di una trasmissione televisiva o dei lettori di un giornale o degli utenti di un social; per aumentare il numero dei contatti tra utenti e la piattaforma che contiene l’informazione. Diffondere fake news o non impedirne la circolazione può essere utilissimo allo scopo di aumentare le vendite di beni o servizi di ampliare lo share dei media o di aumentare il numero degli account di un social, al fine di innalzare il valore commerciale del mezzo col quale la notizia è diffusa. Allo stesso modo non si può ignorare che i social stessi hanno interesse a diffondere fake news quando queste, per il loro contenuto, incentivano la curiosità degli utenti e si prestano a esser ridiffuse in modo massiccio. In questo caso, infatti, i social traggono un profitto dal numero di clic che l’accesso alla notizia produce e che si trasforma in un accrescimento del valore degli spazi pubblicitari oltre che nell’accumulo di un numero sempre crescente di dati, preziosissimi in tempi di Big data.
Diverso invece il quadro in cui si collocano le fake news che hanno la finalità di orientare la informazione politica o scientifica. Le fake news che intervengono nel dibattito politico o nei processi decisionali derivanti hanno lo scopo di modificare le opinioni politiche degli utenti, al fine di incrementare il consenso di chi si sostiene o di diminuire quello di chi si contrasta. Le fake news in materie scientifiche hanno in linea generale lo scopo di orientare le convinzioni dei cittadini circa la affidabilità della informazione scientifica nei settori più diversi della conoscenza. Le false comunicazioni scientifiche possono andare, infatti, dai farmaci e dalle cure relative alla salute fino alle tematiche ambientali, senza dimenticare le notizie e i “racconti” orientati a ridefinire la conoscenza del passato, come accade nel caso dei negazionisti o a spingere a visioni distopiche del futuro.
La stessa costante ricostruzione della storia, già paventata nel famoso libro di Orwell 1984, è resa oggi ancora più facile proprio dal fenomeno delle fake news che, a tal fine, sono ampiamente utilizzate.
Il termine fake news fa dunque riferimento a uno spettro amplissimo di fenomeni che assumono valore e significato diverso a seconda della finalità che ne orienta l’uso.
Il significato di questo neologismo è inoltre molto diverso da altri due concetti che negli ultimi tempi, anch’essi espressi con termini altrettanto nuovi, lo accompagnano spesso nelle discussioni sui media e nel dibattito pubblico.
Intendo riferirmi al neologismo “post truth” e al controverso concetto di “alternative facts’’.
Anche in questo caso siamo in presenza di termini che cercano di cogliere aspetti nuovi della realtà in cui viviamo, legati in particolare all’ecosistema costituito dai media e dalla diffusione delle notizie on line.
Come tutti sappiamo, “post truth” è stata scelta come la parola dell’anno 2016 dall’Oxford Dictio- nary, che ne ha dato una definizione precisa. Si tratta di una definizione, che ha più un valore “concettuale” che “descrittivo”, in quanto esprime il significato che l’aggettivo ha per i redattori del dizionario, mentre di norma i dizionari definiscono il significato che le parole hanno nel linguaggio utilizzato dalla comunità linguistica di riferimento.
Si tratta comunque di un aggettivo finalizzato ad esprimere una caratteristica del sostantivo al quale si accompagna. Esso si riferisce o denota circostanze rispetto alle quali i fatti oggettivi influenzano l’opinione pubblica non per ciò che essi sono ma per il modo col quale vengono raccontati («relating to or denoting circumstances in wich objective facts are less influential in shaping public opinion than appeals to emotion and personal belief»).
In questo senso l’espressione “post truth politics” è utilizzata per indicare quella comunicazione politica che, riferita o meno che sia a fatti realmente accaduti e a idee correttamente rappresentate, è data in modo da suscitare emozioni in chi l’ascolta.
Lobbiettivo è quindi di suscitare una partecipazione emotiva all’evento descritto o al messaggio politico che ne è oggetto.
Nel caso della c.d. post truth, la finalità del messaggio dato è dunque quella di stimolare o provocare emozioni (e credenze) e dunque una adesione di carattere più emotivo che razionale.
In questo senso nulla vieta che una fake news sia anche “post truth”, come accade quanto la notizia falsa punti più sull’emotività che sulla razionalità di quanti ne vengano a conoscenza.
Un altro neologismo che spesso è accomunato a fake news è “alternative facts”, un termine per ora ancor più incerto nel suo significato, usato in modo plateale dalla consigliera del Presidente Trump Kellyanne Conway durante una conferenza stampa il 22 gennaio 2017.
Il significato di questa espressione, secondo la stessa Conway, starebbe sostanzialmente ad indicare affermazioni o notizie relative a fatti accaduti che presentano una visione della realtà propria di chi la esprime anche se diversa da come gli stessi fatti sono stati visti e raccontati dalla maggioranza dei media o da fonti istituzionali specificamente competenti. Un po’ come le diverse stime normalmente date da organizzatori e autorità di polizia circa il numero dei partecipanti a una manifestazione di massa.
L’uso dell’espressione “alternative facts”, nella misura in cui legittima informazioni relative a fatti accaduti non corrispondenti alla verità oggettiva, è stata fortemente contestata da un gruppo cinquanta importanti giuristi americani aderenti al Distrisct of Columbia Bar Association’s Rule of Professional Conduct, che il 23 febbraio 2017 hanno presentato un ricorso contro Conway per violazione del Codice etico, in quanto giurista titolare di pubblico incarico.
Tuttavia, in attesa di vedere se questa espressione sia o no destinata a radicarsi, è chiaro che essa rappresenta sostanzialmente una sottospecie di particolare interesse delle fake news.
Diverso è invece il discorso rispetto a un altro termine, anche questo frequentemente utilizzato con riguardo alle fake news. Il riferimento è al c.d. “hate speech”, ovvero ai “discorsi di odio”.
Ehate specch, infatti, ha una definizione specifica ed è stato oggetto di numerosi interventi normativi, sia a livello di Unione Europea che di CEDU, così come da parte degli ordinamenti giuridici di numerosi Stati.
Per hate speech si intendono, secondo il Consiglio di Europa (ma analoghe sono le definizioni degli altri ordinamenti) «tutte le forme di espressione miranti a diffondere, fomentare, promuovere o giustificare l’odio razziale, la xenofobia, l’antisemitismo o altre forme di odio fondate sull’intolleranza. Tra cui l’intolleranza espressa sotto forma di nazionalismo aggressivo e di etnocentrismo, la discriminazione e l’ostilità nei confronti delle minoranze, dei migranti e delle persone di origine immigrata» (Consiglio di Europa, Comitato dei Ministri).
All’interno dell’Unione Europea l’hate speech è stato definito illegale fin dalla Decisione quadro 2008/913/JHA del 28 novembre 2008 ed è su questa base che la stessa Unione Europea ha concordato il 31 Maggio 2016 con Facebook, Microsoft, Twitter e YOU Tube, nell’ambito dell’Internet Forum, il “Code of Conduct on illegal online hate speech”.
Il concetto di hate speech è dunque precisamente determinato e giuridicamente regolato e perciò diverso da a quello assai più generico e sfuggente di fake news.
Nulla vieta che una fake news possa, per il suo contenuto, coincidere anche con l’hate speech e, se diffusa on line, ricadere nell’ambito del Codice di condotta appena citato.
Tuttavia concettualmente fake news e hate speech sono termini diversi che fanno riferimento a aspetti differenti della diffusione di notizie con riferimento al loro contenuto.
Va inoltre sottolineato che tutti i termini qui usati, fake news, post truth, alternative facts, hate spe- ech, hanno almeno due cose in comune.
La prima è di far riferimento in generale alla diffusione di notizie o opinioni relative a fatti, o ideologie, o modi di vedere la realtà e di descriverla.
La seconda che nessuno di essi è di per sé limitato all’uso di Internet o alla comunicazione on line. Al contrario tutti si applicano anche al sistema dei media e dei mezzi di diffusione del pensiero. Inoltre in genere riguardano aspetti dell’informazione che confinano con la libertà di opinione e comportano problemi non semplici di armonizzazione tra la libertà di manifestazione del pensiero, o per gli americani la “freedom of speech”, e la violazione del diritto dei cittadini ad essere informati correttamente nel quadro di un diritto di informazione costituzionalmente garantito non solo come un diritto in sé ma anche, e soprattutto, come un diritto funzionale
Fermo restando quanto appena detto, sarebbe assurdo negare che tutti questi termini, e i fenomeni ai quali si riferiscono, hanno assunto un valore specifico nel tempo attuale in virtù del sistema dei media, da un lato, e della diffusione delle notizie on line, dall’altro.
L’incrocio tra media tradizionali e diffusione delle notizie on line, così come l’incrocio fra fake news e hate speech, dà vita a quello che Mediamatters for America ha definito nel suo noto paper “Misin- forme of the Year: the Ecosystem of Fake News and the “Alt-Righi”, come un vero e proprio Ecosistema. Ancor più interessante su questo piano il contributo di Kate Starbird, “Information Wars: A Window into the Alternative Media Ecosystem”, pubblicato in medium.com.
Pur essendo di estrema importanza ed efficacia, l’uso coordinato di media tradizionali e/o della informazione on line al fine della diffusione delle fake news, tuttavia non vi è dubbio che il vero habitat o bordo di cultura del tema che stiamo affrontando è quello della informazione on line.
Del resto la Standford Graduate School of Education il 22 novembre 2016 ha reso noto che una indagine condotta su 7.804 studenti in 12 Stati degli USA dimostra che la capacità dei giovani americani, anche delle high school, di valutare la credibilità delle notizie diffuse in rete è bassa. Infatti il 30% degli intervistati tra una notizia data da un sito “vero” e quella data da un fake website, ovviamente simile nell’aspetto al vero, preferiscono credere al sito falso.
Insomma, non vi è dubbio che l’interesse maggiore in materia di fake news va dedicato alla diffusione di questo tipo di notizie sulla rete.
L’aspetto principale della pericolosità delle fake news diffuse in rete e tramite i social consiste nel fatto che nella realtà on line ha preso piede un fenomeno inaspettato anche se molto prevedibile: quello della c.d. “informazione fai da te”, in virtù della quale gli utenti dei social si informano l’uno con l’altro, attraverso una sorta di catena elettronica di S. Antonio potenzialmente pressoché infinita. E’ facilissimo, inserendosi in queste “catene”, magari usando tag che le identificano, diffondere informazioni false che però, specialmente dalle persone meno informate sono credute vere e originate o ritrasmesse da utenti reali della rete.
Questo compromette in modo decisivo la possibilità di sostenere, come spesso si è fatto, che la rete è in grado di autocorreggersi grazie alla Crowdwisdom, in virtù della quale le notizie infondate o di scarsa credibilità sono espulse dagli stessi utenti che rinunciano a ridiffonderle.
E’ molto diffìcile credere che la crowdwisdom possa davvero funzionare quando si tratta di distinguere notizie fondate o credibili da fake news volutamente fatte circolare da chi è interessato a diffonderle. Occorre tenere presente che la maggior parte delle fake news che si diffondono in modo ampio, e talvolta persino virale, sulla rete sono originate non da account corrispondenti a esseri umani, anche se magari in modo anonimo, ma da account coordinati e gestiti da robot operanti secondo algoritmi appositamente definiti. E’ evidente che questo fenomeno, proprio per la sua pervasività (guidata anche da un uso sapiente dei Big data e del Data analysis) rende diffìcilissimo per gli utenti normali distinguere fra notizie false o falsamente riportate e notizie corrette, anche se diffuse attraverso il sistema della “informazione fai da te”.
Per questo non si può far conto soltanto sulla crowdwisdom per combattere in modo efficace il fenomeno delle fake news on line.
Per comprendere meglio questi aspetti e, in generale, il fenomeno delle fake news on line, è necessario però richiamare all’attenzione su alcuni aspetti della rete e dei social che è indispensabile avere presenti.
Questo comporta anche alcune precisazioni terminologiche che rispondono ad aspetti essenziali dei molti e diversi modi che caratterizzano la diffusione delle informazioni in rete e, di conseguenza, il fenomeno delle fake news.
Dalla Boschi al funerale di Riina fino ai falsi incontri di Renzi con il fondatore di Facebook, passando per i legami fra partiti, amministratori di pagine social dispensatrici di ‘bufale’ e presunti network internazionali di siti di disinformazione. Come promesso da Matteo Renzi, il Pd ha pubblicato su ‘Democratica’ il primo rapporto periodico sulle fake news, una serie di dati e report documentati che puntano il dito contro M5S e Lega.
“A differenza degli altri, il Pd non ci ha pensato un attimo a prendere le debite distanze dai toni e dal linguaggio aggressivo e inappropriato utilizzati in una card pubblicata da alcuni attivisti del Pd qualche settimana fa. Perché il M5S non ha fatto altrettanto in questo caso?”, si legge su ‘Democratica’ con riferimento alla falsa foto dei funerali di Totò Riina con Maria Elena Boschi e Laura Boldrini.
Il rapporto spiega il percorso di alcune fake news, come un incontro tra Renzi e Zuckerberg per una intesa sulla censura alla rete, sui social e su Internet e indica i legami tra quest’ account ‘crea bufale’ con M5S e Lega. “In questo scenario, fare chiarezza e dissipare i dubbi dovrebbe essere un obiettivo comune a tutte le forze politiche. Per cominciare, Di Maio potrebbe prendere le distanze dai canali unofficial meno trasparenti che supportano il suo Movimento, come ha fatto il Pd nei confronti di un gruppo di sostenitori che per attaccare i nostri avversari aveva utilizzato dei toni aggressivi e deprecabili seppur non disinformativi o diffamanti”, spiega il Pd.
Secondo la ricostruzione nel rapporto dem, sarebbero almeno tre le pagine non ufficiali di supporto al Movimento Cinque Stelle – ‘Virus5Stelle’, ‘Vogliamo il Movimento 5 Stelle al governo’ e ‘M5S News’ – gestite da amministratori conosciuti dal candidato premier pentastellato tanto da essere ‘taggati’ in alcuni suoi post, e responsabili della condivisione sistematica e massiva di alcune fra le fake news più diffuse.
Il Pd prosegue: “Allo stesso modo, Matteo Salvini potrebbe spiegare perché l’account ufficiale della Lega si sia pubblicamente legato a un sito parte di una rete internazionale di disinformazione. Queste prese di posizione sarebbero degli atti significativi quanto mai auspicabili in uno scenario internazionale sempre più allertato dalle possibili conseguenze di tentativi di condizionamento dell’opinione pubblica specialmente durante le campagne elettorali in vari Paesi democratici”. In particolare, nel mirino del rapporto Pd finisce il legame fra la Lega e la pagina ‘Adesso Basta’, “direttamente collegata – scrivono i dem – alla destra estrema statunitense e parte di un network di siti internazionali che perseguono gli stessi fini”.
Secondo il report, “pare dunque prioritario mantenere alta la guardia; tutte le forze politiche del nostro Paese dovrebbero collaborare per scongiurare eventuali pericolo di ingerenze nel dibattito pubblico e garantire la massima correttezza e trasparenza informativa anche in vista dell’imminente campagna elettorale”.

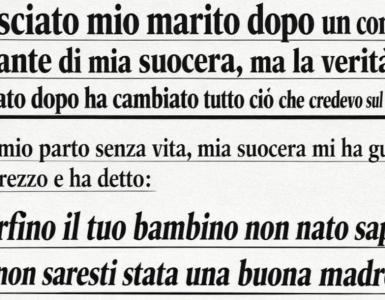
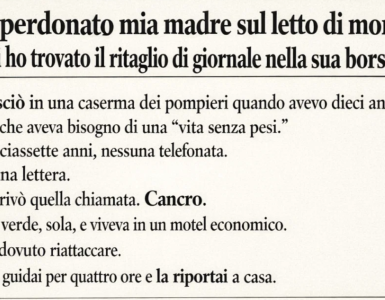
Add comment