Avevo accettato di occuparmi della figlia di mia cugina, una bambina di sei anni, solo per un’ora. La bambina era ingestibile. Scaduto il tempo, non avendo sue notizie, l’ho chiamata. Mi ha risposto dicendo che aveva intenzione di passare la notte fuori e che sarebbe rientrata soltanto il giorno seguente. Ero furioso: ho vestito la bambina, l’ho portata fuori e l’ho sistemata nel seggiolino dell’auto come se fosse una busta della spesa che non volevo.
Neppure un “per favore”. Solo un pigro: “Ho pensato che non ti dispiacesse”. Come se badare a sua figlia scatenata, che aveva distrutto mezzo appartamento, versato succo di mela sul mio portatile e urlato come una forsennata per un gusto di yogurt sbagliato, fosse stato un piacere.
In realtà non avrei neanche dovuto essere a casa: avevo cancellato all’ultimo momento un appuntamento per aiutarla, perché lei si diceva “sopraffatta”. Quella parola che ripete sempre, mentre tutti noi altri teniamo insieme le nostre vite con lo scotch senza pretendere applausi.
Ero furibondo. Ma non potevo semplicemente abbandonare la bambina. Così l’ho allacciata al seggiolino, ho mandato a mia cugina un messaggio secco: “Te la sto riportando”, e ho guidato per quaranta minuti fino a casa sua.
Arrivato lì, il portiere del palazzo mi ha detto che lei era partita per il weekend a Miami con un certo Micah. La sua auto non era nemmeno nel parcheggio.
Mi sono ritrovato così bloccato con una bambina di sei anni, un piccolo tornado che odiava i calzini, adorava gli stick di colla e aveva la concentrazione di una mosca sotto Red Bull.
Seduto in macchina, davanti all’appartamento vuoto, stringevo il volante con il fumo che mi saliva dalla testa. “E adesso?” borbottai, mentre lei dietro canticchiava una canzone inquietante su una mucca viola che sposava un panino.
“Ti piace la pizza?” chiesi, disperato.
“Sì,” rispose. “Ma non quella marrone. Né quella a triangolo. Solo quella soffice.”
Non avevo idea di cosa intendesse, ma trovai una pizzeria con un menù adatto ai bambini e un tavolo d’angolo. Pensai che potesse mangiare e sfogarsi un po’, mentre io avrei chiamato mia zia o magari perfino i servizi sociali. Perché questo non era affatto il piano.
Ci sedemmo, pronti al peggio. E invece successe qualcosa di inatteso.
Si comportò bene. Usò il tovagliolo. Ringraziò il cameriere. Mi offrì persino un grissino. Per venti minuti filati fu… normale. Sembrava un’altra bambina rispetto a quella che poche ore prima aveva scarabocchiato il mio frigorifero con un pennarello indelebile.
Il cameriere si avvicinò e disse: “Che carina! È sua?”
Prima che potessi rispondere, la piccola mostriciattola sorrise e disse: “È il mio migliore amico.”
Rimasi di sasso. “Cosa?”
Lei annuì seria, poi intinse la pizza nell’acqua e mi mostrò i denti sporchi di pomodoro. Scoppiai a ridere. Sul serio. Di pancia. E lei rise con me, a volume massimo, come se condividessimo una barzelletta segreta. Le persone si girarono a guardarci, ma non mi importava.
Forse ero solo stremato, ma per la prima volta da quando l’avevo presa con me non stavo pianificando l’esilio di mia cugina. Stavo… iniziando a divertirmi con lei.
Certo, non durò molto: cercò di lasciare una mancia al cameriere mettendogli un pastello in tasca e rischiò di soffocarsi legandosi un palloncino al collo come una sciarpa. Ma sotto il caos, c’era qualcosa. Una scintilla.
Quella sera la sistemai sul divano con una coperta e le lasciai guardare i cartoni finché non si addormentò. Non ebbi il coraggio di sgridarla quando disegnò un ritratto di famiglia con noi due e mi disse che avevo “i capelli da eroe”.
La mattina dopo ricevetti un messaggio da mia cugina: “Ehi, puoi tenerla fino a stasera? Abbiamo perso il volo 🥴”.
Nessuna scusa. Nessun grazie. Solo un’emoji e una pretesa.
Presi il telefono e chiamai mia zia, sua madre.
Scoprii che non era la prima volta: mia cugina aveva già lasciato la bambina a vicini, amici e perfino a un ex insegnante, sparendo per interi weekend senza dire quando sarebbe tornata.
“Dice che ha bisogno di libertà”, sospirò mia zia. “Ma ha una figlia, non una borsa da palestra.”
Quelle parole mi colpirono.
Guardai la bambina—si chiama Farrah—che pettinava la bambola con una forchetta cantando sottovoce. Lei non sapeva di essere trattata come un pacco dimenticato.
Così la portai a fare colazione con i pancake e poi al parco. Facemmo castelli di sabbia, demmo da mangiare alle anatre e fummo inseguiti da uno scoiattolo arrabbiatissimo. Mi chiamò “zio delle avventure”, anche se in realtà ero suo cugino di secondo grado.
Poi arrivò un altro messaggio: “Rimaniamo fino a domenica! Puoi tenerla ancora? TI ADORA! 😘”
Quello fu il limite.
Non risposi. Tornai da mia zia e chiesi cosa servisse per ottenere la tutela temporanea. Non volevo fare l’eroe, ma non sopportavo che Farrah continuasse a pagare per l’immaturità di sua madre.
Due settimane dopo avevo i documenti in mano. Non era una custodia definitiva, ma mi dava il potere di decidere per lei e tenerla al sicuro.
Pensavo che mia cugina avrebbe fatto scenate. Invece rispose con un solo messaggio: “k.”
Fu allora che capii: non voleva combattere. Voleva scappare.
Da lì in poi fu un caos: chat di famiglia in fiamme, telefonate di mia madre in lacrime, mia cugina che mi bloccava ovunque. Ma Farrah? Lei rifioriva.
Dormiva meglio, mangiava meglio, disegnava di più. La iscrissi a un corso di arte e dopo una settimana l’insegnante mi prese da parte: “È incredibilmente intelligente. E molto divertente. Ha vissuto traumi?”
Non sapevo cosa rispondere. Annuii soltanto.
Quella sera chiesi a Farrah se le mancava la mamma.
Mi guardò e disse: “Non quando sto con te.”
Quelle parole mi colpirono come un treno in corsa.
Passarono i mesi e trovammo un ritmo. Colazioni con cereali e SpongeBob, pomeriggi al parco o momenti di calma. Non tremava più se qualcuno alzava la voce. Imparò ad allacciarsi le scarpe. Fece amicizia con un bambino timido che adorava i dinosauri.
Poi, sei mesi dopo, arrivò una lettera raccomandata. Mia cugina chiedeva di rinunciare alla custodia.
Nessun avviso, nessun confronto. Solo un documento legale, freddo e definitivo. Si era trasferita ad Atlanta con Micah, aveva “ricominciato da zero” e non voleva “trattenere Farrah”.
Avrei dovuto sentirmi sollevato. Invece mi sentivo svuotato. Non ero suo padre. Non avevo mai pensato di diventarlo. Ma ormai non riuscivo a immaginare le mie giornate senza il suo sorriso sdentato e le sue barzellette terribili.
Dopo altri tre mesi di tribunali, documenti e ispezioni, il giudice mi concesse la custodia completa.
All’uscita dal tribunale, Farrah mi prese la mano e chiese se potevamo festeggiare con un gelato.
“Solo se prometti di non versarlo sulla bambola.”
Rise e corse avanti. Naturalmente, lo versò sulla bambola. Non la fermai.
Sono passati due anni. Farrah ora è in seconda elementare. È ossessionata dallo spazio e dai pattini a rotelle e dice che da grande vuole fare “la cantante, l’astronauta e la paninara”. Io le rispondo che può essere tutte e tre le cose.
Parliamo ancora di sua madre, con onestà ma senza cattiveria. Le dico che ognuno cresce con tempi diversi e che, a volte, l’amore significa lasciar andare.
Un giorno mi ha chiesto se ero triste perché “mi ero ritrovato incastrato con lei”.
Le ho detto che non ero incastrato. Ero stato scelto.
Non da sua madre, ma dalle circostanze. Da quel groviglio assurdo che l’ha portata nella mia vita senza lasciarmi il tempo di scappare.
E sì, ho perso una cugina. Ma ho trovato un motivo per svegliarmi ogni mattina con uno scopo.
Non avevo mai pensato di essere padre. Ora non riesco a immaginare di essere altro.
E quella piccola peste?
È la cosa migliore che mi sia mai capitata.
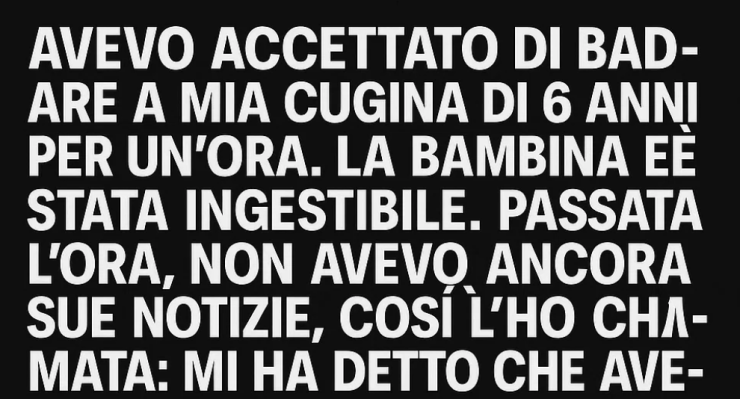



Add comment