Io e il mio ragazzo ci siamo trasferiti da poco a vivere insieme. Da allora, le cose hanno cominciato a sparire, per poi ricomparire un giorno dopo, esattamente nello stesso posto da cui erano scomparse. Parlo di documenti, piccoli oggetti di casa, perfino del cibo. Così ho installato una telecamera nascosta, e quello che ho visto mi ha gelato il sangue.
…Qualcuno camminava nel nostro salotto nel cuore della notte. Non era il mio ragazzo. Era una figura più bassa, che si muoveva lentamente, a piedi nudi.
All’inizio pensavo di aver immaginato tutto. Le immagini erano sgranate — non avevo comprato la versione in alta definizione — e la sagoma era solo un’ombra scura, alle 2:37 del mattino, che si muoveva dal corridoio verso la cucina. Sembrava aprisse il frigorifero, si fermasse un attimo e poi si allontanasse con quella che sembrava proprio la bustina di formaggio a fette che giuravo fosse sparita il giorno prima.
La mattina dopo, lo mostrai a Omar, il mio ragazzo. Rise nervosamente e disse che probabilmente era un glitch. «Magari ero io? Forse mi sono alzato per uno spuntino.»
Lui è alto un metro e novantuno. Quella figura no.
Decisi comunque di lasciar perdere. Più o meno. Non volevo sembrare la fidanzata paranoica, dopo appena un mese di convivenza. Avevamo già avuto qualche difficoltà di adattamento — lui lasciava sempre la luce del bagno accesa, io volevo le finestre aperte e lui preferiva tenere tutto sigillato come un sottomarino.
Ma una settimana dopo, riguardando le registrazioni, vidi di nuovo la stessa scena. Stessa ora. Stessa figura. Stavolta prese le mie chiavi dal vassoio accanto alla porta, le rigirò tra le mani e le rimise esattamente al loro posto — proprio come le avevo trovate quella mattina, dopo aver giurato che la sera prima non c’erano.
Non dissi nulla a Omar. Chiamai invece l’amministratore del palazzo.
«No, nessuna effrazione, nessuna copia di chiavi emessa. In quell’appartamento siete solo voi due. Sicura di non aver spostato tu le cose?»
Ero sicura. Così, la notte successiva, decisi di restare sveglia.
Mi misi sul divano, al buio, con una coperta addosso. Anche il cellulare lo spensi, per non far filtrare nemmeno un bagliore. Verso le 2:40 sentii un rumore. Non passi, esattamente — piuttosto il lieve cigolio del pavimento di legno. Il nostro corridoio scricchiola sempre negli stessi punti.
E poi, davanti ai miei occhi, l’anta del ripostiglio del corridoio si aprì.
Ne uscì una figura minuta. Indossava i calzini, un cappuccio tirato sulla testa. Si voltò verso la cucina, e io trattenni il respiro.
Accesi la luce e urlai.
La persona si immobilizzò. Io pure.
Poi si tirò giù il cappuccio.
Era una ragazza. Avrà avuto tredici, forse quattordici anni. Capelli neri arruffati, lo sguardo terrorizzato. Non disse nulla, guardò solo in basso, come una bambina colta sul fatto.
Omar accorse dalla camera in boxer. Lei cercò di tornare nel ripostiglio, ma lui le sbarrò la strada. Si accovacciò sul pavimento e scoppiò a piangere.
La facemmo sedere al tavolo e le demmo un bicchiere d’acqua. Tremava, stringendo le maniche della felpa come fossero un’armatura. Si chiamava Isela. Quella notte non disse molto, ma nei giorni successivi, mettendo insieme i pezzi, scoprimmo la verità.
Si nascondeva nello spazio sopra la lavanderia condominiale.
Il nostro edificio aveva una strana struttura: alcuni condotti d’aerazione collegavano gli armadi di servizio di un appartamento con il soffitto di un altro. Quando il personale delle pulizie aveva dimenticato di rimettere una lastra nel controsoffitto, lei era riuscita a entrare e da allora viveva lì.
Da due settimane. Era lì da prima che ci trasferissimo.
Non era del tutto senza casa: sua madre abitava nell’edificio accanto. La conoscevo di vista — sempre seduta fuori con una sigaretta e la musica alta dal telefono, a litigare con qualcuno su FaceTime.
Isela era scappata, ma non voleva andare lontano. Solo abbastanza da non stare più lì.
Le chiesi perché avesse scelto proprio il nostro appartamento.
«Voi non urlavate,» mormorò.
Quelle parole mi colpirono come un pugno.
Di notte sgattaiolava dentro quando era certa che dormissimo. Mangiava qualcosa, faceva la doccia, o si sedeva sotto la bocchetta dell’aria calda perché lì si sentiva al sicuro. Ecco perché la mia sciarpa era finita in bagno, quella volta. Pensavo di stare impazzendo.
Non sapevo cosa fare. Chiamare la polizia? Dirlo a sua madre?
Omar pensava che dovessimo denunciarlo. «Non può vivere qui. E se succede qualcosa? Finiremmo nei guai.»
Aveva ragione. Ma non mi sembrava giusto.
Le chiesi se sarebbe tornata a casa — se l’avessi accompagnata io. Mi guardò come se le avessi chiesto di toccare il fuoco.
«Torno nel controsoffitto,» disse. «Lasciami restare finché ricomincia la scuola.»
Non ci avevo neppure pensato, alla scuola.
Le chiesi dove andasse, e mi disse che non ci andava da aprile. Era metà luglio. Chiesi se sua madre lo sapesse. Lei scrollò le spalle.
«È occupata col suo ragazzo.»
Sapevo chi era. Sempre fuori, a lucidare la Camaro e a gridare a chiunque passasse sul “suo” marciapiede.
Quella notte non chiusi occhio.
Il mattino dopo chiamai al lavoro dicendo che stavo male. Poi telefonai al distretto scolastico, fingendomi una vicina preoccupata. Mi dissero che risultava “assente ingiustificata, luogo sconosciuto”. Se avesse saltato il primo giorno di scuola ad agosto, avrebbero fatto partire un controllo assistenziale.
Decisi di guadagnare tempo.
Sgomberai un angolo del ripostiglio, le misi una coperta e del cibo. Sapevo che era folle. Probabilmente anche illegale. Ma continuavo a pensare a come tremava, e a come aveva detto che non urlavamo.
Per alcuni giorni, Isela venne e andò in silenzio. Aspettava che fossimo al lavoro, poi dormiva o guardava film sul tablet che le avevo prestato. Le lasciavo frutta e vestiti puliti presi al mercatino. Era come avere un coinquilino fantasma.
Poi Omar la scoprì.
Tornò a casa prima e la trovò sul divano, che mangiava cereali.
Andò su tutte le furie. Non con lei — con me.
«Stai ospitando una ragazza scappata di casa? Sei impazzita, Daria?»
Provai a spiegare. Che non era pericolosa. Che era solo una ragazzina spaventata. Che aveva bisogno di un posto sicuro fino a quando non fosse ricominciata la scuola.
«Non è una tua responsabilità,» disse. «Non puoi farla vivere qui come se fossimo in un film strappalacrime.»
Aggiunse che, se non avessi detto qualcosa alle autorità, l’avrebbe fatto lui.
Lei ci sentì litigare. Quella notte se ne andò.
Pensavo fosse tornata a casa. Ma il mattino dopo, controllando il controsoffitto, trovai la sua felpa piegata sopra la grata del riscaldamento. Come un addio.
Passai la giornata a cercarla. Sua madre era fuori, col solito telefono e la sigaretta. Le chiesi se Isela fosse tornata.
«Non è un mio problema, adesso,» disse, soffiando il fumo.
Andai al parco, davanti alla scuola, perfino al distributore. Nessuna traccia.
Tre giorni. Poi quattro.
Al quinto giorno, ricevetti una telefonata da una tavola calda dall’altra parte della città. Avevo scritto il mio numero su un post-it e glielo avevo messo in tasca, “per ogni evenienza”.
«Una ragazza ha lasciato questo numero,» disse la cassiera. «Ha detto che forse sarebbe venuta a prenderla.»
Era lì, seduta a un tavolo con una tazza vuota di cioccolata calda. Occhiaie profonde, senza felpa, solo una maglietta troppo grande.
Si alzò come se si aspettasse di essere rimproverata.
Io la abbracciai. Non sapevo cos’altro fare.
Questa volta chiamai una consulente che conoscevo, di un programma comunitario dove avevo fatto volontariato. Le spiegai tutto. Mi disse che ci avrebbe pensato lei — niente polizia, niente giudizi, solo un posto tranquillo dove stare.
Isela accettò, piano piano. Non voleva tornare da sua madre, ma neppure continuare a nascondersi.
La accompagnammo lì quel pomeriggio.
È ancora lì, adesso. Ha un letto, dei pasti regolari, supporto psicologico. E ha perfino parlato di provare ad entrare nella squadra di atletica quando ricomincerà la scuola.
Io e Omar, invece, non abbiamo resistito.
Si è trasferito poche settimane dopo. Disse che era “troppo”, che non eravamo sulla stessa lunghezza d’onda quando si trattava di limiti e conseguenze.
Aveva ragione. Ma non mi pento di averla aiutata.
A volte la vita ti mette davanti qualcuno, e tu non puoi decidere se sia il momento giusto o no. Puoi solo scegliere se esserci o voltarti dall’altra parte.
Ripensandoci, tutte quelle piccole cose che sparivano — la sciarpa, il formaggio, le chiavi — non erano nulla, rispetto a quella parte di me che si è risvegliata. La parte che ricorda cosa vuol dire essere giovani, spaventati, e non sapere se qualcuno ti vede davvero.
Adesso, lei non è più invisibile.
E io non ignorerò mai più quel cigolio nel corridoio.
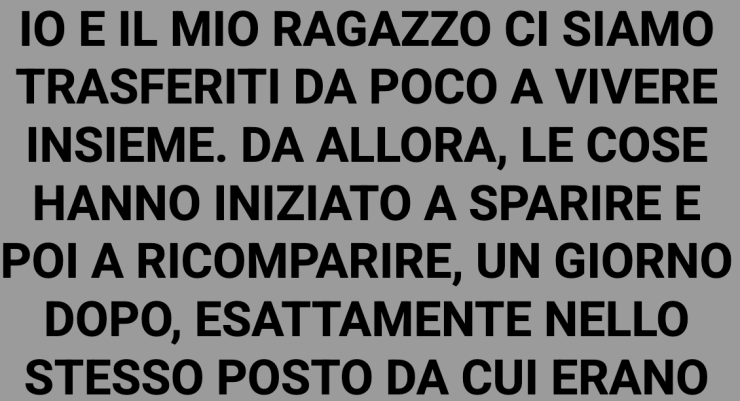



Add comment