Disse che stavamo “solo guardando”. Nessuna pressione, nessuna decisione. Una visita casuale al rifugio locale dopo il brunch, come se non avessimo già una dozzina di cose da fare.
Non sospettai nulla… finché non mi guidò in una piccola stanza delle visite e disse: “Aspetta qui un attimo.”
Poi uscì.
Qualche minuto dopo tornò, stringendo tra le braccia un gattino grigio con le zampine bianche e due occhi enormi e curiosi. Sorrisi subito, perché… insomma, un gattino.
Ma poi rimasi gelata.
Quelle macchie sul pelo. Il piccolo mento bianco. Persino quel minuscolo taglio sull’orecchio. Somigliava in modo incredibile a Misty, la mia gatta d’infanzia. Quella che dormiva sul mio cuscino ogni notte fino al giorno in cui andai al college. Quella che mia madre aveva salvato l’anno in cui mio padre se ne andò.
Mi si strozzò la voce mentre allungavo le mani per prenderla.
“Non si chiama Misty,” disse lui, poggiandola delicatamente sulle mie ginocchia. “Ma potrebbe esserlo.”
La micina mi annusò la mano come se mi conoscesse da sempre.
Ed è stato allora che l’ho visto: legato al suo piccolo collo, sotto il collarino, c’era un anello che scintillava contro il pelo.
Lo fissai, incredula. Poi alzai lo sguardo verso di lui, con la bocca socchiusa.
“Fa parte del pacchetto di adozione,” disse con la voce incrinata. “Solo se dici sì.”
Ma prima che potessi rispondere, notai qualcos’altro: inciso sul retro della medaglietta c’era scritto “Vuoi sposarmi?” … ma con un errore. “Maary” con due A.
Strabuzzai gli occhi, convinta di aver letto male. Poi controllai di nuovo. No, c’era proprio scritto così.
Lui diventò rosso come un pomodoro. “Ok, in mia difesa… ero nervosissimo quando l’ho ordinato e ho scritto troppo in fretta. Giuro che ho ricontrollato, ma evidentemente non abbastanza.”
Non riuscii a trattenermi: scoppiai a ridere. Forte. Le lacrime mi colavano dagli occhi, metà per la risata e metà per l’emozione. Quel minuscolo gatto. L’anello. Lui, lì davanti a me, impacciato come un ragazzino.
“Sì,” dissi, senza lasciare che la mia mente rovinasse quel momento.
Lui tirò un sospiro e si inginocchiò, come se avesse trattenuto il fiato per un’ora. “Davvero?”
“Certo che sì,” ripetei, ancora ridendo tra le lacrime. “Anche con il refuso.”
Mi infilò l’anello al dito: era perfetto, sembrava fatto apposta per stare lì da sempre. Misty — il gattino, non l’originale — si accoccolò sulle mie ginocchia come se fosse già a casa. Era tutto perfetto.
Ma la storia non finì lì.
Quella sera, mentre eravamo accoccolati sul divano con Misty tra di noi, chiesi: “Ma come l’hai trovata?”
Si morse il labbro, imbarazzato. “Ok… è una storia un po’ lunga.”
“Racconta,” insistetti.
Così mi spiegò.
Da mesi stava preparando la proposta. Sapeva che amavo gli animali, soprattutto i gatti, e si ricordava ogni dettaglio dei racconti su Misty, la mia Misty. Aveva persino chiesto informazioni a mia madre.
Non si aspettava però di trovare un gattino che le somigliasse così tanto.
“Non la cercavo con quell’aspetto,” confessò. “Volevo solo un gatto dolce che ti conquistasse. Ma quando l’ho vista… la somiglianza era impressionante. Stesso pelo grigio, stessi occhi. Perfino quel taglietto all’orecchio.”
Gli vennero i brividi, disse. Lo prese come un segno.
“Come se l’universo mi stesse dicendo: ‘È pronta. Vai.’”
Lo abbracciai forte, sopraffatta non solo dalla proposta, ma da tutta la cura che aveva messo in ogni dettaglio.
Nei giorni seguenti ci siamo immersi nella nostra nuova vita: fidanzamento, convivenza con un gattino. Tutto sembrava magico.
Ma la magia, ho imparato, porta con sé anche le ombre.
Tre settimane dopo l’adozione, Misty smise di mangiare.
All’inizio pensammo fosse solo schizzinosa. Poi cominciò a nascondersi sotto il divano. Il suo fusa si affievolirono, la vivacità sparì. La portai dal veterinario con l’ansia che mi stringeva il petto.
Il medico fece degli esami e ci guardò con aria grave.
“Ha la FIP,” disse piano. “È una malattia virale molto seria. E quasi sempre letale nei gattini.”
Lo fissai, incapace di elaborare. “Ma… stava bene. Fino a pochi giorni fa.”
Annui. “Purtroppo progredisce in fretta. Probabilmente era già infetta prima di arrivare al rifugio. Esiste una cura sperimentale, ma non è facilmente accessibile.”
Tornammo a casa in silenzio. Misty si accoccolò sulle mie ginocchia, debole, ma ancora capace di fare le fusa.
Mi sembrava uno scherzo crudele del destino. Lei non era solo un animale. Era parte della nostra storia, del nostro inizio. E ora ci dicevano di prepararci a perderla?
Non potevo accettarlo.
Cominciai a informarmi, a telefonare, a cercare altri proprietari online. Continuava a spuntare un nome: Tasha, una donna in un altro stato che aveva aiutato centinaia di gatti malati di FIP ad accedere al trattamento.
La contattai. Rispose quasi subito.
Mi spiegò come funzionavano i farmaci, il dosaggio, i controlli. Sarebbero serviti 84 giorni di terapia. Costosa. Non garantita.
Ma c’era speranza.
Decidemmo di tentare.
Raccogliemmo il denaro come potevamo. Vendetti dei gioielli vintage ereditati. Dan — ora posso dirlo, si chiama Dan — prese turni extra al ristorante dove lavorava nei weekend. Gli amici ci aiutarono. Mia madre mise a disposizione parte dei suoi risparmi.
I farmaci arrivarono in una scatola anonima. Ogni giorno, alla stessa ora, le facevamo l’iniezione. Odiavo vederla soffrire, ma lentamente, quasi incredibilmente, migliorava.
Tornò l’appetito. Riprese a rincorrere la coda. A fare il “calcio da coniglio” con i giocattoli.
Al giorno 40 era quasi normale. All’84, le analisi del veterinario erano “sorprendentemente perfette”.
“Ce l’ha fatta,” disse, incredulo.
Io ci credevo, o volevo crederci. Ma tirai davvero un sospiro di sollievo solo al giorno 90, quando la vidi saltare sul davanzale e cinguettare agli uccellini come se niente fosse mai successo.
Misty aveva vinto.
Le comprammo una medaglietta a forma di cuore, incisa con “Guerriera FIP”. La portava con orgoglio.
La vita tornò stabile. Iniziammo a pianificare il matrimonio, a scegliere location e torte. Misty ci seguiva ovunque, con il suo sguardo critico da supervisore.
Poi arrivò un’altra sorpresa.
Un pomeriggio, dal veterinario, una donna anziana mi fissava mentre tenevo Misty in braccio. Alla fine mi chiese: “Scusi… ma ha adottato quel gatto dal rifugio di Oakridge?”
Annuii.
Si portò la mano alla bocca. “Credo che sia uno dei gattini che ho portato io lì…”
Rimasi senza parole.
Lei spiegò: la gatta del vicino aveva partorito sotto il suo portico. Era riuscita a catturarne due e li aveva portati al rifugio, non potendoli tenere.
“Ho sempre pensato a che fine avessero fatto,” disse commossa. “Quella piccola… sembrava un’ombra con le calze bianche.”
Sorrisi. “È lei.”
La donna accarezzò Misty con delicatezza. “Ho perso mio marito l’anno scorso. Non abbiamo mai avuto figli. Gli animali erano la nostra famiglia. Non pensavo di poterne avere un altro… ma vedervi insieme mi fa credere che fosse destino.”
Capì allora quanti fili invisibili avevano condotto quel gattino fino a noi. Quanti cuori aveva già toccato prima ancora che la incontrassimo.
Invitammo quella donna — si chiamava Lorraine — al nostro matrimonio.
Arrivò in un abito floreale e collana di perle, e pianse più di chiunque altro durante le nostre promesse. Misty, con un piccolo papillon bianco, stava seduta composta in prima fila, sulle ginocchia di mia madre.
E tra un ballo e una fetta di torta, Dan mi sussurrò: “Sai, in fondo, non è mai stato davvero solo per un gattino.”
Annuii.
Era destino. Era fede. Era amore, quello ostinato che continua a farsi strada anche quando la vita è imprevedibile e disordinata.
Quindi, se stai leggendo e ti chiedi se le cose possono davvero sistemarsi… sì, succede. Forse non come immaginavi. Forse non quando pensavi di averne più bisogno. Ma succede.
E a volte comincia con una visita inaspettata a un rifugio.
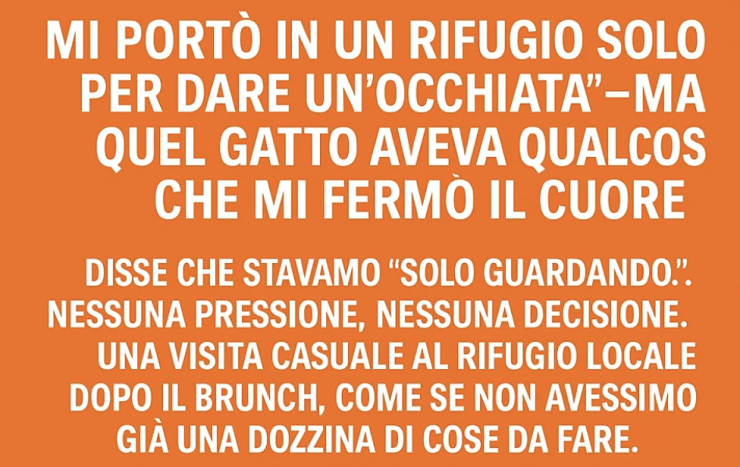
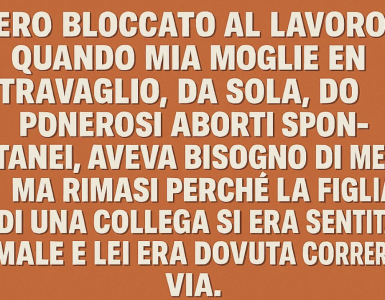
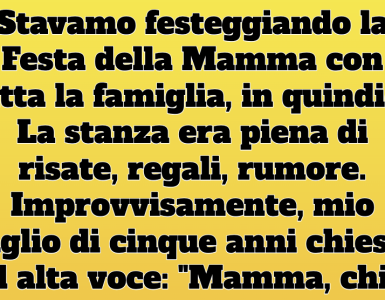

Add comment