Avevo appena assunto una nuova collaboratrice. Un giorno, alla fine del turno, suo marito venne a prenderla. Era il mio ex.
Mi limitai a salutarlo con un cenno. Nient’altro.
Il giorno dopo, la ragazza entrò nel mio ufficio, chiuse la porta con calma, si sedette di fronte alla mia scrivania, intrecciò le mani sul grembo e disse:
«Grazie per avermi assunta.»
Poi aggiunse, con voce ferma:
«So chi sei.»
All’inizio pensai parlasse in senso professionale — lavoro nel reparto HR di uno studio di architettura di medie dimensioni, e nel nostro settore è facile incrociare persone già conosciute. Ma lei sorrise, quel tipo di sorriso educato dietro cui si nasconde qualcosa di più tagliente, e aggiunse:
«Uscivi con Abed.»
Mi si gelò il sangue. Non sentivo quel nome da otto anni.
Abed ed io eravamo stati insieme per due anni, un periodo turbolento in cui amore e controllo si scambiavano i ruoli di continuo. Era finita male. Io avevo voltato pagina. O almeno così credevo.
Annuii piano. «Sì. Tanto tempo fa.»
Lei si appoggiò allo schienale e disse tranquilla:
«So tutto. Eppure ho voluto questo lavoro. Questo dovrebbe dirti qualcosa.»
Rimasi muta. La mente come scollegata dal corpo.
Si chiamava Paloma. Sui trentacinque, riservata ma sicura, con una presenza che faceva tacere la stanza quando entrava. Aveva superato brillantemente il colloquio: lauree, referenze solide, esperienza in uno studio concorrente. Un profilo perfetto.
E io l’avevo assunta.
Ora, seduta di fronte a me, mi rivelava di essere la moglie del mio ex manipolatore emotivo — e di sapere tutto del nostro passato.
«Non sono qui per creare problemi,» disse infine. «Ma credo fosse giusto parlarne faccia a faccia, così non ci saranno malintesi.»
Si alzò, lisciò la camicetta e uscì.
Per le due settimane successive non seppi cosa pensare.
La osservavo alle riunioni: brillante, precisa, un po’ intensa ma sempre professionale. Non faceva pettegolezzi, non cercava attenzioni. Anzi, era impeccabile.
Eppure mi sentivo come se camminassi a piedi nudi su vetri rotti. Ogni suo «buongiorno» mi faceva sussultare.
Un giovedì, verso fine giornata, passai accanto alla cucina del personale e la sentii al telefono. Non stavo origliando — stava praticamente gridando.
«Te l’ho detto,» diceva. «Basta, Abed. Non puoi riscrivere la storia.»
Rimasi immobile.
Mi vide. Per un istante nei suoi occhi lampeggiò qualcosa — vergogna, forse rabbia. Poi chiuse la chiamata e passò accanto a me in silenzio.
Il mattino dopo chiamò per dire che non sarebbe venuta al lavoro.
Passò una settimana. Poi un’altra.
Quando tornò, era dimagrita. Non molto, ma il viso più scavato, le spalle più tese. Portava ballerine invece dei tacchi. E non diceva più buongiorno.
Un pomeriggio mi scrisse un’e-mail: “Possiamo parlare?”
Accettai.
Questa volta non si sedette. Restò sulla soglia, le braccia incrociate.
«Avevi ragione,» disse soltanto.
Non chiesi in che senso. In parte lo sapevo già.
Mi raccontò che Abed la tradiva. Che le controllava il telefono, i messaggi, e la minacciava di “non portare le sue storie sul lavoro” — cioè da me. La situazione era degenerata, e lei si era trasferita da sua sorella due notti prima.
Non pianse. Non tremò. Parlò come se stesse leggendo un bollettino meteo.
Poi aggiunse una frase che mi è rimasta dentro:
«Pensavo di essere più furba di te. Pensavo fossi tu quella stupida per essere caduta nella sua trappola. Ma ora so che ero solo in ritardo.»
Annuii. Nient’altro.
Da quel giorno tra noi cambiò tutto. Non amicizia vera, ma rispetto. Un riconoscimento silenzioso.
Paloma rimase nello studio. Lavorava sodo. Dopo un anno venne promossa.
E fu allora che accadde l’imprevedibile.
Un lunedì mattina trovai una busta manila sulla mia scrivania. Dentro, delle fotografie stampate.
In una, Abed era a torso nudo sul balcone del mio vecchio appartamento. La data: sette anni prima, quando stavamo ancora insieme.
In un’altra, lui era con una donna sconosciuta. Mano nella mano. Stesso periodo.
Ce n’erano altre due, con la stessa donna. Paloma.
L’aveva conosciuto prima di quanto pensassi.
La chiamai nel mio ufficio.
«Non capisco,» dissi. «Perché prendere questo lavoro? Perché cercarmi?»
Lei non distolse lo sguardo.
«Avevo bisogno di chiudere un cerchio,» disse. «Non solo con lui. Con me stessa.»
Scoprii che, mentre la mia relazione con Abed stava finendo, lei era l’altra donna. Non lo sapeva all’inizio, ma quando l’aveva scoperto era rimasta.
«Mi diceva che eri pazza,» ammise. «E io gli credetti. Finché non ti ho incontrata.»
Quelle parole mi colpirono come un pugno. Non era venuta per vendetta.
Era venuta per capire.
Non provai rabbia, ma una strana pace mista a tristezza. Come se ci fossimo svegliate entrambe dallo stesso incubo.
Nei mesi seguenti diventammo davvero amiche. Non parlavamo più di lui. Non serviva. Quel capitolo era finito.
Ma la vita, a volte, fa il giro completo.
Un giovedì di pioggia, il nostro studio fu selezionato tra i finalisti per un grande progetto cittadino, la gara più importante in cinque anni.
Il presidente della commissione? Il nuovo capo di Abed.
E indovina chi Abed aveva cercato di ingannare, tentando di cambiare azienda di nascosto?
Paloma aveva tutte le prove: e-mail, messaggi, date. Tutto legale, tutto trasparente.
Consegnò tutto al nostro ufficio legale.
Solo facendo il suo lavoro.
Vincemmo l’appalto.
Non per vendetta.
Per verità.
Una settimana dopo ricevetti un messaggio su Facebook da Abed:
«Adesso fate squadra voi due? Patetiche.»
Non risposi.
Non provai neppure rabbia. Solo sollievo.
È passato più di un anno.
Paloma è ora la CFO della nostra azienda. Si è fidanzata con un uomo gentile, pacato, l’opposto dei tornado che un tempo inseguivamo.
L’ho conosciuto al suo compleanno: mi ha portato la mia bottiglia di vino preferita.
Io? Sto bene. Meglio che mai. Ho ricominciato a frequentare qualcuno, con calma, con consapevolezza. Niente fuochi d’artificio, niente drammi. Solo calore costante.
A volte la vita ti ripropone lo stesso esame due volte, per essere sicura che tu abbia imparato la lezione.
E a volte ti mette accanto la persona che ha sostenuto lo stesso esame, solo per mostrarti che non eri l’unica a soffrire.
Ecco cosa ho imparato:
La guarigione non sempre arriva nella solitudine.
A volte entra nel tuo ufficio con un paio di tacchi, ti ringrazia, e spezza con te la catena del passato.
Se hai mai dubitato della tua versione della storia, non farlo.
La verità trova sempre il modo di tornare, anche se impiega otto anni.
E se mai ti capiterà di trasformare il dolore in forza, fallo.
Perché non c’è vendetta più elegante della pace.
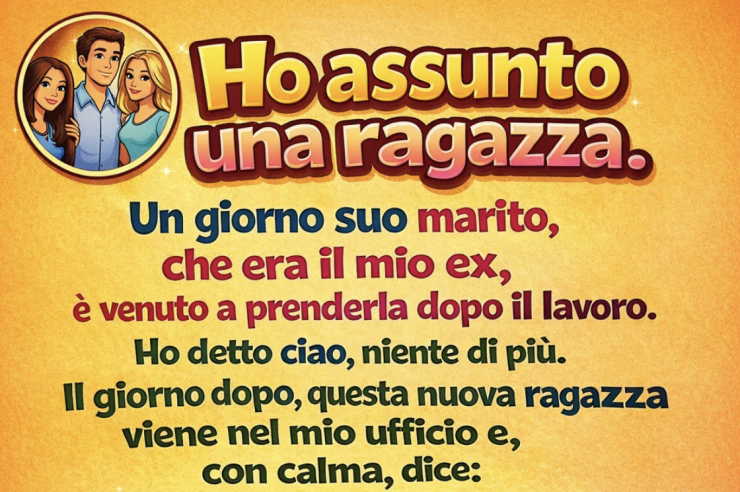

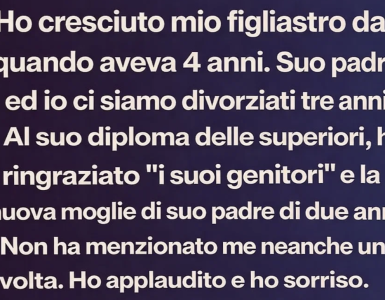
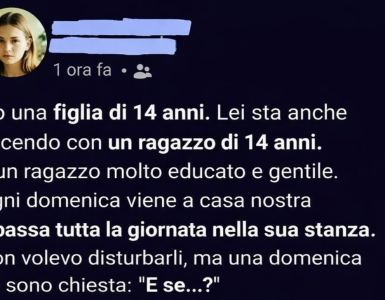
Add comment