Mio marito e io stiamo provando ad avere un bambino da tre anni e abbiamo avuto due aborti spontanei. Sua madre sa quanto sia stato difficile. La settimana scorsa, è passata con una scatola avvolta e ha detto: «Solo una piccola cosa per il futuro». Dentro c’erano un paio di minuscole scarpine fatte a mano e un biglietto che diceva: «Quando sarà il momento, lo saprai. Con amore, mamma».
Sono scoppiata in lacrime non appena le ho viste. Il tipo di pianto che ti assale di sorpresa, profondo e pieno di anni di dolore. Mio marito, Darren, mi ha stretta a sé e mi ha tenuta a lungo senza dire una parola. Non ne aveva bisogno.
Quelle scarpine sono rimaste sul camino per giorni. Non le ho mosse. Non potevo. Sembrava che se le avessi toccate, avrei portato sfortuna. Come se la speranza che portavano fosse troppo fragile per le mie mani goffe.
La mamma di Darren, Lorraine, è sempre stata un po’ un mistero per me. Gentile, ma riservata. Non era il tipo da interferire, e lo apprezzavo, ma significava anche che non sapevo mai davvero cosa pensasse. Quel regalo sembrava personale. Profondo. Come se portasse un messaggio che non avevo ancora decifrato.
Due settimane dopo, avevo un appuntamento dal medico, solo un controllo di routine. Ho pensato di annullarlo. A che serviva? Un altro specialista, un altro consiglio di «rilassarsi e lasciare che accada naturalmente», come se lo stress fosse il motivo per cui il mio corpo non riusciva a tenere un bambino.
Ma ci sono andata. Soprattutto perché Darren me l’ha implorato. Ha detto: «Escludiamo solo qualcosa di nuovo, va bene? Per tranquillità».
All’appuntamento, la mia ginecologa, la dottoressa Patel, ha fatto le solite domande. Poi si è fermata, ha sfogliato di nuovo la mia cartella e ha detto qualcosa che non mi aspettavo.
«Abbiamo mai fatto test approfonditi su Darren?».
Ho sbattuto le palpebre. «Ha fatto un controllo base di fertilità due anni fa».
Ha annuito piano. «Raccomando un’analisi più avanzata. Le cose cambiano. E a volte, ciò che pensiamo sia a posto… non lo è».
Sono uscita con un misto di irritazione e curiosità. Darren? L’uomo che poteva correre per cinque miglia senza sudare. Come poteva essere lui il problema?
Ma quella sera, a cena, gliel’ho detto. Con mia sorpresa, ha accettato subito. «Me lo stavo chiedendo anch’io», ha detto. «Forse non è solo il tuo corpo a essere stanco».
Abbiamo fissato il test. Ci è voluta una settimana per i risultati. Quella settimana è passata più lenta di una lumaca in vacanza.
Quando finalmente ci siamo seduti di nuovo nell’ufficio della dottoressa Patel, aveva un’aria seria. Non spaventosamente seria, ma gentilemente seria.
«I risultati mostrano una condizione chiamata frammentazione del DNA», ha detto. «Significa che il DNA degli spermatozoi di lui si rompe più del dovuto. Questo potrebbe spiegare gli aborti spontanei».
L’ho fissata, incerta se provare sollievo, panico o qualcosa nel mezzo.
«Si può sistemare?» ha chiesto Darren.
«A volte sì. Cambiamenti nello stile di vita. Antiossidanti. Ma avete anche opzioni: FIVET con ICSI, sperma di donatore, adozione».
Il mio cervello si è bloccato a «sperma di donatore». Sembrava una crepa nel terreno che non avevo visto arrivare.
Quella notte, Darren e io siamo rimasti seduti in silenzio sul divano. Le scarpine erano ancora sul camino come piccoli fantasmi.
«Ho sempre pensato che fossi tu», ha sussurrato. «Non ho mai nemmeno immaginato che potesse essere io».
Gli ho preso la mano. «Non importa. Siamo noi. Sempre noi».
Ha annuito, deglutendo a fatica. «Non voglio solo continuare a guardarti soffrire. È come se ti stessi deludendo e facendoti patire allo stesso tempo».
Non ne abbiamo più parlato per qualche giorno. Poi una sera, Lorraine mi ha chiamata. Solo me, non Darren.
«Volevo chiederti se vieni per un tè», ha detto. «Solo tu. Volevo parlarti di una cosa».
Ho accettato, incerta se stessi andando verso conforto o confronto.
La sua casa odorava di cannella e libri vecchi. Mi ha fatto sedere nella veranda e ha versato camomilla in due tazze scompagnate.
«So che le cose sono state pesanti», ha detto. «E so che tu e Darren non mi dite sempre tutto. Va bene. Non ho bisogno di sapere tutto».
Ho annuito, incerta dove volesse arrivare.
«Ma voglio dirti una cosa. Qualcosa che non ho mai detto nemmeno a Darren».
Le mie sopracciglia si sono inarcate.
«Ho avuto cinque aborti spontanei», ha detto piano. «Tutti prima di Darren. Pensavo di essere maledetta. O rotta».
L’ho fissata, stupefatta. Non parlava mai del suo passato, figuriamoci di una cosa del genere.
«Poi un giorno, a 39 anni e avendo rinunciato, sono rimasta incinta di Darren. E lui è rimasto. Ce l’ha fatta».
Ho sentito gli occhi pizzicare. «Non gliel’hai mai detto?».
«No. Non volevo che crescesse sentendosi un miracolo di cui non potevo fare a meno. Dovevo lasciarlo solo… essere lui».
Ha sorseggiato piano il tè. «Ma devi sapere che la speranza non sparisce. Cambia solo forma».
Quando sono tornata a casa, ho raccontato tutto a Darren. È rimasto lì con la bocca leggermente aperta.
«Ha passato quello… da sola?» ha chiesto.
«Sì».
È come se qualcosa si fosse spostato tra noi dopo quello. Come se la pressione si fosse allentata un po’. Non stavamo più combattendo una guerra silenziosa: avevamo alleati. Avevamo prospettiva.
Abbiamo deciso di provare un altro ciclo di FIVET. Questa volta con una dieta migliore, integratori per Darren, meno ossessione. Più gentilezza.
E questa volta ha funzionato.
Ero alla settima settimana quando ho visto il battito fetale tremolare. Ho stretto la mano di Darren così forte che le dita mi si sono intorpidite.
Non abbiamo detto niente a nessuno ancora. C’eravamo già passati. Troppo speranzosi, troppo presto. Ma ogni settimana passava, e il bambino restava.
Alla dodicesima settimana, abbiamo finalmente detto tutto a Lorraine. Non ha pianto, ha solo sorriso quel sorriso dolce che sfoggiava quando qualcosa importava troppo per dirlo ad alta voce.
Alla sedicesima, abbiamo scoperto che era una femmina.
Alla ventesima, ho iniziato a sentirla scalciare, piccoli colpetti all’inizio, come se bussasse educatamente.
E poi alla ventiquattresima settimana, mi sono svegliata con un’emorragia.
Siamo corsi in ospedale, cuori in gola.
Il medico ci ha detto di stare calmi. Potevano fermare il travaglio se l’avessero preso presto.
Ma quella notte, nella quiete della stanza d’ospedale, l’ho sentita di nuovo. Un calcio forte, desafiante.
E poi tutto si è fermato.
Niente dolore. Niente sanguinamento. Solo quiete.
Un’ecografia ha confermato ciò che sembrava troppo bello per essere vero: stava bene. Rannicchiata, battito forte.
Mi hanno tenuta in osservazione per una settimana. Ho contato ogni ora. Ogni bip del monitor sembrava un inno.
Alla fine mi hanno dimessa, dicendo di riposare ed evitare stress. Che era esilarante, perché lo stress era ormai un compagno fisso.
Ma ce l’abbiamo fatta.
Trentotto settimane dopo, ho dato alla luce una bimba rossa in viso, urlante, perfetta, che abbiamo chiamato Elsie Hope.
Lorraine è stata la prima a tenerla dopo di noi. Ha infilato le scarpine nella culla di Elsie e ha detto: «Penso che abbia aspettato abbastanza per indossarle».
Abbiamo tutti pianto.
Ma ecco la svolta che non mi aspettavo.
Due mesi dopo la nascita di Elsie, ho trovato una busta nella posta. Senza francobollo, solo i nostri nomi scritti nella calligrafia tremolante di Lorraine.
Dentro c’era una lettera. Diceva:
«Se stai leggendo questo, significa che ce l’avete fatta. E io probabilmente non sono lontana dall’addormentarmi per sempre in questo mondo. Ho fatto degli esami che non vi ho detto. C’è un tumore, ed è avanzato. Non volevo aggiungere preoccupazioni alla vostra gioia. Ma dovevo dirvi una cosa…»
Le mie mani tremavano mentre leggevo.
«…quelle scarpine non erano per Elsie. Le ho fatte trent’anni fa per il bambino che non ho mai incontrato. Non sono mai riuscita a buttarle. E poi un giorno ho realizzato: forse non erano destinate al mio bambino. Forse erano sempre state per il vostro».
L’ho riletta tre volte. Poi mi sono seduta e ho pianto più forte del giorno in cui è nata Elsie.
Lorraine è morta poche settimane dopo. Pacificamente, nel sonno. Elsie era tra le mie braccia al funerale, con un cappellino che Lorraine aveva fatto.
Abbiamo seppellito la lettera con lei. Ma ho tenuto le scarpine.
Elsie ha quasi due anni ora. Le trascina in giro come una bambola. Abbiamo provato a nasconderle perché non si rovinino, ma lei le trova sempre.
Le chiama «scarpe della nana».
E a volte, quando il mondo sembra pesante, mi siedo con lei in grembo, la sua manina stretta intorno al mio dito, e le racconto della donna che ha sferruzzato speranza con dita tremanti. Che ha creduto in un futuro che non avrebbe visto.
Pensavo che la speranza fosse un sentimento. Ma ora so che è un’azione. Una maglia. Un passo avanti. Una scelta.
A chiunque stia ancora aspettando, ancora sperando: vi vedo. Vi conosco. E prometto: la vostra storia non è finita.
Se questa storia vi ha toccato, per favore mettete like e condividete. Non sapete mai chi potrebbe aver bisogno di un po’ di speranza oggi.
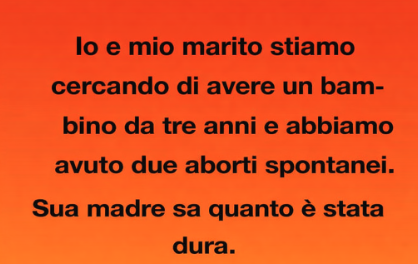
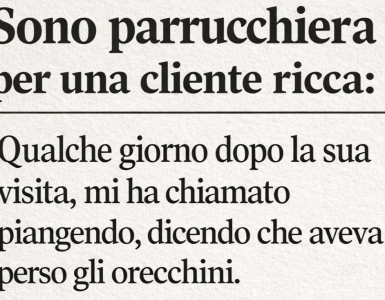


Add comment