La demenza di papà non era più solo dimenticare i nomi. Era diventata qualcosa di molto più pericoloso.
Mi svegliavo alle due di notte con l’odore di gas, perché aveva lasciato i fornelli accesi. Due volte i vicini mi hanno chiamata: l’avevano trovato in pantofole per strada, a chiedere a degli sconosciuti come tornare a casa—quando era a tre case dalla nostra. A volte pensava fosse il 1985. Altre volte non sapeva chi fossi.
Avevo il terrore di lasciarlo solo, ma non potevo stare con lui ogni secondo. Ero esausta, a pezzi, sempre sull’orlo. Così ho fatto ciò che pensavo facesse una famiglia: ho chiamato mio fratello e mia sorella.
Anzi, li ho implorati.
Chiesi se potevamo fare a turni per restare da lui di notte. Se potevano contribuire alle spese per un’assistenza domiciliare. Se potevano anche solo passare a tenergli compagnia qualche ora, così da potermi fare una doccia, dormire senza paura, respirare.
Spiegai tutto: quanto avevo paura, quanto la situazione fosse diventata pericolosa, quanto mi sentissi incapace di proteggerlo.
Mi hanno liquidata.
“Stai esagerando,” disse mia sorella.
“Papà è sempre stato smemorato,” aggiunse mio fratello.
“Vivi più vicino. Te la caverai.”
E basta. Nessun piano. Nessun aiuto. Solo l’aspettativa silenziosa che, essendo la più vicina, dovessi assorbire tutto io.
Così presi la decisione più difficile della mia vita.
Misi papà in una casa di riposo.
Non lo feci a cuor leggero. Visitai strutture, feci mille domande, piansi nei parcheggi. Il giorno in cui firmai i documenti, mi tremavano tanto le mani che a malapena riuscivo a tenere la penna. Mi sentivo come se lo stessi tradendo, anche se ogni parte razionale di me sapeva che lo stavo proteggendo.
Quando i miei fratelli lo seppero, esplose il caos.
Mia sorella mi urlò contro, mi chiamò mostro. Mio fratello disse che avevo “abbandonato” nostro padre come fosse un peso indesiderato. Parlavano di lealtà e famiglia, come se non fossi stata io a spegnere padelle bruciate e rispondere alle chiamate notturne. Le loro parole mi avvelenarono. Piansi per giorni, chiedendomi se davvero avevo scelto la via più comoda. Se avevo fallito l’uomo che ci aveva cresciuti.
Poi, una settimana dopo, il telefono squillò.
Era la casa di riposo.
La voce dell’infermiera sembrava sorpresa—quasi entusiasta.
Mi disse che papà stava mangiando pasti completi per la prima volta da mesi. Dormiva tutta la notte. Aveva iniziato a scherzare con gli altri ospiti, partecipava alle attività, canticchiava durante l’ora di musica.
Si fermò un attimo, poi disse con dolcezza:
“Non vediamo spesso miglioramenti così rapidi.”
Mi sedetti sul letto e scoppiati a piangere. Ma stavolta non per il senso di colpa. Per sollievo.
Nel frattempo, i miei fratelli improvvisamente volevano andare a trovarlo. Chiedevano l’indirizzo come se solo allora la situazione fosse diventata reale. Quando finalmente arrivarono, mi trattavano ancora da colpevole.
Nel corridoio dicevano sottovoce che “non era necessario” portarlo lì. Che “papà sarebbe stato bene a casa.” Che “avevo esagerato.”
Intanto, papà era nella sala comune, che rideva con un’infermiera, raccontava per la seconda volta la stessa barzelletta e si applaudiva da solo.
Il contrasto era surreale.
Lo vedevo rifiorire in un posto pensato per tenerlo al sicuro. E ascoltavo persone che non avevano mosso un dito accusarmi di aver fatto qualcosa di imperdonabile.
Ora vivo in questo strano equilibrio tra senso di colpa e pace.
Mi manca ogni giorno.
Mi domando ancora, nei momenti di silenzio, se ho fatto la scelta giusta.
Ma poi penso che ora lui non può più uscire di casa di notte.
Non rischia più di bruciarla.
E io riesco a dormire.
Forse la vera domanda non è se ho fatto bene o male.
Forse è se prendersi davvero cura di qualcuno significa anche accettare di essere fraintesi—soprattutto da chi non ha mai fatto lo stesso.
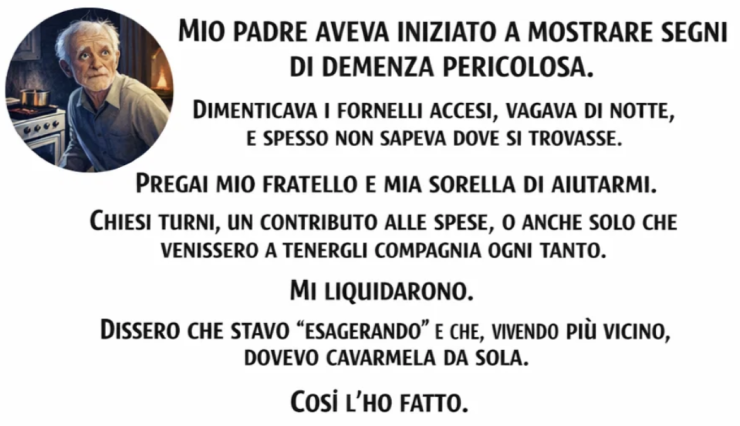



Add comment