Avevo solo undici anni quando i nostri genitori morirono. Nessun nonno, nessun zio, nessuna famiglia allargata. Solo mia sorella.
Aveva appena vent’anni — una studentessa universitaria con sogni, ambizioni e una vita davanti — ma il giorno in cui i nostri genitori se ne andarono, fece le valigie, lasciò il dormitorio e tornò a casa.
Da quel momento, divenne tutto per me.
Rinunciò al suo futuro perché io potessi averne uno.
Lavorava due turni, teneva in piedi la nostra piccola casa e mi amava attraverso ogni crisi, ogni brutto voto, ogni incubo.
Quando compii diciotto anni e partii finalmente per l’università, dentro di me qualcosa cambiò.
Volevo libertà — quella che credevo tutti gli altri avessero.
Mia sorella mi chiamava ogni mattina, ogni sera.
Mi chiedeva se avessi mangiato, se stessi dormendo abbastanza.
E invece di ringraziarla… le urlai contro.
«Smettila di chiamarmi! Fatti una vita!»
Dall’altro capo del telefono, silenzio.
Avrei dovuto capire, ma riattaccai, fingendo che non mi importasse.
Lei non chiamò più. Per settimane.
Pensai fosse arrabbiata. Che avesse bisogno di tempo.
Non ci riflettei oltre.
Arrivò la pausa di primavera. Tornai a casa immaginando di trovarla ai fornelli o davanti alla TV.
Invece, la porta d’ingresso era spalancata, che oscillava piano nel vento.
Il cuore mi balzò in gola.
Dentro, la casa era quasi vuota.
Pareti spoglie. Mobili mancanti. Scatoloni negli angoli.
Mi mancò il respiro.
Corsi dalla nostra vicina e bussai con tutta la forza che avevo.
Lei aprì, lo sguardo pieno di pietà.
«Non… non lo sai?» sussurrò.
Il mondo mi girò intorno.
Mi raccontò che mia sorella era crollata settimane prima.
Si sentiva debole da tempo, ma aveva ignorato i sintomi finché non riuscì più a stare in piedi.
All’ospedale le diagnosticarono una malattia autoimmune.
Le cure erano costosissime. Così aveva venduto i mobili, uno alla volta, solo per poter pagare le medicine che la tenevano in vita.
La vicina l’aveva aiutata come poteva.
Sentii il respiro spegnersi nei miei polmoni.
Corsi in ospedale, le lacrime che mi offuscavano la vista.
Quando la vidi — pallida, stanca, ma ancora lei, la mia sorella coraggiosa — crollai.
Le cinsi il viso tra le mani e singhiozzai:
«Mi dispiace tanto. Sono qui. Non me ne vado più.»
Lei sorrise appena e mi strinse la mano con dolcezza.
È tutto ciò che ho al mondo.
E ora so che l’ho quasi persa per colpa della mia cecità, della mia egoistica voglia di libertà.
Prego solo che un giorno possa perdonarmi.

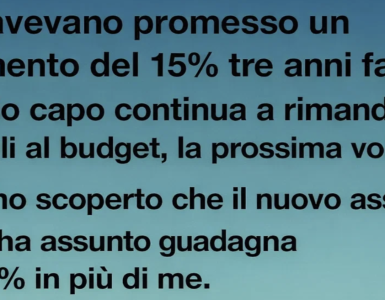
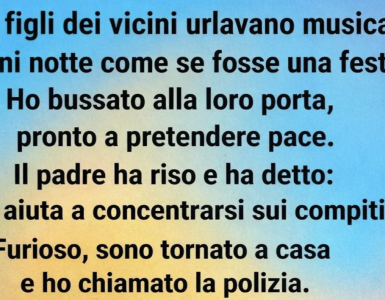
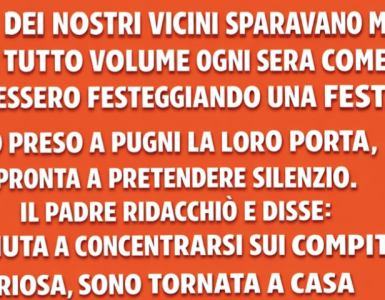
Add comment