Quando mi sono trasferita nel mio nuovo appartamento, la sensazione predominante fu il sollievo.
Nuova città, nuovo lavoro, un nuovo inizio. L’appartamento era piccolo, ma era mio. Silenzioso, pulito, prevedibile—o almeno così credevo.
La prima settimana, iniziarono i colpi alla porta.
Ogni sera, senza eccezioni, alle 21:15 in punto. Tre colpi secchi. Pausa. Altri due.
La prima volta che aprii, davanti a me c’era una signora anziana, leggermente curva, i capelli grigi raccolti in uno chignon stretto. Occhi acuti, irrequieti.
«La tua musica è troppo alta», disse.
«Non stavo ascoltando musica», risposi confusa.
Aggrottò la fronte, mormorò qualcosa tra sé e se ne andò.
La sera successiva, bussò di nuovo. Stessa ora. Stavolta mi chiese se avevo visto un gatto randagio—che non esisteva. La notte seguente si lamentò dei passi sopra il soffitto—peccato che io abitassi sotto di lei.
Alcune sere faceva domande assurde: La posta è arrivata in anticipo? L’ascensore funziona strano? Senti odore di gas?
Se non rispondevo subito, non se ne andava. Continuava a bussare. Ancora e ancora.
Provai a ignorarla. A restare immobile nel buio, trattenendo il respiro come un bambino che si nasconde. Ma lei sapeva sempre che ero lì.
All’inizio, provavo compassione. Poi fastidio. Infine rabbia.
Lavoravo tutto il giorno. Tornavo a casa stanca, mentalmente e fisicamente. Quella bussata serale divenne l’incubo che temevo di più. Mi sembrava invadente, quasi ossessiva. Come se pretendesse la mia attenzione ogni sera.
Mi sfogai con gli amici. «È solo sola», dicevano. «Ignorala.» Ma non ci riuscivo. Lei non me lo permetteva.
Una sera, esplosi.
Era stata una giornata orribile. Il capo mi aveva umiliata. Il treno in ritardo. Pioveva a dirotto e avevo i piedi zuppi. Tutto ciò che volevo era silenzio.
Alle 21:15, arrivò il solito colpo.
Qualcosa in me si spezzò.
Aprii la porta prima che bussasse ancora. Stava per parlare, ma la interruppi.
«Perché continui a farlo?» dissi con la voce tremante. «Perché mi tormenti ogni sera? Ti lamenti per cose che non esistono, inventi storie e non mi lasci in pace. Io non ti ho fatto niente.»
Le si aprì la bocca, poi si richiuse.
«Io vivo qui», continuai. «Sono stanca. Lavoro tutto il giorno. Non è mio dovere farti compagnia. Non è colpa mia se ti senti sola. E forse, se non fossi così fastidiosa, non lo saresti.»
Silenzio.
Non replicò. Non si difese. Mi guardò a lungo, con gli occhi lucidi, poi abbassò lo sguardo. Si voltò lentamente e tornò nel suo appartamento, senza dire una parola.
Chiusi la porta, col cuore che martellava. La colpa già saliva, ma l’orgoglio la ricacciava giù.
Il giorno dopo, mentre uscivo per andare al lavoro, l’amministratore del palazzo mi fermò vicino alle cassette della posta. Un uomo anziano, sempre gentile.
«Ho saputo di ieri sera», disse con tono pacato.
Il cuore mi sprofondò. «Mi dispiace se abbiamo fatto rumore.»
Scosse la testa. «Lei non è arrabbiata. Ma volevo solo dirti una cosa.»
Fece una pausa, cercando le parole giuste.
«Ogni sera, lei aspetta vicino alla porta. Succede da anni. Da quando, qui, c’è stato un brutto episodio—una ragazza giovane che viveva da sola… non è mai tornata a casa una sera.»
Sentii un nodo in gola.
«Lei ha notato la tua routine», continuò. «Che torni tardi. E bussa ogni sera alla stessa ora per essere sicura che tu sia tornata sana e salva. Aspetta di sentire la tua voce. È tutto ciò che ha sempre voluto.»
Non riuscivo a parlare.
«Non le importa del rumore», disse piano. «Voleva solo sapere che stavi bene.»
Quella sera, non ci fu nessuna bussata.
E, in qualche modo, quel silenzio fece più male del rumore.
Da allora, non ho mai più sentito un colpo alla porta nello stesso modo.
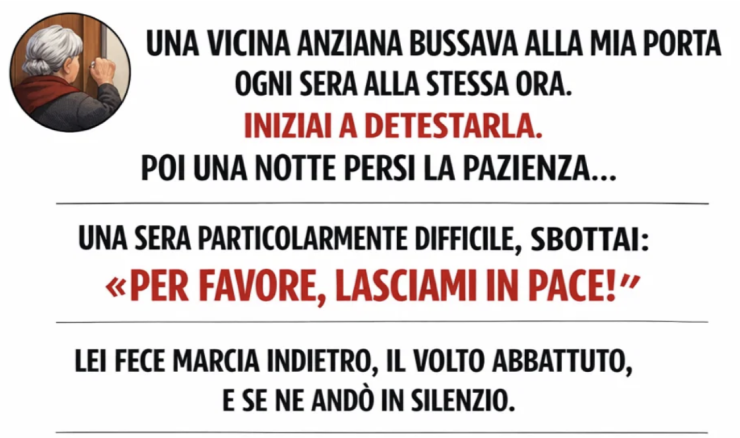



Add comment