Avevo proposto a mia sorella di occuparmi di mia nipote per il weekend, così potesse riposare. Entro la domenica, la bambina non aveva detto una sola parola: fissava soltanto la mia foto di matrimonio. Quella sera, mentre la rimboccavo a letto, mi sussurrò:
«So dove va, quando tu dormi».
Rimasi paralizzata, il cuore in gola. «Chi?» chiesi.
Lei indicò mio marito.
All’inizio risi. O forse provai a farlo. Ma uscì una risata strana, secca. Zaina, la mia nipotina di sei anni, poteva semplicemente dire cose inquietanti come fanno molti bambini… giusto?
Eppure, quella notte non chiusi occhio. Rimasi sdraiata a fissare il soffitto, lanciando sguardi furtivi a Raj, mio marito da otto anni, che dormiva serenamente accanto a me. Bocca leggermente aperta, respiro lento. Un’immagine di pace e innocenza. Ma il tono di Zaina non lasciava spazio a giochi o fantasie: era un’osservazione fredda, precisa. Come se avesse visto un insetto in cucina.
La mattina dopo le portai i cereali e, con dolcezza, le chiesi: «Che cosa intendevi ieri sera, tesoro?»
Lei scrollò le spalle e affondò il cucchiaio nella ciotola. «Lo vedo. Esce dalla porta sul retro. Si mette scarpe diverse.» Poi alzò lo sguardo e aggiunse: «E un cappello.»
Il boccone mi si fermò in gola. Raj teneva davvero un cappellino da baseball e un paio di scarpe da ginnastica vicino alla porta sul retro, ma non lo avevo mai visto uscire di notte. Diceva di odiare correre al buio.
Provai a scacciare l’idea. Forse aveva sognato. O confuso qualcosa. Ma quella sera, dopo aver messo a letto Zaina, rimasi sveglia. Finsi di dormire, un occhio aperto sotto le coperte. Verso le 2:10, Raj si sollevò lentamente.
Nessun rumore. Solo un movimento fluido, abituale. Posò i piedi a terra, si alzò e andò dritto all’armadio. Indossò jeans e una maglietta scura. Poi uscì dalla stanza.
Sentii il lieve clic della porta sul retro.
Rimasi immobile per due minuti buoni, il cuore che martellava così forte che temevo Zaina potesse sentirlo dalla stanza degli ospiti. Alla fine mi alzai, andai in cucina e sbirciai dalle tende.
Raj stava camminando lungo il vicolo dietro casa. Non correva. Non faceva jogging. Camminava, come se sapesse esattamente dove andare.
Quella notte non lo affrontai. Mi convinsi di aver frainteso. Forse non riusciva a dormire e voleva fare due passi. Ma accadde di nuovo la notte dopo. E quella successiva.
Non dissi nulla a mia sorella — non sapevo nemmeno cosa stessi insinuando. Tradimento? Spaccio? Sonnambulismo? Niente sembrava combaciare con Raj: metodico, prevedibile, ingegnere. Il tipo che fa liste per le proprie liste.
Il martedì, dopo che Zaina era tornata a casa, montai una piccola telecamera con visione notturna vicino alla porta sul retro. Gli dissi che era per “sicurezza”, nel caso i procioni tornassero a rovistare tra i rifiuti.
Quella notte, alle 2:07, Raj fece la stessa cosa. Si alzò. Si vestì. Uscì. Io lo vidi in diretta sul telefono.
La mattina dopo lo affrontai.
Lui si bloccò, la forchetta sospesa a mezz’aria. «Cosa intendi, che sono uscito?»
Gli mostrai il filmato. Lo guardò come se fosse uno scherzo.
«Non è possibile. Non me lo ricordo.» La sua voce era bassa.
La sua reazione non sembrava falsa. Sembrava… spaventata.
«Ultimamente sono esausto» aggiunse. «Come se dormissi, ma non mi riposassi. E se fosse sonnambulismo?»
Gli prenotai subito una visita medica.
La clinica del sonno aveva tempi lunghi, ma gli diedero un monitor portatile da indossare. Montammo anche una telecamera in camera da letto. Io iniziai a tenere un diario.
Tre notti dopo, qualcosa cambiò.
Invece di uscire dal retro, Raj si fermò in cucina a fissare il vuoto. Poi aprì il frigo, prese una bottiglia d’acqua e andò in garage.
Lo seguii dalla finestra di sopra. Entrò in macchina e partì.
Non resistetti: salii in auto e lo seguii.
Guidò per una decina di isolati, parcheggiò vicino a un centro commerciale e entrò in una lavanderia a gettoni aperta 24 ore.
Niente di sospetto. Nessuno ad attenderlo. Si sedette su una sedia di plastica e fissò le asciugatrici per mezz’ora. Poi tornò a casa.
Il giorno dopo, quando glielo dissi, era incredulo. Non ricordava nulla. Non era mai stato in quella lavanderia. Il monitor mostrava attività cerebrale elevata proprio in quell’orario.
Eravamo entrambi scossi. Gli feci promettere di non guidare più di notte finché non avessimo avuto risposte. Accettò.
Ma non finì lì.
Una settimana dopo, mia sorella mi chiamò, la voce tesa. «Zaina ha disegnato qualcosa a scuola. La maestra ha chiamato.»
Mi mandò una foto: un disegno a pastelli. Il mio salotto. Il divano, il tappeto. Una figura stilizzata (io) addormentata sul divano. Un’altra figura (Raj) in piedi vicino alla porta, con un cappello.
Dietro di lui, in rosso, un’ombra alta con occhi enormi.
«Zaina dice che l’uomo porta l’ombra a casa» sussurrò mia sorella.
Mi sentii male.
Da quel momento, Raj non dormì più da solo. Io restai sveglia ogni notte, registrando tutto. Ma sulle riprese si vedeva solo lui che camminava. Gli occhi vuoti.
Finché una notte cedetti: «Non posso vivere così. Che diavolo sta succedendo?»
Si lasciò cadere a terra come un bambino e disse qualcosa che non dimenticherò mai:
«Quando avevo dodici anni, sonnambulavo. Una volta mia madre mi trovò in cucina con un coltello in mano. Fermo, immobile. Da allora tolse ogni oggetto affilato. Poi sembrò passare.»
Chiamai subito sua madre. Confermò, ma esitò quando chiesi: «Ha mai ferito qualcuno?»
Silenzio. Poi: «Una volta. Graffiò suo cugino nel sonno. Abbastanza da farlo sanguinare. Dicemmo che era stato il gatto.»
Raj non ricordava nulla. Ma la sua espressione quando glielo dissi… era come vedere una diga rompersi.
Tornammo alla clinica del sonno. Questa volta fecero test più approfonditi. Diagnosi: episodi dissociativi notturni. Non sonnambulismo classico, ma qualcosa di più raro. Un misto di trauma, stress e forse… memoria repressa.
Il medico chiese: «Vivete nella casa dove è cresciuto?»
No.
«È tornato recentemente in un luogo legato a un ricordo forte?»
Fu allora che capii. Quella lavanderia.
Un tempo era un negozio di giocattoli. La madre di Raj lo aveva menzionato una volta, per caso.
Quando glielo dissi, Raj crollò in ginocchio fuori dalla clinica e pianse. Ricordò. Non tutto, ma abbastanza: quella cugina lo rinchiudeva negli armadi per scherzo. Lo derideva al buio. I genitori non lo seppero mai. Lui aveva rimosso tutto.
Tornare in quel posto aveva riaperto la ferita.
Dopo mesi di terapia e monitoraggi, gli episodi si fermarono. Lentamente, poi del tutto.
In estate, Zaina tornò a trovarci. Facemmo pancake. Guardammo cartoni. Indicò di nuovo la foto del matrimonio, ma stavolta rise: «Zio Raj sorride troppo, lì.»
Le chiesi, mesi dopo, cosa fosse “l’ombra”.
«Seguiva zio Raj quando era triste di notte. Ma è andata via quando tu non hai più dormito da sola.»
Quella frase ancora oggi mi fa venire i brividi.
Ma le credo.
A volte le parti più oscure di noi non scompaiono: aspettano. La crepa giusta. Il momento giusto.
La parte bella? Se le affrontiamo — con verità, amore e sostegno — possono andarsene.
Siamo stati fortunati. E ora Raj non è solo guarito: è più aperto, più sensibile. Ha persino chiamato quella cugina. Non per accusarla, ma per dire che ricordava. E che la perdonava.
Lei non se ne ricordava neppure.
Il perdono non è fingere che nulla sia accaduto. È decidere che non avrà più potere su di te.
Quindi sì. Avevo offerto di badare a mia nipote, pensando di fare un favore a mia sorella.
Ma forse Zaina ha salvato noi.
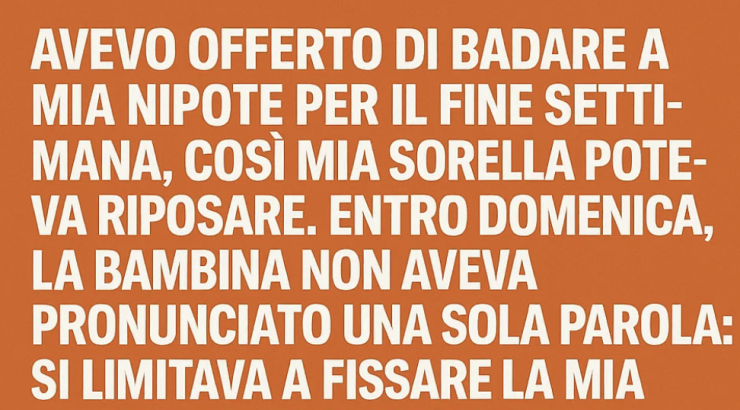



Add comment