Ero a Parigi in viaggio da sola, camminavo senza meta vicino a una stazione della metro, quando notai un ragazzo con il cappuccio che mi seguiva. Continuava a guardarsi alle spalle, come se controllasse qualcuno. Prima che potessi capire, mi si avvicinò e disse: “Sei un’idiota.”
Rimasi di sasso. Pensai si stesse rivolgendo a un altro, ma no—mi fissava dritta negli occhi, come se avessi fatto qualcosa di sbagliato. Stavo per rispondergli, magari insultarlo o chiedergli che problema avesse, quando mi afferrò per un braccio e mi trascinò di lato verso un vicolo.
Non ero ingenua: sono cresciuta a Johannesburg, dove impari presto a non fidarti degli sconosciuti che ti toccano per strada. Provai a divincolarmi, pronta a urlare, ma lui abbassò la voce e disse: “Ascolta, fidati per cinque secondi. Vedi quell’uomo dall’altra parte della strada? Ti segue da tre isolati. Non è un turista.”
Guardai oltre la sua spalla e lo vidi: un uomo con una giacca di pelle che fingeva di leggere una mappa, ma teneva gli occhi puntati su di me. Il sangue mi gelò.
Il ragazzo con il cappuccio—che poi scoprii si chiamava Noam—aveva forse poco meno di trent’anni, barba incolta e un’energia nervosa ma attenta. Mi guidò lungo una strada laterale, camminando come se fossimo amici.
“Continua a muoverti e, per l’amor di Dio, sorridi come se stessimo parlando di formaggi”, mi sussurrò.
Così parlammo di formaggi. O meglio, lui pronunciava nomi—Camembert, Brie, Mimolette—e io annuivo come se stessimo avendo la conversazione più divertente della mia vita. L’uomo in giacca di pelle esitò, poi sparì.
Quando fummo lontani dalla metro, Noam si fermò sotto un portico di un fioraio. “Non dovresti andare in giro da sola con quella macchina fotografica in bella vista,” disse guardando la mia borsa. “È come avere un faro addosso.”
La macchina era una Leica vintage di mio zio, ereditata poco prima del viaggio. Valeva più di tutti i miei bagagli messi insieme. Lui avrebbe potuto prenderla, ma non lo fece.
Invece si offrì di accompagnarmi al museo dove stavo andando. Esitai, poi accettai: la sua voce non era insistente, solo premurosa.
Durante la passeggiata, scoprii che non era francese: marocchino-israeliano, nato a Haifa, studiava architettura a Lione ed era a Parigi solo per una settimana. Mostrava dettagli che non avevo mai notato: incisioni sui muri, graffiti particolari, un caffè nascosto sotto un arco di pietra.
Il museo era chiuso per sciopero—classico. Ma non mi importò. Finimmo seduti sui gradini di una fontana, bevendo Orangina in bottiglia di vetro e raccontandoci storie di viaggio. Io parlai di mio zio, lui dei nani da giardino di sua madre e dei disastri culinari di suo padre. Sembrava lo conoscessi da molto più di un’ora.
Quella sera ci rivedemmo a Montmartre, in un ristorante senza insegna, frequentato solo da locali. Condividemmo un confit de canard e una crème brûlée. Era tutto semplice, naturale. Sicuro.
Nei giorni seguenti continuammo a “incontrarci per caso”: musei, librerie, caffè. Ogni volta sorrideva fingendo di studiare un menu o di osservare un piccione. Era un gioco, ma anche qualcosa di più.
Poi arrivò il giovedì. Avevo programmato una gita a Versailles. Lui si offrì di venire, ma dissi che avevo bisogno di stare sola. Sorrise: “Scrivimi se cambi idea.” Non lo feci.
Quando tornai a Parigi, esausta, trovai la porta del mio appartamento socchiusa. Sapevo di averla chiusa. Il cuore in gola, scesi in strada. Dopo minuti interminabili al telefono con la polizia, chiamai Noam.
Arrivò in dieci minuti. Dentro l’appartamento regnava il caos: valigia aperta, cassetti rovesciati, armadio svuotato. La mia Leica non c’era più. Mi sedetti a terra trattenendo le lacrime.
“Poteva andare peggio,” disse piano. “Non eri qui. Questo è ciò che conta.”
Si trattava di una banda che seguiva i turisti dai post su Instagram. La polizia non fu d’aiuto, il padrone di casa nemmeno. Ma Noam rimase accanto a me: compilò la denuncia, litigò col proprietario in francese, e mi comprò una vecchia macchina fotografica in un negozio di usato. “Non è la stessa cosa, ma magari scatterai foto migliori con questa,” disse, arrossendo.
Due giorni dopo, accadde l’impensabile. Camminando vicino alla metro dove ci eravamo conosciuti, Noam mi afferrò il braccio: “È lui.”
Il tipo con la giacca di pelle.
Noam lo seguì di nascosto per due isolati e scattò alcune foto con il cellulare. Le consegnammo alla polizia: si trattava di un borseggiatore recidivo. Non recuperarono la mia Leica, ma due settimane dopo mi chiamarono: avevano trovato la borsa di mio zio in un banco dei pegni. Dentro c’era ancora un rullino.
Sviluppandolo, vidi immagini di mio zio con persone sconosciute: una donna sorridente, un bambino sulle spalle, una Parigi diversa, intima. Sul retro di una foto, una scritta sbiadita:
“L’amore è una città che costruisci con qualcun altro.”
Mostrai la foto a Noam in videochiamata. Era tornato a Lione, ma continuavamo a sentirci. Un anno dopo venne a trovarmi in Sudafrica. Due anni dopo tornammo insieme a Parigi—senza macchina fotografica, solo con ricordi.
Avevo iniziato quel viaggio pensando di cercare me stessa. Invece trovai qualcuno che mi fece sentire al sicuro, che mi insegnò a prestare attenzione.
A volte, chi ti scuote la vita non cerca di impressionarti. Ti sta semplicemente proteggendo.
E a volte, perdere qualcosa di prezioso ti porta tra le braccia di qualcosa di ancora migliore.
Se viaggiate soli, fidatevi del vostro istinto—ma non abbiate paura di farvi sorprendere.
E chissà, magari chi vi chiama “idiota” lo fa solo per salvarvi.

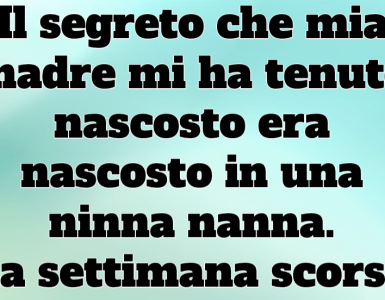
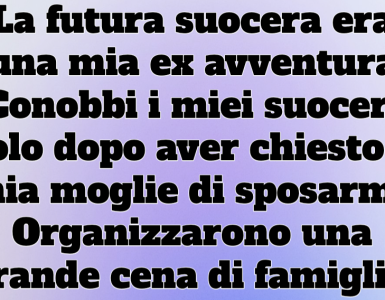
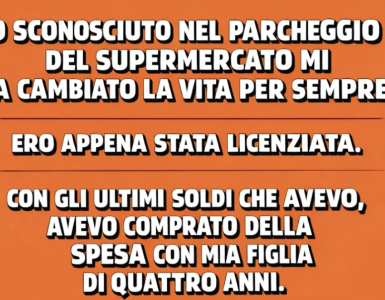
Add comment