Papà morì improvvisamente quando ero giovane. Non vidi mai mia madre versare una lacrima. Dopo il funerale, la ricordo mentre continuava la sua giornata come se nulla fosse successo. Di recente, anche lei è morta. Mettendo in ordine le sue cose, ho trovato la scatola di medicine di papà, nascosta nel suo armadio. Dentro c’erano flaconi con ancora il suo nome sull’etichetta, tutti intatti, mai aperti, con date di scadenza ormai da tempo superate.
Ricordo la settimana in cui morì papà come una vecchia videocassetta consumata. Avevo solo dieci anni, ma ancora oggi sento il rumore della porta di zanzariera che sbatteva dietro i paramedici. Dissero che era stato un infarto. Nessuna autopsia. Sì, aveva la pressione alta, forse colesterolo, ma la sua morte fu improvvisa. Uno di quei decessi che la gente liquida con un’alzata di spalle: “capita”.
Dopo che portarono via il corpo, mamma mi fece sedere e, stringendomi la mano una sola volta, mi disse: “Ora sei tu l’uomo di casa”. E basta. Non parlammo mai più di papà. Nessuna foto incorniciata in salotto. Nessun racconto, nessun compleanno ricordato. Sparito.
Quando trovai quella scatola nel suo armadio, stavo svuotando la sua stanza, dopo che gli operatori dell’hospice erano venuti a ritirare alcune cose. Era morta di insufficienza renale, una fine lenta e dolorosa, in un letto silenzioso. Le ero stato accanto nell’ultima settimana. Ma tra noi non c’erano mai state “grandi conversazioni”: si parlava dei piatti da dividere, dei cappotti da donare. Nulla su papà.
Eppure, proprio lì, in quell’armadio, c’era quella scatola senza coperchio, nascosta dietro una vecchia macchina da cucire. Dentro, almeno sei flaconi di prescrizioni mediche, coperti di polvere, tutti sigillati e datati circa due mesi prima della sua morte. Su ogni etichetta il nome era chiaro: Liron Choudhury. Li fissai a lungo. Un dolore sordo mi iniziò a pulsare nella testa.
Perché le sue medicine per la pressione erano ancora chiuse, se aveva un problema cardiaco noto?
Iniziai a cercare informazioni sui farmaci. La maggior parte erano comuni: beta-bloccanti, statine. Uno era un anticoagulante. Poi arrivai all’ultimo. Un farmaco usato per controllare la fibrillazione atriale. Sull’etichetta c’era scritto: “1 al giorno”. Ricordavo papà portarsi la mano al petto dopo aver corso per prendere l’autobus.
Avrebbe dovuto prenderle. E mamma chiaramente le aveva in mano.
All’inizio pensai: forse rifiutava di prenderle. Forse odiava gli effetti collaterali. Ma, ripensandoci, non lo avevo mai visto prendere delle pillole. E mi ricordavo bene di averlo sentito discutere con mamma alcune volte riguardo “andare a ritirare le prescrizioni”.
Così decisi di approfondire. Non volevo accusare una donna morta, ma dentro di me qualcosa continuava a tirarmi. Alla fine chiamai il vecchio medico di papà. Una scommessa azzardata: era in pensione, ma quando spiegai chi fossi accettò di incontrarmi per un caffè.
La dottoressa Malik ricordava bene mio padre. Disse che era ansioso per la sua salute, ma molto scrupoloso: non saltava mai un controllo. “Era uno di quelli che faceva troppe domande”, sorrise, mescolando il tè.
Le chiesi se ricordava di avergli prescritto quelle medicine. Mi rispose di sì, due mesi prima dell’infarto, con un nuovo piano da monitorare a breve. Aveva fissato un controllo, ma lui non si era mai presentato. Lo chiamò, senza risposta. Pensò che fosse morto prima di iniziare la terapia.
“Ma le medicine erano nel suo armadio”, sussurrai.
Lei sgranò gli occhi. “Allora le aveva ritirate?”
Annuii.
E fu in quel momento che la consapevolezza colpì anche lei. Se le aveva ritirate, perché non le aveva prese?
Tornai a casa e cresceva in me una sola domanda. Così aprii la vecchia scatola di documenti fiscali di famiglia e cercai gli estratti conto. Due cose saltarono subito all’occhio: uno, a ritirare i farmaci era stata mamma, con la sua carta; due, il giorno dopo aveva trasferito 9.000 dollari dal conto cointestato al suo conto privato. Non sapevo nemmeno che esistesse.
Confuso, chiamai mia cugina Aari, praticante legale. Le raccontai tutto. Tacque un attimo, poi fischiò piano.
“Pensi che gli abbia impedito di prendere le medicine?”
“Non lo so,” risposi. “Ma perché altro nasconderle?”
Quel fine settimana venne ad aiutarmi a cercare ancora. In fondo all’armadio, dietro una vecchia scatola di biscotti piena di bottoni, trovammo un piccolo sacchetto di velluto. Dentro, una collana d’oro e una lettera piegata.
Era indirizzata a me.
La carta era consumata, ma la calligrafia inconfondibile: quella di papà.
“Se stai leggendo queste righe significa che non ce l’ho fatta. Spero di sbagliarmi. Spero che tu non debba mai arrivare a questo. Tra me e tua madre c’è qualcosa che non va. Sono malato, ma non credo che lei voglia che io guarisca. Non crede davvero che io stia male, dice che esagero. Non ha ritirato le mie medicine, come aveva promesso. So che suona assurdo. Forse lo è. Forse sono paranoico. Ma se dovesse succedermi qualcosa, ti prego, non dare per scontato che sia stato naturale.”
Lessi quella frase più e più volte.
Papà lo sapeva. Lo sentiva.
E lei lo fece comunque.
Aari rimase senza parole, poi mormorò: “Pensi che basti per—”
“Per cosa?” la interruppi. “Sono entrambi morti adesso.”
Non mi sentivo arrabbiato. Solo svuotato.
Per anni avevo creduto che papà fosse morto giovane per sfortuna o cattiva genetica. Forse, invece, era qualcosa di molto più oscuro.
Quella notte non dormii. Continuavo a ricordare piccoli momenti: mamma che sbuffava perché papà dimenticava la spazzatura; i suoi occhi al cielo quando lui diceva di sentirsi stordito. Credevo fosse solo severa. Ma ora?
Forse pensava che lui stesse fingendo. Forse era esausta. Forse non voleva essere legata a un marito malato.
Decisi di parlare con Nalini, la donna che una volta puliva casa nostra. Le chiesi se ricordava qualcosa di strano in quel periodo. Ci rifletté e poi disse piano: “Qualche giorno prima, tua madre mi disse una frase strana: ‘A volte penso che sarebbe più facile se smettesse di fingere’. Non capii. Pensai volesse dire che lui esagerava i sintomi. Ma ora…”
Non c’erano dubbi.
Non ci sarebbe stata un’indagine, né tribunali. Nessuna revisione ufficiale della causa di morte. Solo una scatola di medicine, una lettera e centinaia di sospetti taciuti.
Alla fine decisi che a papà dovevo almeno la verità. Non alla polizia. A me stesso.
Organizzai un piccolo memoriale. Venticinque anni dopo.
Invitai alcuni amici di famiglia, vicini che lo ricordavano ancora. Lessi la lettera ad alta voce. La gente pianse. Alcuni rimasero scioccati. Aari parlò anche lei. Condividemmo ricordi, ridemmo della sua ossessione per i cruciverba.
Per la prima volta sentii che papà aveva avuto il saluto che meritava.
Poi andai al cimitero. Sulla sua lapide c’erano solo nome e date. Scelta di mamma. Portai con me una nuova targa e la posai accanto alla pietra.
C’era scritto: “Ha lottato. Ora lo vediamo.”
Ed era vero.
A volte la giustizia non arriva come la vogliamo. Ma possiamo comunque dire la verità. Possiamo comunque onorare ciò che era stato nascosto.
Non sono più arrabbiato.
Ho solo smesso di fingere.
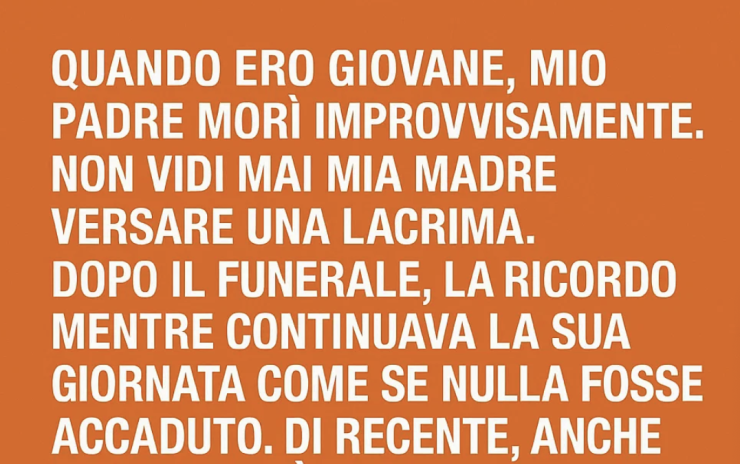
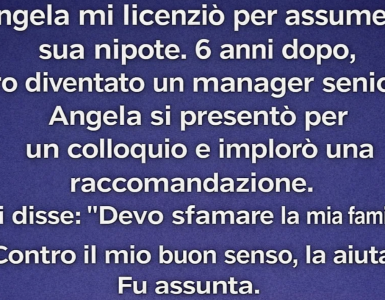
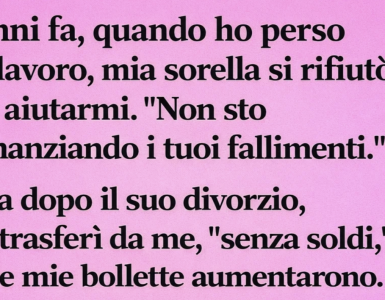
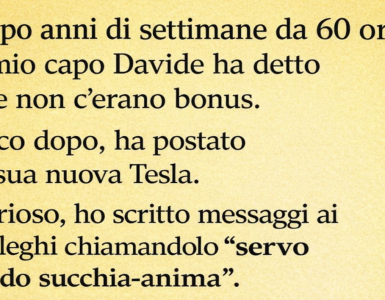
Add comment