La settimana scorsa mia madre mi ha chiamato all’improvviso, dopo anni di silenzio, dicendomi che sta morendo. Ha aggiunto che per lei significherebbe molto poter tornare a vivere nella casa in cui mi ha cresciuto, ma io le ho detto di no.
Ieri mi sono svegliato di soprassalto per i colpi alla porta: era la polizia. Mi hanno informato che era arrivata una segnalazione su un’anziana sorpresa a introdursi in una proprietà privata, la mia. Ora vivo io in quella casa: mio padre me l’ha lasciata quando è morto, due anni fa. Diceva sempre che quella sarebbe stata la mia ancora, che qualsiasi cosa fosse successa, quella casa sarebbe stata per sempre mia.
Quando sono uscito, l’ho vista: mia madre, seduta rannicchiata sulla veranda, con una coperta leggera sulle gambe e un sacchetto di plastica pieno di medicine e fazzoletti. Non sapevo se piangere o urlarle contro. Sembrava molto più vecchia dei suoi sessant’anni: la pelle sottile e fragile, come se potesse lacerarsi solo a guardarla. Eppure, nei suoi lineamenti, riconoscevo ancora la donna che cantava mentre piegava il bucato, la stessa che un weekend aveva fatto le valigie senza più tornare.
Ho detto agli agenti che me ne sarei occupato io. Loro si sono scambiati uno sguardo, come a farmi un augurio muto, e se ne sono andati. Lei è rimasta in silenzio per qualche secondo, fissando lo zerbino come se dovesse decifrarlo. Poi ha mormorato che pensava avrei cambiato idea. Io ho riso, ma non in modo gentile, facendole notare che si era introdotta in casa mia. Lei ha sussurrato che lì aveva vissuto, che aveva cucito lei le tende della cucina.
In quel momento ho notato il dettaglio: alla finestra della cucina, la mia finestra, c’era un pezzo di stoffa floreale legato a un angolo, come se avesse provato ad attaccare qualcosa del passato al presente. Ho sentito l’impulso di strapparlo via. Le ho chiesto perché fosse davvero lì. Ha tossito forte, con un colpo di tosse profondo e pesante, e ha ripetuto che è malata, che non vuole morire in una stanza in affitto, ma in un posto che per lei abbia un significato.
Io sono rimasto in silenzio. Lei ha continuato dicendo che non stava chiedendo la casa, solo di poter morire in un luogo che contasse qualcosa per lei. Le ho ricordato che se n’era andata per un uomo con la moto che non sopportava i bambini, che avrebbe potuto scrivere o telefonare. Lei ha risposto che aveva paura che mio padre mi mettesse contro di lei. Ho replicato che non ne aveva avuto bisogno: c’era riuscita da sola.
Si è soffiata il naso sulla manica. Portava ancora una fede, ma non sapevo se fosse quella di mio padre o di un altro. Mi ha chiesto di farla entrare almeno un’ora, promettendo che non avrebbe insistito ancora. Ho scosso la testa: sapevo che avrebbe chiesto di nuovo, il giorno dopo e quello dopo ancora, fino a ritrovarmela in una stanza con un letto ospedaliero, mentre io le porto il brodo con il cucchiaio. Lei non ha negato. Ha solo chiuso gli occhi.
Sono rientrato in casa e ho chiuso a chiave. Al tramonto non c’era più. Ho immaginato che fosse andata via o che avesse trovato un rifugio. Non l’ho cercata. Ma non riuscivo a dormire: continuavo a pensare al fatto che sapesse dove vivo, al coraggio che aveva avuto a sedersi sulla mia veranda come un fantasma che chiede di rientrare nel passato.
Ho preso una settimana di permesso, dicendo al mio capo che avevo una situazione familiare da gestire, il che era vero. Lavoro in biblioteca, soprattutto al banco prestiti, e a volte aiuto negli incontri di alfabetizzazione digitale per anziani. È un lavoro tranquillo e apprezzo i frequentatori abituali.
Mercoledì è arrivata la signora Yamada e mi ha detto che mia madre era alla mensa di San Paolo quella mattina e che avevano dovuto chiamare qualcuno per venirla a prendere. Ho chiesto se fosse sicura che si trattasse di mia madre, e lei ha risposto che la donna aveva detto di essere mia madre e aveva chiesto se suonassi ancora il piano. Non lo faccio più da quando papà è morto.
Sono uscita a metà turno e mi sono precipitata a San Paolo, una piccola chiesa che organizza un servizio pasti. Era lì, seduta all’ombra con un piatto di purè e piselli. Stavolta sembrava ancora più provata, con un braccialetto ospedaliero al polso. Le ho chiesto dove stesse dormendo e lei ha risposto che non aveva un posto fisso, a volte un letto in chiesa, a volte un pavimento. L’ho odiata per il fatto che mi stesse facendo provare compassione.
Le ho detto di venire con me. Non per restare, ma per farsi una doccia, mangiare qualcosa di caldo e mettere dei vestiti puliti. Non ha obiettato. In casa camminava come se temesse che il pavimento la respingesse, fermandosi davanti a ogni fotografia appesa. Davanti a una mia foto a dieci anni, con un dente mancante, ha sussurrato che l’avevo tenuta. Le ho spiegato che era stato papà ad appenderla e che io non l’avevo mai spostata. Lei ha commentato che lui mi aveva sempre amata di più. Non ho risposto.
Ha fatto una doccia lunga, mentre io scaldavo della zuppa. Quando è uscita, aveva un po’ di colore in volto. Le ho passato una vecchia felpa di papà. Lei mi ha guardato con gli occhi lucidi dicendo che non si meritava niente di quello. Le ho risposto che era vero. Ha dormito sul divano e io sono rimasto sveglio a controllare la veranda dalle persiane.
La mattina dopo le ho detto che l’avrei accompagnata a un rifugio vicino all’ospedale. Ha annuito senza discutere. Durante il tragitto mi ha chiesto se ricordassi l’altalena in giardino. Le ho detto di no. Ha raccontato che una volta ero caduto, aprendomi il mento, e che mi aveva tenuto in braccio mentre papà guidava come un pazzo verso il pronto soccorso. Io non ricordavo nulla, se non l’immagine di papà seduto vicino al mio letto d’ospedale con un frullato in mano.
Arrivati al rifugio, mi ha chiesto, nel caso non ce la facesse, di spargere le sue ceneri in giardino, sotto l’albero di albicocco. Ho pensato a quell’albero: dopo la morte di papà avevo quasi deciso di abbatterlo, ma non ne avevo mai avuto il coraggio. Le ho risposto che si vedrà.
È passata una settimana, poi due. Nessuna telefonata, nessuna notizia. Avevo quasi convinto me stesso di essere di nuovo libero. Finché non è arrivata una lettera. Era stata ricoverata nel reparto hospice di San Julian e, non avendo altri contatti, avevano usato il mio nome come riferimento di emergenza. Ho fissato la busta per ore prima di aprirla. Dentro, poche righe in cui ammetteva di avermi lasciato a pezzi, ma di non aver mai smesso di pensare a me, e diceva di essere tornata non solo per la casa, ma per dirmi qualcosa che mio padre non mi aveva mai raccontato.
Non sono andato da lei subito. Volevo prima capire. Ho chiamato mio zio Pravin, cugino di papà, che da piccolo veniva a trovarci portandomi caramelle straniere. Gli ho chiesto cosa intendesse mia madre con quel segreto taciuto da mio padre. Lui ha sospirato, dicendo che non era la sua storia da raccontare, ma che papà mi aveva protetto, forse fin troppo, e che a volte le bugie si intrecciano con l’amore. Ho odiato quella risposta.
Alla fine sono andato a San Julian. Lei era ancora più magra e pallida, ma nei suoi occhi si è accesa una scintilla quando mi ha visto. Ha detto che ero andato e io le ho chiesto solo di spiegarmi cosa intendesse. Mi ha fatto sedere e ha iniziato dicendo che non era mio padre ad avermi “solo cresciuto”, ma ad avermi salvato, non da lei, ma dal mio vero padre.
Mi ha rivelato che ero nato da una sua relazione extraconiugale quando aveva ventitré anni. Mio padre l’aveva perdonata, aveva firmato il certificato di nascita e deciso che nessun bambino doveva pagare per gli errori degli adulti. Ma quando avevo dodici anni, quell’uomo era ricomparso, pretendendo di entrare nella mia vita. Lei era tentata, pensava che io avessi il diritto di conoscerlo, mentre mio padre era contrario, deciso che io fossi solo suo figlio.
Mi ha spiegato che non se n’era andata solo per un altro uomo, ma per fermare una guerra tra i due uomini che mi rivendicavano. Allontanandosi, sperava che mio padre mi tenesse al sicuro e che l’altro alla fine si ritirasse. Così era stato: lui era emigrato in Canada e non aveva più cercato contatti.
Non sapevo cosa provare. Avevo passato la vita a credere che lei fosse scappata per una storia d’amore egoista, ma aveva scelto di farsi odiare pur di seppellire quel segreto. Con la mano tremante ha aggiunto di non aver mai smesso di amarmi, ma di aver pensato che volermi da lontano fosse più sicuro per me. Le lacrime mi sono scese senza che potessi fermarle.
Sono rimasto con lei un’ora, poi un’altra. Abbiamo parlato poco, ma siamo rimasti lì insieme. È morta due giorni dopo. Ho seppellito le sue ceneri sotto l’albicocco, senza cerimonie, solo io, una paletta e un suo vecchio foulard legato a un ramo.
Più avanti, in estate, ho trovato una busta nascosta nel vano del pianoforte, con una lettera di mio padre. Diceva che, se la stavo leggendo, significava che lei era tornata e che sperava l’avessi ascoltata. Ammetteva i suoi errori e diceva che il perdono non è debolezza, ma l’unica vera forma di forza che abbiamo. Ho pianto per un’ora di fila.
Non so se li ho perdonati davvero, lei o lui, o se ho perdonato me stesso per averla respinta quando ha chiesto aiuto per la prima volta. Ma quell’albero di albicocco ha fiorito prima del solito, con una quantità di fiori che non avevo mai visto. Forse certe cose hanno solo bisogno di tempo. E forse alcune radici, per quanto danneggiate, continuano a reggere.
Se c’è qualcuno che hai completamente escluso dalla tua vita, chiediti perché. A volte restiamo aggrappati al dolore anche quando non è più necessario.
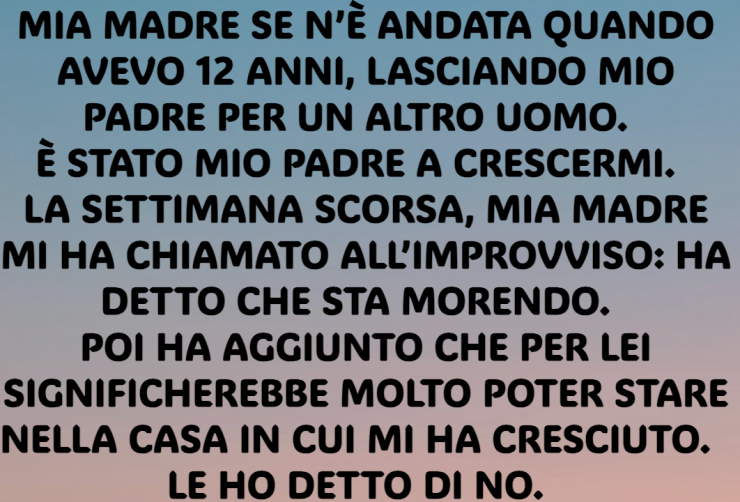



Add comment