Mia moglie vuole dare alla nostra bambina un nome “moderno e audace.” Le sue proposte? Apple o Cyan. Ho detto subito di no. Lei ha sorriso e ha annuito: “Lo sapevo che avresti detto così.” Pensavo fosse finita lì. Ma il giorno dopo, sono tornato a casa e sono rimasto scioccato nel vedere la cameretta dipinta di un blu acceso, con la scritta CYAN in grandi lettere di legno sopra la culla.
Rimasi fermo sulla soglia, senza parole. La stanza era passata da un delicato beige a un’esplosione di colori. Raya, mia moglie, era seduta sulla sedia a dondolo, accarezzandosi il pancione e sorridendo come se fosse tutto normale.
“Pensavo fossimo d’accordo,” dissi, entrando nella stanza.
“Non abbiamo litigato,” rispose con nonchalance. “Hai solo detto no. Non è la stessa cosa.”
Cercai di non innervosirmi. In passato avevamo avuto piccoli disaccordi—su tende, nomi per il cane, persino su che tipo di sottaceti usare nei panini. Ma questo era diverso.
“Non voglio chiamare nostra figlia come un colore di cartuccia per stampanti,” dissi, mezzo scherzando.
“Cyan non è solo un colore,” rispose, alzandosi lentamente. “È fresco, artistico, orientato al futuro.”
“Orientato al futuro? Raya, stiamo avendo un bambino, non lanciando una startup tecnologica.”
Lei rise—e questo rese difficile arrabbiarsi. Ma dentro restavo inquieto. Mancavano ancora quattro mesi alla nascita, e avevo sempre immaginato che avremmo scelto un nome che amassimo entrambi. Un nome da sussurrare nella notte o da scrivere con orgoglio sui biglietti di compleanno. Cyan non era quel nome.
Nelle settimane successive, Raya continuava a proporre nomi stravaganti—Nimbus, Quest, Orbit. Ogni volta mi irrigidivo un po’. Provai a proporre io qualcosa: Nora, Elias, Giulia. Speravo di trovare un equilibrio.
Lei diceva che erano “troppo sicuri”. Io le rispondevo che i suoi sembravano nomi di mobili dell’IKEA. Ridevamo, ma sotto c’era una tensione vera. Non si trattava solo dei nomi. Era la sensazione di non essere più sulla stessa lunghezza d’onda per qualcosa di importante.
Una sera, sul divano, guardavamo un documentario su musicisti jazz. Spuntarono immagini di Thelonious Monk, e ci voltammo contemporaneamente.
“Thelonious,” disse lei, alzando un sopracciglio. “Quello sì che è audace.”
“Ma classico,” aggiunsi. “E musicale. Ha una storia.”
Per la prima volta, ci trovammo a considerare sinceramente un nome che non fosse completamente tradizionale, ma nemmeno tirato fuori da un film di fantascienza. Parlammmo per ore quella notte. Di nomi con anima, radici, significato.
Qualche giorno dopo, la madre di Raya ci invitò a cena. Parlando del bambino, disse: “Ho ancora quel vecchio libro dei nomi degli anni ’80, se vi interessa.”
Raya declinò con garbo. “Stiamo facendo tutto in digitale, per ora.”
Ma più tardi, le chiesi: “E se tornassimo un po’ alle origini?”
Lei sospirò. “Voglio solo che nostro figlio si distingua. Che non sia uno dei cinque Emma o Liam in classe.”
“Lo capisco,” risposi. “Ma e se a farlo distinguere fosse chi è, non solo come si chiama?”
Non rispose. Ma non protestò. Era già un passo avanti.
Poi arrivò la svolta.
Stavo prendendo un caffè con mio cugino Mateo, quando mi disse qualcosa che cambiò tutto.
“Non te l’ho mai raccontato,” disse sorseggiando il suo latte, “ma a diciott’anni ho cambiato legalmente nome.”
Rimasi di sasso. “Davvero? Come ti chiamavi prima?”
“Cyan,” disse, con un sorriso imbarazzato.
Mi si spalancò la bocca.
“L’ho sempre odiato,” aggiunse subito. “Mi prendevano in giro. Mi chiamavano Crayon. Cyanide. Un insegnante mi chiese se i miei genitori si drogavano.”
E ora? “Mateo sono io. L’ho scelto io. Una nuova partenza.”
Quella sera lo raccontai a Raya.
Non disse molto. Si sedette sul bordo del letto, in silenzio.
“Non me l’aspettavo,” disse infine.
“Non sto dicendo che Cyan sia un brutto nome. Solo… forse non è adatto a tutti. E forse non al nostro bambino.”
Annuii lentamente. Poi mi disse qualcosa che non sapevo.
“Sai, anche io ho quasi cambiato nome.”
“Davvero?”
“All’università. Odiavo quanto Raya sembrasse antiquato rispetto a tutte le Sophias e Maddies. Avevo perfino compilato i documenti.”
“Cosa ti ha fermata?”
“Mia nonna. Mi disse che il nome veniva dalla sua migliore amica d’infanzia. Pregò che lo portassi con onore.”
“E lo fai,” dissi. E lo intendevo davvero.
Lei sorrise. E per la prima volta da settimane, sembravamo respirare all’unisono.
Decidemmo di ricominciare da zero con i nomi.
Niente più scelte solo per essere trendy. Niente che sembrasse il nome di uno shampoo o di un pianeta alieno.
Iniziammo a scrivere nomi che avessero significato. Persone che ci avevano ispirati, luoghi che amavamo, musica che ci aveva cambiati.
Scrivemmo Maya—per la poetessa. Jonah—per il ragazzo che avevo seguito come tutor, ma che aveva insegnato più a me che io a lui. Liora—che in ebraico significa “luce”.
Appendemmo la lista al frigorifero. Ogni volta che passavamo, ne cerchiavamo uno o ne cancellavamo un altro. Era diventato il nostro nuovo piccolo rituale.
Poi arrivò una telefonata inaspettata.
La zia di Raya era morta. Un ictus improvviso. Aveva solo 58 anni.
Si chiamava Mira.
Raya era distrutta. Mira era stata più di una zia—era stata come una seconda madre quando i suoi genitori si erano separati. Le aveva insegnato a guidare, l’aveva portata al suo primo concerto, le sussurrava frasi incoraggianti durante le crisi di panico al liceo.
Al funerale, uno dopo l’altro, amici e parenti raccontavano quanto Mira avesse toccato le loro vite. Non in modi eclatanti. Ma in quelli silenziosi e costanti.
Durante il viaggio di ritorno, Raya mi strinse la mano forte.
“Penso di aver trovato il nome,” sussurrò.
Non dovetti chiedere. Sapevo già.
E così, Mira salì in cima alla lista. In lettere grandi e decise.
Un mese dopo, durante un controllo, il medico ci confermò che il bambino stava bene. Cuore forte. Attivissimo.
Non volevamo sapere il sesso. Volevamo fosse una sorpresa.
Ma ormai lo sapevamo: maschio o femmina, il nome sarebbe stato Mira. In onore. In gratitudine. Per amore.
Qualche settimana prima del parto, organizzammo l’ultimo baby shower. Palloncini, calzini minuscoli, cupcake con punti interrogativi sopra.
Un’amica ci regalò un quadro con il significato del nome Mira: “meraviglia, pace, oceano.”
Tutti pensarono che lo avessimo scelto per il suono o il significato.
Noi sorridevamo e annuivamo. Alcune cose è più bello tenerle nel cuore.
Quando nacque, era una femmina. Polmoni sani, capelli folti, occhi sereni.
La chiamammo Mira Elise.
Ed era tutto ciò che non sapevamo di desiderare.
Ora, ogni volta che entro nella cameretta, vedo ancora quelle lettere CYAN appese al muro. Non perché abbiamo tenuto quel nome—ma perché le abbiamo girate, dipinte di bianco, e riordinate a formare: MIRA.
Un simbolo silenzioso di crescita, di compromesso, e dell’amore che si approfondisce quando impari ad ascoltare davvero.
Ecco la verità: i nomi sono importanti—ma mai quanto le persone dietro di essi. Mai quanto l’unità. Mai quanto l’eredità che lasci.
A volte, la scelta più audace è quella della semplicità con significato. Onorare il passato, abbracciando il futuro.
Se questa storia ti ha toccato o ti ha fatto pensare a qualcuno che ami, metti un like e condividila. Forse qualcuno, proprio ora, sta affrontando una decisione simile—e il tuo gesto potrebbe portargli un po’ di chiarezza.
Perché alla fine, il nome che non ci saremmo mai aspettati, è diventato quello che non smetteremo mai di pronunciare con il cuore pieno.
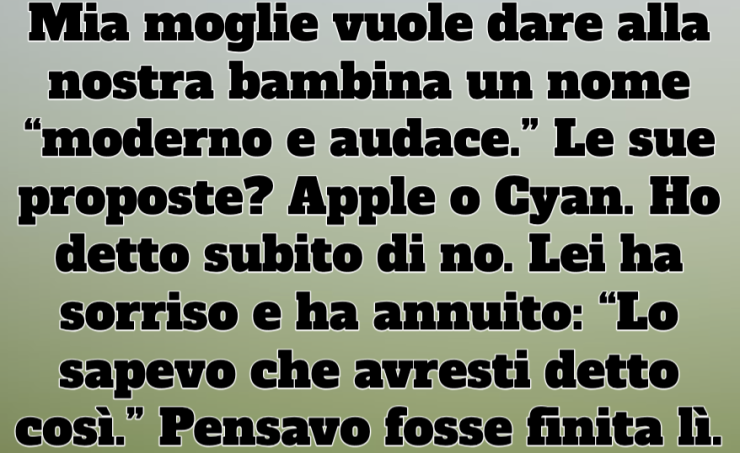

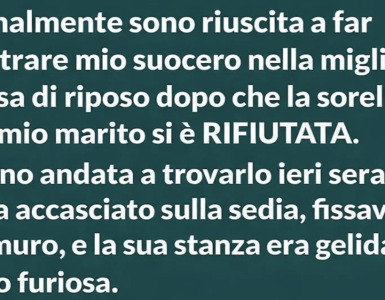

Add comment