La gente intorno a me crede che alzi il gomito solo per dimenticare te.
Invece non è così.
Bevo perché dentro c’è troppo rumore,
quello dell’orgoglio che grida di stare zitto.
Così, tra un bicchiere e l’altro, riesco quasi a mandarle quel messaggio breve:
“Mi manchi.”
So bene come andrà a finire —
tornerà, prenderà ciò che vuole, poi sparirà senza voltarsi.
Chiamarmi Claudio non cambia quel che è successo.
A trentacinque anni, le cose si mettono così: da otto mesi vivo solo.
Almeno, questa è la versione che racconto ai conoscenti.
L’ultima volta che ho visto Giulia, se n’era già andata con qualcun altro.
Prima ancora di sparire, aveva cancellato tutto ciò che eravamo.
Qualcuno ha dovuto tirarmi su con un cucchiaio piccolo.
Hanno parlato così:
— “Fortuna averla persa, era velenosa, tu vali molto di più.”
Quando il sole è alto annuisco insieme a loro.
Con la luce accesa ragiono da persona normale:
faccio sport, lavoro e penso: mai ripetere quell’errore.
Di notte, invece di cercare pace, apro una porta con quel bicchiere.
Verso il vino non per calma, ma per perdere il controllo.
A quell’ora, le ventitré, ogni rumore si spegne troppo in fretta.
Senza accorgermene fisso lo schermo del telefono.
A gridare dentro di me è la dignità:
fermati, non mandarle nulla, smettila di sembrare debole,
pensa a come ti ha fatto sentire.
È dura, precisa, senza crepe quella voce.
Per zittirla, però, l’unica strada è sporcarla con qualcosa di tossico.
Con il primo giro, la tensione comincia a sciogliersi.
Dopo il secondo, i pensieri si mescolano:
le scenate svaniscono, restano solo le nostre risate
oppure l’immagine del suo corpo tra le lenzuola.
Al terzo sorso, qualcosa scatta dentro.
Da quel momento in poi, ogni traccia dell’uomo perbene scompare nel buio.
Solo Claudio, con la testa tra le mani.
WhatsApp si apre da solo.
Lei è lì, attiva ora.
Le mando:
— “Hai gli occhi aperti?”
Forse meglio:
— “Mi gira in mente quello che eravamo.”
Risponde quasi ogni volta.
Conosce il mio stato, quando ho bevuto troppo.
Riesce a vedere quanto sono fragile.
Alcune sere mi chiede di raggiungerla.
Allora esco con l’auto, pur sapendo che potrei perdere la patente o peggio —
un errore sopra un altro.
Arrivo da lei.
Passa un’ora usando me.
Tra noi non c’è affetto.
Solo presa ferma da una parte.
Cedimento totale dall’altra.
Col mio errore si riempie lo stomaco dell’orgoglio.
Dalle sue schegge vivo io, chiuso nel silenzio.
Il giorno dopo è un disastro.
Apro gli occhi e sono tra le lenzuola mie —
oppure, ancora peggio, nelle sue, con lei seduta accanto che mi osserva:
uno sguardo fra compassione e seccatura.
Parole secche:
— “Adesso basta, devo muovermi.”
Il dolore alla testa pulsa, certo,
però il vero male viene da dentro, dalla coscienza pesante.
Controllo ciò che ho scritto prima.
Non mi riconosco.
Avevo giurato di non ricascarci mai più.
Giurai a me stesso che avrei fatto attenzione.
Ma poi bevvi, ignorando quello che il corpo mi diceva.
Stasera torno a casa.
Il vuoto dentro si fa sentire, come sempre.
Apro una bottiglia.
Non è per il gusto del vino.
È per spegnere quel poco di dignità rimasta.
Così dopo non pesa più tornare da chi mi ferisce.
Gli amici pensano sia tutto finito.
Dicono:
— “L’hai sentita ancora?”
Rispondo di no.
Faccio finta che non importi.
Invece ogni volta cedo.
Senza quella dose di oblio, non ce la farei.
Mi serve annientarmi un po’.
Solo così riesco ad accettarlo di nuovo.
Chiamatemi pure Claudio.
A trentacinque anni suonati, eccomi qui.
L’etichetta da alcolizzato non mi calza a pennello;
piuttosto assomiglio a uno che si punisce di proposito.
Il bere?
Un trucco qualsiasi per intorpidire
quel poco di rispetto che resta
prima del weekend.
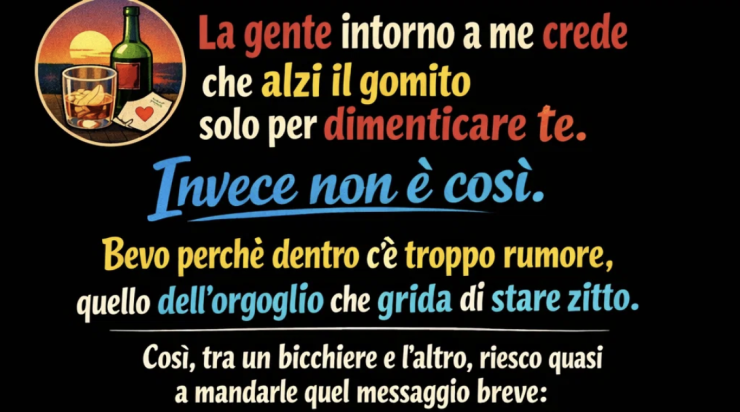
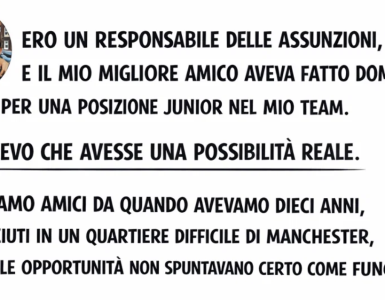
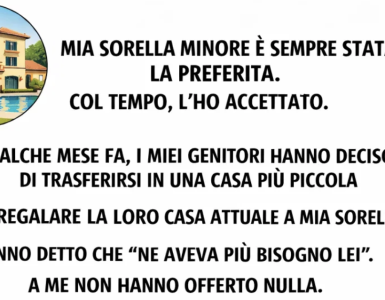
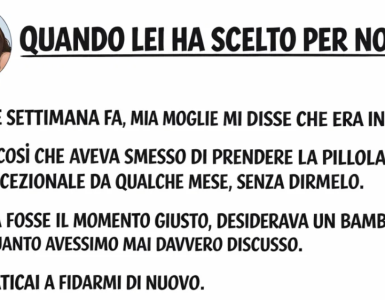
Add comment