Quel che sta succedendo nella Siria nordorientale, al confine con la Turchia e a Est del fiume Eufrate, lo racconta il corpo seviziato e oltraggiato di Hevrin Khalaf, segretaria generale del Future Syria Party, il nuovo Partito futuro siriano, e attivista per le donne, massacrata orribilmente sabato 12 ottobre a sud della città di Tel Abyad, dopo essere stata bloccata mentre, su una Toyota, viaggiava sull’autostrada M4 verso Qamishlo.
Un agguato in cui hanno perso la vita Hevrin, forse violentata dai suoi aguzzini prima di essere lapidata, e altri otto civili, tra cui l’autista curdo dell’attivista, ammazzati a colpi di arma da fuoco. A documentare l’esecuzione ci sono due video realizzati da gli assassini e poi diffusi online: Hevrin circondata da uomini vestiti con divise militari, Hevrin ormai senza più vita riversa sul terreno mentre un uomo la tocca con i piedi e la insulta. Immagini crude, che tuttavia non bastano a individuare i colpevoli: l’Isis, si è detto in un primo momento, perché per i fondamentalisti islamici lei era una miscredente, o forse le milizie mercenarie appoggiate da Ankara, secondo la versione delle forze democratiche siriane a guida curda, visto che per la Turchia i curdi come la Khafal sono terroristi. Sì, Hevrin, nata 35 anni fa a Derek, piccolo villaggio al confine con l’Iraq, era nemica degli uni e degli altri.
Di chiunque non volesse la pace. Era una combattente, ma alle armi preferiva la diplomazia, per la quale aveva un grande talento che esercitava instancabilmente per la convivenza pacifica tra curdi, cristiani e arabi come per l’emancipazione delle donne. Che in Rojava, la regione autonoma amministrata dai curdi siriani, sono libere di scegliere il proprio destino senza dover chiedere il permesso ai maschi. Hevrin si era laureata in Ingegneria, ma più che i numeri le interessavano le parole, quelle che nell’inglese fluente imparato da bambina tirava fuori agli incontri con le delegazioni straniere in visita a Qamishli, Kobane e Raqqa, quelle scandite con tono fermo e pacato durante le interviste concesse ai media di tutto il mondo per sostenere la causa dei curdi. L’ultima, rilasciata una settimana prima della sua morte, somiglia a un testamento politico.
«Noi respingiamo le minacce turche, che ostacolano i nostri sforzi per trovare una soluzione alla crisi siriana periodo di dominio dellTsis alle frontiere, la Turchia non ha visto questo come un pericolo per la sua gente. Ma ora che c’è un’istituzione democratica nel nord-est della Siria, loro ci minacciano con l’occupazione». Occupazione che però è negata dai comandi turchi, che declinano anche la responsabilità dell’omicidio di Hevrin Khalaf. Eppure la loro offensiva militare ha già messo in fuga 200 mila sfollati, messo a rischio 170 mila bambini che potrebbero avere bisogno di assistenza umanitaria, creato una moltitudine di disperati, forse un milione e mezzo di persone, che necessitano di cure e medicine. Che qui non ci sono.
La Siria a ferro e fuoco, di nuovo, con un’operazione militare nel nord-est annunciata dal presidente Recep Tayyip Erdogan il 9 ottobre, che ha due obiettivi, come ci spiega Valeria Talbot, responsabile dell’Osservatorio Medio Oriente dell’Ispi, l’Istituto per gli studi di politica internazionale. «Il primo è quello di mettere in sicurezza la frontiera con la Siria, che la Turchia vede minacciata dalle milizie curde che hanno il controllo di quest’area». Milizie che insieme con la coalizione internazionale hanno combattuto e sconfitto l’Isis, riconquistando i territori su cui il Califfato aveva piantato il suo vessillo nero di morte e orrore, ma che il governo turco considera da sempre gruppo terroristico. Una sorta di branca siriana del Pkk, il Partito dei Lavoratori del Kurdistan guidato da Abdullah “Apo” Ócalan, rinchiuso in un carcere turco dal 1990, protagonista di una cruenta stagione di lotta armata contro il governo di Ankara terminata nel 2001. «Il secondo obiettivo dichiarato», continua l’analista, «è quello di ricollocare in quest’area parte degli oltre 3 milioni e 600 mila rifugiati siriani ora ospitati dalla Turchia. Ospitalità realizzata col supporto dell’Unione europea, certo, ma Ankara sostiene che i costi della gestione dell’accoglienza siano molto superiori rispetto al contributo della Ue».
Rifugiati siriani arabi, però, che con buona probabilità non rientrerebbero volentieri nella regione curda, diversa da quella di cui sono originari. «La ricollocazione in quell’area diluirebbe la densità curda della zona», precisa la Talbot, «ma alimenterebbe probabilmente nuove tensioni».
L’avanzata dei turchi, resa possibile anche dal ritiro ufficiale delle truppe americane da Kobane, città simbolo della resistenza contro l’Isis, potrebbe penetrare il territorio siriano per trenta-trentacinque chilometri, ovvero fino alle città di Hasakah e Kobane,
stando alle dichiarazioni ufficiali di Ankara, ma alcuni esperti di affari esteri ipotizzano obiettivi ben più ambiziosi, supponendo che l’esercito di Erdogan potrebbe spingersi fino a Raqqa e Deir ez-Zor.
Un complicato Risiko nel quale ha fatto irruzione anche il presidente siriano Bashar al Assad, che con il supporto del presidente russo Vladimir Putin e dell’Iran, scende in campo al fianco delle unità combattenti curde per aiutarle ad arginare l’offensiva turca. Un doloroso compromesso per i curdi, come lo ha definito sul bimestrale americano Foreign Policy il capo delle Forze democratiche siriane Mazloum Abdi. «Ma se dobbiamo scegliere tra un compromesso e il genocidio del nostro popolo, certamente sceglieremo la vita della nostra gente», ha spiegato. «Che cosa i curdi abbiano ottenuto nel negoziato non si sa», osserva la Talbot, «ma, cercando la protezione di Assad e della Russia per respingere i militari turchi e salvarsi, partivano da una posizione di debolezza». Così il Sultano è riuscito in quella che per la comunità internazionale era una missione impossibile: riunire i destini della Siria, fino a oggi spaccata in due; da una parte il Rojava, strappato al Califfato e amministrato dai curdi, dallaltra l’ovest, quasi interamente sotto il controllo del governo ufficiale di Damasco. «Perché per Assad questa operazione significa andare verso il controllo di tutta la Siria, riprendendo la parte che stava sotto il controllo curdo, che rappresenta il 30 per cento del territorio».
In quella fetta di Siria che corre lungo la frontiera della Turchia e dell’Iraq oggi i combattenti curdi custodiscono le prigioni in cui sono rinchiusi oltre 70 mila miliziani jihadisti catturati negli anni della guerra all’Isis, oltre che gli affollati campi che ospitano donne e bambini che si erano uniti all’organizzazione terroristica sotto il Califfato. «Rinchiusi nelle carceri ci sono anche i foreign fighters che l’Europa non ha voluto riprendere», dice la Talbot. «Sui media sono apparse notizie di fughe già avvenute da campi lasciati incustoditi o colpiti da bombe turche. Di certo i rischi in termini di riorganizzazione dello Stato islamico sono altissimi». E aumentano ora dopo ora di questa nuova e insensata guerra.



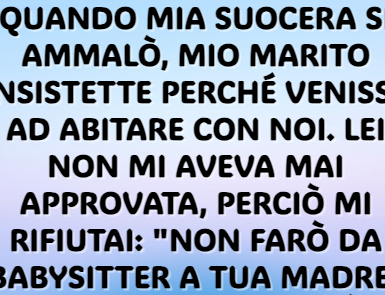
Add comment