Non avrei nemmeno dovuto trovarmi fuori a quell’ora. Avevo appena finito un doppio turno al ristorante e avevo perso l’ultimo autobus, così decisi di tagliare per la parte più isolata di Jefferson Avenue. Non è certo la zona più sicura dopo mezzanotte: negozi sbarrati, vetri rotti, vecchi volantini incollati al marciapiede dalla pioggia e da chissà cos’altro.
Poi l’ho vista.
Un minuscolo cucciolo di golden retriever, poco più grande di una scatola da scarpe, legato a una panchina arrugginita con una corda sfilacciata. Stava lì, immobile, come se non capisse nemmeno di essere stata abbandonata. La coda ha fatto un piccolo cenno quando mi ha visto, ma non ha abbaiato, non ha guaito. Solo uno sguardo fisso. E quello mi ha spezzato.
Non c’era una ciotola, né cibo, né un biglietto. Solo quel collare stretto, con una medaglietta di strass semi-nascosta nel pelo. Mi sono accovacciato e ho parlato piano, con voce rassicurante. Lei mi ha lasciato accarezzarla. Le zampette erano fredde: era lì da parecchio.
Ho girato la medaglietta, aspettandomi un nome o un numero di telefono. Invece, dietro, c’era un foglietto piegato a forza, incastrato così stretto che quasi si strappava a tirarlo fuori.
La calligrafia era frettolosa, quasi illeggibile. Ma una frase era chiara:
“Se stai leggendo questo, non portarla al canile. Hanno già provato a ucciderla una volta.”
È stato allora che ho notato una piccola cicatrice sotto l’orecchio sinistro. Come se fosse stata ricucita… o peggio.
Ho alzato lo sguardo, improvvisamente consapevole di ogni ombra sulla strada. Quello non era un normale abbandono.
L’ho presa in braccio, con il cuore che martellava. Tremava, ma non si muoveva. L’ho avvolta nella giacca e sono andato veloce verso casa. Vivo in un piccolo appartamento sopra il ferramenta del signor Lindley. Gli animali non sono ammessi, ma avrei spiegato dopo.
Dentro, le ho scaldato un po’ di pollo dal frigorifero e steso un asciugamano sul pavimento. Ha divorato tutto come se non mangiasse da giorni, leccando la ciotola finché non girava sul pavimento. Io l’ho guardata: occhi svegli, ma un silenzio innaturale. Come se avesse imparato a non fare rumore.
E quel biglietto mi ronzava in testa.
Chi lo aveva scritto? Cosa significava “hanno già provato a ucciderla”? Era solo un proprietario paranoico o c’era dell’altro?
La mattina dopo ho preso un giorno di malattia e ho portato la cucciola — che ormai chiamavo Daisy — da un veterinario dall’altra parte della città. Non volevo rischiare che qualcuno la trovasse.
La dottoressa Haynes ha scansionato il microchip. Ce n’era uno.
Appena vide i dati sullo schermo, però, si irrigidì.
“Questo cane risulta deceduto”, disse sottovoce. “Tre settimane fa. Segnalato dall’ufficio di controllo animali dopo un ‘incidente’ al rifugio comunale. Ma qualcuno ha cancellato i suoi dati dal sistema.”
La bocca mi si è seccata. “Che tipo di incidente?”
Lei mi mostrò un rapporto sgranato: un gruppo di cuccioli era stato portato al rifugio, poi schedato per eutanasia a causa di “sovraffollamento”. Uno era scappato. Daisy.
O qualunque fosse stato il suo nome prima che qualcuno tentasse di cancellarla.
“In realtà non dovrei nemmeno mostrarti questo,” ammise la veterinaria. “Ma qualcosa non torna.”
Le chiesi: “Posso tenerla? Legalmente, intendo.”
Lei sospirò, poi accennò un sorriso. “Non ha più un proprietario registrato. Chi ha rimosso la sua scheda l’ha resa un fantasma. Per il sistema non esiste. Tienila al sicuro.”
Così ho fatto.
Nei giorni seguenti Daisy è diventata la mia ombra. Mi seguiva da una stanza all’altra, dormiva accanto a me, ma sobbalzava a ogni bussata. Pian piano, però, ha iniziato a giocare. La coda scodinzolava di più. Una volta ha abbaiato al rumore del tostapane, e io mi sono messo a ridere fino alle lacrime.
Credevo fossimo al sicuro.
Poi, una notte, tornando dal turno, ho trovato la porta di casa socchiusa.
Mi sono gelato.
L’avevo chiusa a chiave. Sempre.
Sono entrato di corsa, gridando il nome di Daisy. Nessuna risposta. Panico puro.
Poi l’ho vista: nascosta sotto il lavandino del bagno, tremava. Accanto alla porta, piantato con un cacciavite nel legno, c’era un biglietto. Stessa carta, stessa grafia.
“Sei stato avvertito. Fatti da parte.”
Ho capito. Non volevano che Daisy fosse solo dimenticata. La volevano morta.
Quella notte non ho dormito. Sono rimasto sveglio, Daisy sulle ginocchia, lo sguardo fisso alla porta con una mazza da baseball accanto.
Il giorno dopo sono andato dal mio amico Milo, esperto di computer. Gli ho mostrato i biglietti, la cicatrice, il rapporto della veterinaria.
Lui ha fischiato: “Sicuro che non sia roba da combattimenti clandestini?”
“Daisy? È grande quanto una pagnotta.”
“Appunto. Usano i cuccioli come cani-esca.” Il suo tono si abbassò. “Brutta gente. Spiegherebbe la cicatrice.”
Il mio stomaco si è rivoltato.
Milo ha iniziato a scavare nei registri: bilanci del rifugio, documenti di donazioni, file nascosti. Dopo ore, ha trovato qualcosa.
“C’è un gruppo privato che prende cani dal rifugio comunale. Dicono che li rimettono in adozione. Ma non c’è traccia di adozioni reali. In compenso, ricevono enormi pagamenti da un’azienda di test farmaceutici.”
Il sangue mi si è gelato. “Test sugli animali?”
Lui ha annuito. “Se Daisy è scappata da quello, è un miracolo che sia viva.”
La guardai: accucciata ai miei piedi, con il suo pupazzo preferito. Dolce, fiduciosa Daisy. E qualcuno l’aveva vista solo come un oggetto da usare.
Non potevo permettere che accadesse di nuovo.
Con Milo abbiamo installato telecamere e nuove serrature. Poi lui ha creato un finto profilo di adozione collegato a quel gruppo “rescue”. Fingendo di avere una partita di cani pronti per i test. Hanno risposto subito, fissando un incontro in un vecchio magazzino al porto.
A mezzanotte.
Non siamo andati dalla polizia. Abbiamo chiamato qualcuno di più coraggioso: la cugina di Milo, giornalista investigativa. Quella che una volta aveva smascherato un mattatoio con una telecamera nascosta.
Ha accettato senza esitazione.
Quella notte si è presentata al magazzino con un microfono occulto. Milo e io eravamo nascosti in un furgone lì vicino. Daisy era al sicuro da un vicino.
L’uomo che arrivò sembrava normale. Sui 40, ben vestito. Come un dentista. Ma portava un furgone pieno di gabbie.
Ha parlato con calma, dicendo che poteva procurare decine di animali. Ha chiesto quanto fossero “docili” e “forti”. Ha accennato a “test clinici” e a “esemplari da sacrificare”.
Era tutto registrato.
La stessa notte, il servizio è andato in onda:
“SCOPERTO GIRO CLANDESTINO DI TEST SUI CANI LEGATO AL RIFUGIO COMUNALE.”
Cinque arresti. Laboratorio chiuso. Dirigenti licenziati.
E Daisy? È diventata il simbolo della lotta.
La sua cicatrice, i suoi occhi dolci e le foto con i suoi nuovi giochi hanno fatto il giro del web. Donazioni, proteste, adozioni a valanga. Il rifugio ha cambiato gestione. La cugina di Milo ha vinto un premio.
E io?
Ho potuto tenerla, senza più ostacoli.
A volte, la notte, penso a quanto sarebbe stato facile tirare dritto davanti a quella panchina. Ero stanco, senza soldi. Avrei potuto pensare che qualcuno tornasse a prenderla. Ma non l’ho fatto.
Daisy mi ha salvato.
Prima di lei, la mia vita era solo turni massacranti e zuppe istantanee. Con lei ho qualcosa per cui combattere.
L’amore non arriva sempre al momento giusto. A volte ti aspetta legato a una panchina alle due di notte, con una cicatrice e un biglietto spiegazzato.
Ma ne vale sempre la pena.
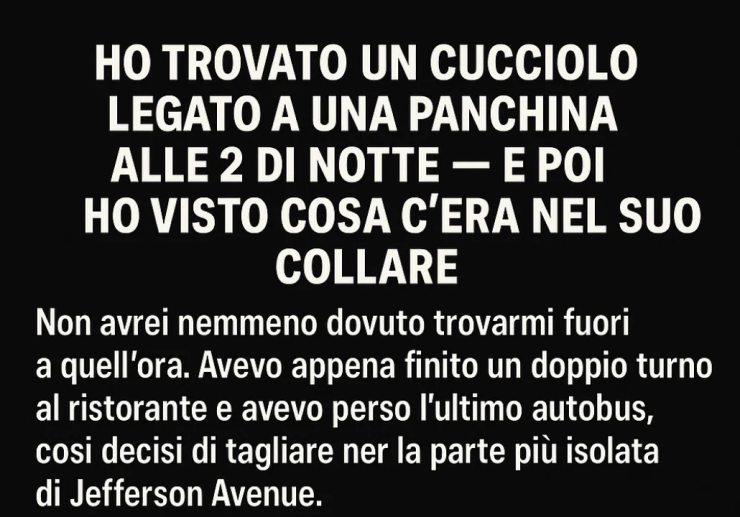
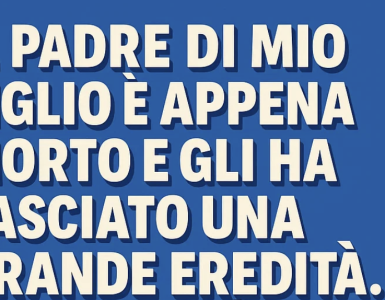


Add comment