Avevo avuto un infortunio al ginocchio e zoppicavo. I miei genitori mi dissero che non avevano i soldi per portarmi dal medico. Quando lo raccontai al mio allenatore di calcio, rimase scioccato e furioso. Mi chiese:
«Ti rendi conto di quanto potrebbe essere grave? Non puoi semplicemente ignorarlo!»
Scrollai le spalle, fingendo indifferenza, anche se ogni passo sembrava una lama che mi trafiggeva l’articolazione. Ma lui non ci credette.
«Hai quindici anni. Hai talento, talento vero. Sei uno dei migliori centrocampisti che abbia allenato negli ultimi dieci anni. Pensi di poter arrivare lontano con un ginocchio distrutto?» mi disse fissandomi intensamente.
Non seppi rispondere. A dire il vero, non pensavo più al futuro. I miei genitori lavoravano doppi turni in fabbrica e a stento riuscivamo a pagare l’affitto. Niente assicurazione sanitaria. Un ginocchio era solo un ginocchio: se guariva, bene; se no, la vita andava avanti.
Lui non aggiunse altro. Annui come se stesse riflettendo su qualcosa. Pensai che si sarebbe arrabbiato per un paio di giorni e poi avrebbe lasciato perdere.
Ma la mattina dopo, chiamò mia madre.
Ero ancora mezzo addormentato quando la sentii parlare in cucina. Non capii tutto, ma abbastanza. Voleva portarmi in una clinica sportiva e si offriva di pagare lui. Mia madre continuava a dire di no, che non accettavamo elemosine. Ma l’allenatore era testardo. Alla fine, lei cedette: avrebbe ci pensato.
Quella sera mi chiese:
«Lo vuoi davvero, questo sogno del calcio?»
Annui senza esitare. «Più di ogni altra cosa.»
Sospirò, si tolse il grembiule e si asciugò la fronte. «Allora ci vai. Odio chiedere aiuto, ma forse è ora di smettere di fingere che possiamo fare tutto da soli.»
La clinica era nel paese accanto. L’allenatore mi accompagnò di persona. All’inizio il viaggio fu silenzioso. Ero nervoso. Lui lo notò.
«Sai, mi ruppi il legamento crociato quando avevo diciassette anni,» disse all’improvviso. «Pensavo che il mio sogno fosse finito. Ma avevo un allenatore che credette in me. Pagò l’intervento e non mi lasciò mollare. Mi ricordi molto lui.»
Non sapevo cosa dire, così mi limitai a guardarlo e ad annuire. Ma dentro di me qualcosa cambiò. Forse non ero così solo come credevo.
Il medico sportivo fece i test, la risonanza, e il verdetto non fu buono: lesione parziale. Non gravissima, ma non si sarebbe rimarginata da sola. Serviva fisioterapia. Riposare non bastava. Continuare a correre l’avrebbe solo peggiorata.
L’allenatore pagò sei sedute in anticipo.
Fece anche in modo che la scuola mi desse il permesso di frequentare la fisioterapia durante le lezioni, una volta a settimana.
Da quel momento, tutto cambiò. Zoppicavo ancora, ma ora avevo un piano. Avevo speranza.
A scuola, la voce si sparse. Qualcuno mi guardava con invidia, altri con ammirazione. Il mio amico Luan mi disse:
«Fratello, che fortuna. La maggior parte degli allenatori non si sarebbe mai preso questo disturbo.»
Io però non mi sentivo fortunato. Mi sentivo in colpa.
Un giorno, dopo la terapia, chiesi all’allenatore:
«Perché stai facendo tutto questo? Non sai nemmeno se tornerò in campo.»
Mi guardò come se avessi detto una sciocchezza.
«Non è questo il punto. Sei un ragazzo, hai dei sogni. Qualcuno deve aiutarti a non perderli.»
E così feci progressi. Lentamente, dolorosamente, ma feci progressi.
Arrivò l’estate e potevo di nuovo correre. Poi allenarmi. Poi giocare nelle partitelle. Non nelle partite ufficiali, non ancora. Ma l’allenatore mi promise che la stagione successiva sarei tornato più forte.
Poi arrivò un’altra svolta.
Mio padre perse il lavoro in fabbrica. Mia madre prese turni di notte, ma non bastava. A luglio ricevemmo lo sfratto.
L’allenatore lo venne a sapere, non so come. Forse glielo disse Luan.
Questa volta non offrì denaro. Offrì qualcosa di meglio.
Chiamò un amico che dirigeva un campo estivo di calcio e mi fece avere un posto come assistente allenatore. Ricevevo un piccolo compenso e il pranzo gratis. Bastava per aiutare i miei e tenermi impegnato.
Iniziai quella stessa settimana.
Insegnavo ai bambini a passare la palla, a proteggere il possesso, a muoversi leggeri. Il ginocchio faceva ancora male, ma ce la facevo. E amavo vedere la gioia nei loro occhi quando riuscivano in un nuovo gesto tecnico.
Un pomeriggio, una mamma mi disse:
«Sei davvero bravo con loro. Hai mai pensato di fare l’allenatore?»
Risi. «No, io voglio solo giocare.»
Ma quelle parole mi rimasero dentro.
Quell’estate mi insegnò molto. Non solo sulla guarigione o sul calcio, ma sul valore di restituire ciò che si riceve.
La mia famiglia riuscì a tirare avanti. Ci trasferimmo in un appartamento più piccolo: una stanza per tutti e quattro. Ma bastava.
Quando ricominciò la scuola, tornò anche la nuova stagione. E tornai titolare.
Alla prima partita segnai un gol e feci due assist. L’allenatore sorrise e annuì. Non disse altro, ma vidi l’orgoglio nei suoi occhi.
A metà stagione, uno scout venne a una partita. L’allenatore lo aveva invitato senza dirmelo.
Dopo la gara, lo scout mi propose un provino per una squadra giovanile regionale, con possibilità di borsa di studio.
Andai, e ce la feci.
Fu un anno frenetico. Allenamenti, viaggi, scuola. Ma ogni volta che pensavo di non farcela, ricordavo ciò che il mio allenatore aveva fatto per me. E andavo avanti.
Poi, l’ultimo anno di liceo, un altro colpo.
A mia madre diagnosticarono un tumore al seno, allo stadio iniziale. Fu come un treno in corsa.
Le borse di studio, il college, i sogni… tutto sembrava perdere importanza.
Dissi all’allenatore che forse avrei mollato.
Non rispose subito. Poi disse:
«Non posso dirti cosa fare. Ma so che tua madre non vuole che tu smetta. È orgogliosa di te. Lascia che questo ti dia forza.»
Aveva ragione.
Mi allenai più che mai. Mi alzavo presto, studiavo, aiutavo mia madre la sera. Scrivevo le domande per l’università di notte, dopo averle sistemato le medicine.
A marzo arrivò un’e-mail: borsa di studio completa. Un’università a tre ore di distanza. Ottimo programma calcistico, e uno di medicina sportiva tra i migliori. Quello era diventato il mio nuovo sogno: la fisioterapia sportiva, per aiutare altri ragazzi come me.
Corsi dall’allenatore con la lettera in mano. Lui la sollevò come fosse un trofeo e disse:
«Te l’avevo detto.»
Mia madre pianse. Mio padre mi abbracciò più forte che mai.
Passai i mesi successivi a prepararmi, a salutare la squadra.
All’ultima partita, l’allenatore mi chiamò davanti a tutti.
«Voglio dire una cosa su questo ragazzo,» disse, la voce rotta dall’emozione. «Mi ha insegnato che aiutare qualcuno non significa aspettarsi qualcosa in cambio. Significa trasmettere ciò che hai ricevuto. E lui andrà lontano. E non dimenticherà mai da dove è partito.»
Quella notte mi diede una busta. Dentro c’era un biglietto e un assegno da cinquecento dollari. “Fondo d’emergenza. Usalo solo se ne hai davvero bisogno.”
Non l’ho mai incassato. Lo conservo ancora.
L’università fu dura. Il ginocchio mi dava ancora problemi. Quasi fallii chimica il primo semestre.
Ma ricordai tutte le persone che avevano creduto in me. E continuai.
All’ultimo anno ero capitano della squadra. Avevo buoni voti. Mi iscrissi alla specialistica in fisioterapia.
Poi, un’altra svolta.
L’università avviò una collaborazione con un programma giovanile in un quartiere disagiato. Cercavano volontari.
Indovina chi si iscrisse?
Ogni sabato mattina lavoravo con ragazzi che mi ricordavano me stesso: zoppicanti, timidi, ma pieni di potenziale.
Uno di loro, Mateo, zoppicava più di quanto avessi mai fatto io. Capivo che non era una cosa da poco. Il suo allenatore mi disse che la famiglia non aveva assicurazione.
Quella storia la conoscevo bene.
Così chiamai il mio vecchio allenatore. Gli raccontai tutto.
Lui rise: «Guarda un po’… il cerchio si chiude, eh?»
Mi aiutò a raccogliere fondi per Mateo. Raccontai la mia storia online, e la gente donò più di quanto avessi immaginato.
Riuscimmo a farlo visitare da un medico e a iniziare la riabilitazione. Sua madre mi abbracciò piangendo. Disse che gli avevo cambiato la vita.
Fu in quel momento che capii davvero cosa volevo fare: non solo curare ginocchia, ma ridare speranza.
Sono passati tre anni da allora.
Ora lavoro come fisioterapista in un centro sportivo giovanile. Il mio lavoro non è lussuoso, e non mi arricchisce.
Ma ogni giorno aiuto qualcuno a camminare di nuovo. A correre. A sognare.
E, a volte, quando vedo un ragazzo che zoppica cercando di nasconderlo, mi inginocchio e gli chiedo:
«Sai quanto potrebbe essere grave?» — proprio come fece il mio allenatore con me.
E poi, lo aiuto a guarire.
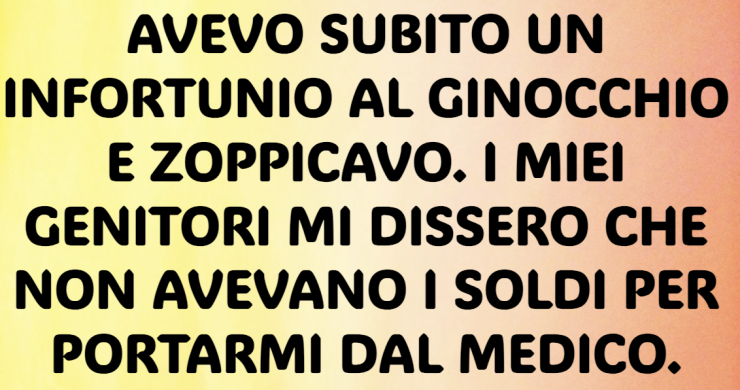
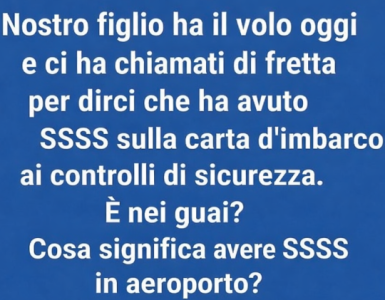


Add comment