Ho 44 anni, tre figli, un lavoro che mi assorbe e giornate piene fino all’ultimo minuto. Una telefonata di rabbia, poi tre giorni di silenzio. Quando ho aperto la porta di casa di mia madre, il tempo si è fermato.
Vivo in corsa. La sveglia suona quando fuori è ancora buio, preparo le colazioni, controllo gli zaini, scappo al lavoro. Rientro nel tardo pomeriggio, accendo i fornelli, riordino, aiuto nei compiti, stendo il bucato. Ogni sera mi dico che troverò un’ora anche per me, ma l’orologio scivola via tra stoviglie e quaderni. In passato, quando i bambini erano piccoli, mia madre veniva spesso: cucinava per tutti, li accompagnava al parco, si sedeva con loro a leggere. Mi regalava un’ora di silenzio, un tè caldo, la sensazione che tutto fosse sotto controllo.
Poi la più piccola ha compiuto dodici anni e quell’aiuto si è diradato. Le sue chiamate, però, sono aumentate. Mi raccontava dettagli di giornate tutte uguali, che io ascoltavo tra una pentola che bolliva e la lavatrice che suonava. Le promesse di “ti richiamo dopo” saltavano una dopo l’altra, fino a trasformarsi in una scia di richieste perse e di richiami senza risposta.
Quel giorno ero stremata. Il telefono ha squillato di nuovo. La sua voce, dall’altra parte, chiedeva di passare subito da lei. Ho sentito un nodo stringersi in gola, come se le parole si fossero accumulate per mesi senza trovare spazio per uscire. “Mamma, smettila di chiamare ogni giorno! Sono al lavoro tutto il giorno e poi devo occuparmi dei bambini e della casa. Non posso venire da te adesso!” ho gridato, senza riuscire a fermarmi. “E non chiamarmi più!” Ho riattaccato e ho appoggiato il telefono sul tavolo come se scottasse.
Sono passati tre giorni. All’inizio mi è sembrato un sollievo quel silenzio, poi si è trasformato in un rumore sordo che cresceva minuto dopo minuto. Ho provato a convincermi che stesse uscendo con le amiche, che avesse deciso di prendermi sul serio, di darmi respiro. Ma ogni volta che guardavo il telefono, la mancanza del suo nome sullo schermo mi premeva sul petto.
Il terzo giorno ho preso le chiavi e sono andata da lei. La luce del pianerottolo ronzava, la porta era chiusa. Ho bussato, una volta, poi due. Nessuna risposta. Ho infilato la chiave nella serratura con una cautela che non mi appartiene, come se il silenzio potesse rompersi da un momento all’altro. Dentro, la casa odorava di pulito e di sapone, come sempre. Ho chiamato il suo nome. Niente. Il corridoio sembrava più lungo, le pareti più strette.
In camera da letto l’ho vista. Distesa sul letto, composta. Per un istante ho pensato stesse dormendo. Ho fatto un passo, poi un altro, e mi sono fermata accanto al comodino. Il suo viso era quieto, come sospeso. “Mamma?” ho detto, ma la mia voce non arrivava fino a lei. Ho capito. E il mondo ha rallentato.
Le lacrime sono scese senza fare rumore. Mi sono guardata intorno in cerca di qualcosa a cui aggrapparmi. Sul tavolo del soggiorno c’era una scatola: un telefono nuovo, ancora chiuso. Ho appoggiato la mano sulla confezione come se potessi sentirne il calore. Ho pensato che forse era per me, che avesse provato a dirmelo, che quelle chiamate fossero l’ultimo tentativo di consegnarmi un dono e, con lui, un pezzo di tempo da condividere.
Sono rimasta lì a contare gli “avrei potuto”. Avrei potuto passarla a trovare la sera prima, anche solo per dieci minuti. Avrei potuto richiamarla il giorno stesso, invece di farmi schiacciare dall’ansia della lista di cose da fare. Avrei potuto chiederle come stava, davvero, senza scappare. Avrei potuto spegnere il fornello un minuto prima, dire ai bambini “torno subito”, infilare il cappotto e uscire. Invece ho scelto di restare dalla parte comoda della stanchezza, quella che giustifica tutto. E ora è tardi.
Ho ripensato a quando mi aspettava al cancello della scuola, al suo passo un po’ svelto per starmi dietro quando correvo verso casa, al modo in cui fingeva di niente quando mi leggeva in faccia che qualcosa non andava. Ho ripensato alle telefonate in cui restavamo in silenzio per qualche secondo, senza sapere come colmare lo spazio tra noi, e al valore di quei secondi che, a volte, contengono più di mille parole.
Ho messo la scatola del telefono nella borsa, non come un trofeo, ma come una promessa. Non so cosa farò domani, né come racconterò ai miei figli che la nonna non c’è più. So soltanto che quella frase — “E non chiamarmi più!” — resterà appesa tra me e la linea che si è interrotta troppo presto. E che d’ora in avanti cercherò di fermare il tempo quando chi amo mi chiama, anche solo per dire nulla. Perché a volte il nulla è il modo in cui il cuore chiede di essere ascoltato.
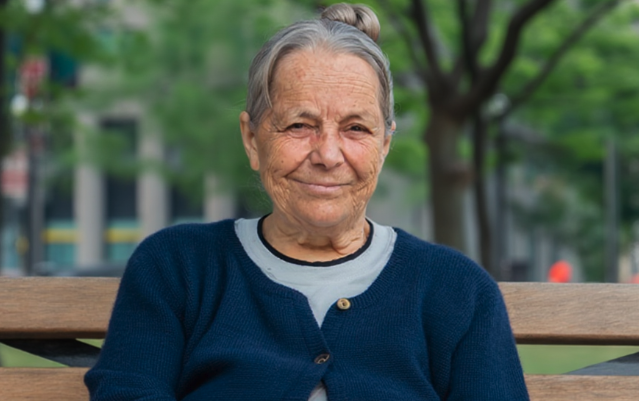

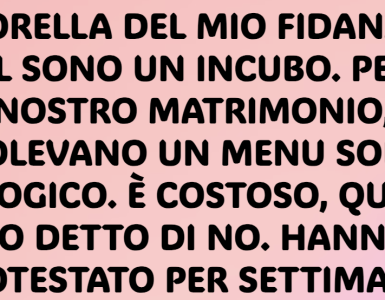

Add comment