Mi stavo per sposare. Mio marito era già stato sposato in passato, mentre per me era la prima volta. Avevamo deciso di occuparci separatamente dei nostri abiti per il matrimonio. Io avevo comprato il mio vestito, le scarpe, fissato un appuntamento con la truccatrice e trovato un fotografo. Chiesi al mio futuro marito come andassero le cose con il suo abito e le scarpe, e lui mi rispose:
«Ci penserò io. Non preoccuparti.»
Non insistetti oltre. Pensai sapesse il minimo indispensabile. Era più grande di me di sette anni, e la sua calma sicura di sé di solito mi tranquillizzava. Ma, in fondo, avevo una piccola sensazione che qualcosa non andasse.
Ignorai quel presentimento. Organizzare un matrimonio è già abbastanza stressante. Tra mia zia che insisteva per avere un violinista e il responsabile della location che continuava a confondere le date, non avevo tempo di fare anche da balia a un uomo adulto.
La mattina del matrimonio mi svegliai alle sei, con le farfalle nello stomaco. La mia migliore amica, Marisa, aveva dormito con me la notte prima. Mi preparò un caffè e, ancora in pigiama, mi fece un discorso incoraggiante.
«Ti stai sposando con qualcuno che ti fa ridere quando piangi», disse. «È questo che conta.»
Sorrisi, scrollandomi di dosso lo strano sogno che avevo fatto — io all’altare, e lui con scarpe spaiate e una cravatta di SpongeBob. Sciocchi nervi, pensai.
Alle dieci ero già sulla sedia del trucco. Tutto sembrava un sogno. Loredana, la truccatrice, era dolcissima e fece magie con il mio viso. Il fotografo scattava in silenzio, catturando attimi che nemmeno notavo.
Il mio telefono vibrò:
«Sto arrivando. Non sbirciare!» scrisse lui.
Sorrisi. Era sempre un po’ teatrale. Pensai intendesse che non voleva che lo vedessi prima della cerimonia. Che dolce, vero?
Quando arrivai al piccolo vigneto dove si sarebbe tenuta la cerimonia, fui accolta da sguardi e sospiri. Mi dissero che sembravo «uscita da una fiaba», «una dea» e «una sposa che ha dormito davvero la notte prima» — il mio complimento preferito.
Gli invitati erano seduti. Il suono delicato di un quartetto d’archi riempiva l’aria tiepida. Io ero dietro una piccola siepe, pronta a entrare. Mio padre era accanto a me, asciugandosi una lacrima con il fazzoletto.
«Pronta, tesoro?» mi chiese.
Annuii, con il cuore che batteva all’impazzata.
Ero pronta.
Poi… la musica cambiò.
Feci i primi passi fuori dalla siepe e guardai verso l’altare.
E lo vidi.
Il mio sposo.
Con le sneakers.
Bianche. E nemmeno nuove. Pieghe, un alone di caffè sulla punta. Indossava una camicia sbottonata, fuori dai pantaloni, e una giacca che mi sembrava quella del compleanno di mio cugino, tre mesi prima.
Sgranai gli occhi. I miei passi rallentarono. Gli invitati mormoravano.
Lui mi sorrise, facendomi un cenno con il pollice alzato.
In quel momento rimasi pietrificata. Non tanto per l’abbigliamento — o forse sì, anche per quello — ma perché capii che non stava scherzando. Non era uno scherzo, né un imprevisto dell’ultimo minuto. L’aveva scelto.
La cerimonia cominciò. Pronunciammo le nostre promesse e, non so come, riuscii a dire «Lo voglio», anche se una parte di me voleva urlare:
«Quelli sono pantaloni della tuta?!»
Non lo erano. Erano jeans. Ma comunque.
Al ricevimento, sotto un cielo illuminato da fili di luci, il cibo era perfetto, il vino scorreva, e la pista da ballo era piena. Tutti ridevano, dicendo che eravamo «una coppia originale», «così rilassati».
Ma io non ero rilassata. Non dentro.
Più tardi, dopo il taglio della torta e le vecchie canzoni del DJ, lo presi da parte.
«Perché ti sei vestito così?» chiesi, trattenendo la rabbia.
Lui scrollò le spalle. «Volevo stare comodo. È anche il mio giorno, no?»
Lo fissai. «Non potevi dirmelo prima?»
«Non pensavo fosse importante», rispose, sorseggiando il suo drink. «Non è una questione di vestiti.»
«È una questione di rispetto», sussurrai.
Quella notte piansi in bagno, mentre lui russava sul letto.
La luna di miele a Santorini si fece lo stesso, ma non riuscivo a togliermi quella sensazione. Ogni volta che vedevo le sue sneakers nelle foto, mi si stringeva lo stomaco.
La cosa peggiore? Tutti trovavano la cosa adorabile.
«Che uomo disinvolto!»
«Che fortuna, uno che non si cura delle apparenze!»
«Deve amarti davvero per essere se stesso così.»
Ma io non mi sentivo fortunata. Mi sentivo invisibile.
Dopo il viaggio, ebbi con lui il nostro primo vero litigio da marito e moglie.
«Ho pianificato per mesi», dissi. «E tu non sei riuscito nemmeno a metterti delle scarpe decenti.»
Lui alzò gli occhi al cielo. «Sono già stato sposato. Fidati, i vestiti non contano.»
«Ecco il punto», replicai. «Tu sei già stato sposato. Per me era la prima volta. E tu l’hai resa piccola.»
Rimase in silenzio.
«Non ci avevo pensato così», ammise infine.
Passarono settimane. Ci trasferimmo insieme, mescolando mobili e abitudini. Scoprimmo chi caricava male la lavastoviglie e chi russava di più. Ridevamo spesso, ma certe crepe restavano.
Un giorno, mentre sistemavo delle scatole dal suo vecchio appartamento, trovai un album.
Il suo primo album di nozze.
Lo aprii piano.
Lui, in smoking nero. Scarpe lucide. Fiore all’occhiello.
Elegante. Fiero.
Entrò nella stanza e si bloccò.
«Non volevo tenerlo», disse.
«Hai indossato un completo per lei», risposi.
Sospirò. «Quel matrimonio… cercavo di impressionare tutti. I suoi genitori, gli invitati, persino me stesso. L’ho odiato.»
«E con me?» chiesi.
«Con te non volevo fingere.»
Quelle parole mi colpirono al cuore.
Ma chiesi comunque:
«Non meritavo un po’ di finzione, solo per un giorno?»
Si sedette accanto a me.
«Tu meritavi tutto. Ma ho creduto che mostrarti il vero me fosse più importante. Ora capisco che ho frainteso.»
Non parlammo più quella sera. Ma qualcosa cambiò.
Qualche giorno dopo tornò a casa con una scatola.
«Aprila», disse.
Dentro c’erano un paio di décolleté color crema e un biglietto:
“Per il nostro rifacimento.”
«Come?» chiesi, stupita.
«Lo rifacciamo», disse sorridendo. «Avrai il matrimonio che hai sempre sognato. Io prenderò lo smoking. Scarpe lucide e tutto il resto.»
Pensai stesse scherzando. Ma non lo era. Organizzò tutto.
Una piccola cerimonia di rinnovo delle promesse. Solo noi, i miei genitori, suo fratello e Marisa.
Richiamò persino la stessa truccatrice e il fotografo.
Questa volta, arrivò in completo elegante. Cravatta. Gemelli. Scarpe vere. Niente sneakers.
Durante le promesse disse una frase che non dimenticherò mai:
«Pensavo che essere me stesso significasse non piegarmi mai. Ma il vero amore è capire quando bisogna mettersi in tiro, quando presentarsi, e quando dire: “Se conta per te, allora conta anche per me.”»
Questa volta, piansi — ma per le ragioni giuste.
Ballammo scalzi al tramonto. Nessun DJ, solo il vecchio stereo di mio padre con la nostra canzone preferita.
Guardando i suoi piedi — nudi, impolverati, sinceri — risi.
Non perché avesse dimenticato le scarpe.
Ma perché sapevo che, stavolta, non l’aveva fatto.
Sono passati tre anni. Litighiamo ancora, ogni tanto — per il termostato o la spesa — ma non si è mai più presentato con le sneakers a un’occasione importante.
Ha imparato.
E anch’io.
A volte, le persone non capiscono il peso delle loro scelte. Non perché non gliene importi, ma perché non hanno mai imparato a guardare le cose da un’altra prospettiva.
Se me ne fossi andata dopo quel primo matrimonio, mi sarei persa l’uomo che, una volta capito, ha fatto di tutto per rimediare.
Non è perfetto. Ma nemmeno io lo sono.
E forse è proprio questo il punto.
Si cresce.
Insieme.
E quando succede, è meglio di qualunque matrimonio da favola.
Se stai preparando un matrimonio, o semplicemente iniziando una vita con qualcuno, parla delle scarpe. Parla di tutto.
Ma, soprattutto, ascolta.
Le persone dimostrano amore in modi strani.
Ma il vero amore impara a dimostrarlo meglio.
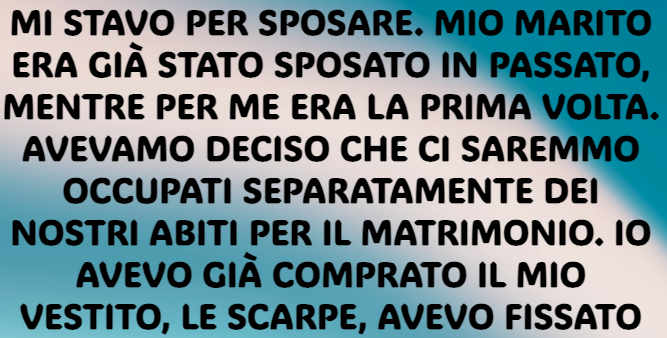
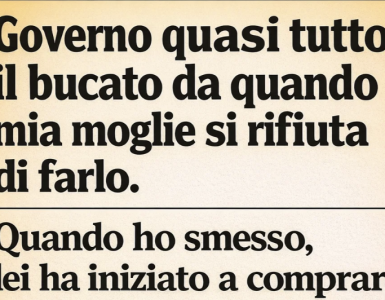


Add comment