Ogni persona che incontro parla di un talento speciale, dice che dentro quel piccolo studio riesce a parlare senza paura.
Invece, mentre ascolto con calma, gli occhi fissi, nella testa giro tra pentole e sughi da preparare.
Succede anche che le sedute si allungano piano, non per scelta vera, più per una cifra che devo versare ogni fine mese, qualcosa legata alla casa dove abito.
Paola è il mio nome. Cinquantadue anni addosso.
Lavoro come psicoterapeuta, qualcuno dice che valga qualcosa.
Il consultorio si trova in città, vicino alla piazza grande. Ci sono sedie morbide, fatte di velluto scuro. La luce non abbaglia mai.
Persone arrancano fin qui con ferite diverse:
storie spezzate dal tradimento,
paure senza forma,
padri e madri che rubano l’aria,
assenze pesanti dopo un funerale.
Le faccio entrare. Parlo piano, niente toni teatrali.
Faccio le domande giuste:
— “E questo come ti fa sentire?”
— “Cosa direbbe il tuo bambino interiore?”
Loro piangono, si sfogano, mi guardano con gratitudine infinita.
— “Dottoressa, lei mi ha salvato la vita.”
A volte penso a cosa compro al supermercato mentre parlano.
Il motivo? Non ne posso più di sentire sempre le stesse cose.
Da anni ascolto gente che ripete scene uguali, vuote, senza fine.
L’uomo dell’una e mezza dice che sua madre non gli dava attenzione.
Annuisco con calma, però dentro conto i minuti.
Devo passare dal ferramenta.
Forse ho lasciato il fornello acceso.
Di tanto in tanto butto lì un “Mh-mh” oppure un “Sì, giusto”,
così parlano ancora, certi che li sto ascoltando davvero.
A me sembra di recitare sempre la stessa scena,
notte dopo notte, con persone nuove ogni volta.
Quello che pesa di più, quello che mi lascia una sensazione strana dentro, riguarda i soldi in ballo.
Prendo in cura un uomo, si chiama Marco.
Oggi sta meglio. I problemi grossi li ha superati da metà anno.
La scelta giusta sarebbe parlare chiaro:
— “Marco, ora puoi proseguire per conto tuo.”
Solo che lui torna ogni settimana.
Mi consegna ottanta euro senza mai saltare un appuntamento.
Licenziarlo vorrebbe dire rinunciare a trecentoventi euro fissi ogni mese.
A breve scade il pagamento dell’assicurazione auto.
Allora che succede dopo?
Cerco qualcosa di diverso da agitarmi addosso.
Rosicchio i pensieri più nascosti finché non ne trovo uno buono per tormentarmi.
Me lo attacco alle spalle come un peso conosciuto.
Fingo che sia evoluzione,
mentre gli offro la mia paura di essere lasciata sola.
Qualche volta penso di essere come un vampiro rovesciato.
Appena qualcuno riversa su di me il suo veleno nero, lo bevo tutto intero —
e dentro brucia, sporca l’anima, arrivo a casa svuotata, muta per ore.
In compenso ricevo denaro sonante,
pur sapendo benissimo di non poter offrire miracoli veloci.
Ho smesso di fidarmi delle emozioni.
Se oggi varca la soglia una persona in lacrime,
la prima cosa che passa nella mente non è tenerezza.
Piuttosto:
“Bene, qui ci vorrà tempo. Almeno ventiquattro mesi davanti.”
Poi rientro tra le mura di casa,
prendo un bicchiere e lo riempio di vino rosso.
Parlo da sola: mi accuso di falsità.
Sono simile a quei sacerdoti che parlano di salvezza
pur avendo perso ogni certezza.
Io racconto di equilibrio mentale,
mentre in realtà gestisco sofferenze altrui
come scartoffie su una scrivania grigia.
Paola mi chiamo, cinquantadue primavere sulle spalle.
A tutti do retta, ascolto i loro guai senza fiatare,
però nessuno sa che dentro di me qualcosa si è spento per sempre.
Quell’empatia tanto lodata?
Non c’è più.
La porto fuori lo stesso, ogni giorno,
come una maschera pesante.
Ottanta euro alla volta,
vendo quello che non esiste più.

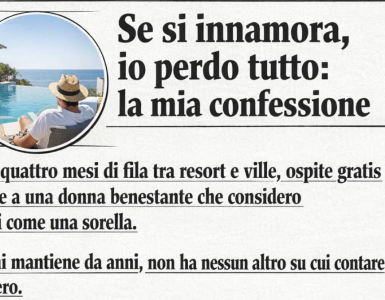
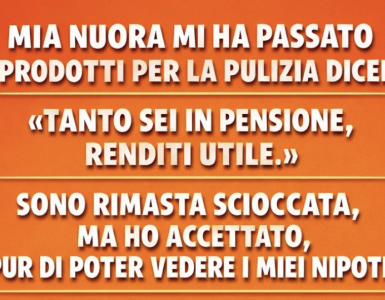
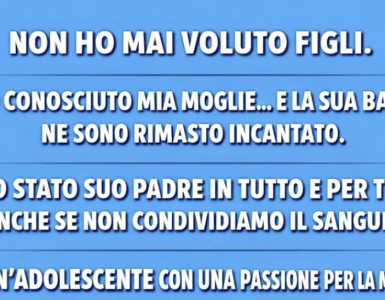
Add comment