Mio figlio si è trasferito con la sua fidanzata l’anno scorso. Da allora, non è più venuto a trovarmi.
Abita a soli dieci minuti da qui.
Gli mando ancora qualche soldo di tanto in tanto, ma lui non risponde né alle chiamate né ai messaggi.
La scorsa settimana mi sono sentita sola.
L’ho chiamato più volte, finché finalmente ha risposto:
«Sono occupato, mamma. Per favore, smetti di chiamarmi ogni giorno. Ti verrò a trovare quando potrò, va bene?»
Non era arrabbiato.
Non era crudele.
Era… indifferente.
Ed è stata proprio quell’indifferenza a spezzarmi.
Sono rimasta con il telefono in mano, ascoltando il silenzio dopo il beep.
Non volevo disturbare. Volevo solo sentire la sua voce.
Mi mancava il ragazzo che sbucava in cucina per chiedere cosa ci fosse per cena.
Quello che mi abbracciava senza motivo.
Si chiama Nishan. Ha ventisette anni.
Un tempo era gentile, tranquillo, dolce.
Ma da quando frequenta Zahra, qualcosa è cambiato.
Non la biasimo, non la conosco abbastanza.
L’ho vista solo una volta, quasi un anno fa, prima che si trasferissero insieme in quel condominio vicino ai binari del treno.
Avevo preparato il kheer, il suo dolce preferito.
Lei ne assaggiò appena un cucchiaio.
E lui non ne chiese il bis.
Lui, che da bambino ne mangiava tre porzioni.
Avrei dovuto capirlo allora.
Dopo quella visita, solo silenzio.
Continuavo a mandargli qualche soldo: 50, 100 dollari.
Scrivevo nel messaggio: “Comprati qualcosa di dolce.”
Nessuna risposta.
Mi dicevo che era solo occupato.
Che forse voleva costruirsi la sua vita senza sentirsi ancora “il figlio di mamma.”
Ma quando l’ho sentito così distante, come se fossi un fastidio, qualcosa dentro di me si è spento.
Non l’ho più chiamato.
Ho cominciato a fare quello che faccio quando la tristezza mi prende: pulire.
Ho lucidato il tavolo quattro volte in un’ora.
Ho piegato lenzuola di letti rimasti vuoti.
Poi, un pomeriggio, qualcuno ha bussato alla porta.
Tre colpi brevi. Non era lui.
Fuori c’era una donna. Cinquant’anni forse.
Alta, con occhi stanchi ma gentili.
Aveva una cartella in mano.
«È lei la signora Dutt?» chiese.
Annuii.
«Mi chiamo Reena. Ho conosciuto suo figlio.»
Il cuore mi fece un balzo.
«Sta bene?»
Lei abbassò lo sguardo.
«Lui abitava nello stesso stabile di mia figlia.
Pensavo dovesse sapere alcune cose.»
La feci entrare. Si sedette al tavolo e posò la cartella.
«Mi scusi se mi permetto,» disse piano. «Anch’io sono una madre.»
Aprì la cartella e fece scorrere una foto verso di me.
Nishan.
Seduto su un gradino, magro, il viso spento.
«Questa è stata scattata sei settimane fa,» spiegò.
«Viveva nel palazzo di mia figlia, ma non più con Zahra.
Si erano lasciati quattro mesi fa.»
Il sangue mi gelò.
«Cosa? Ma mi aveva detto che stavano ancora insieme!»
Reena sospirò.
«No. Dopo la rottura, non aveva un posto dove andare.
Ha dormito per un po’ su un materasso nella lavanderia del condominio.»
Mi si mozzò il fiato.
«La lavanderia?»
«Sì. Poi ha perso il lavoro ad aprile.
Non voleva che nessuno lo sapesse.
Diceva sempre che stava “sistemando le cose”.
Alla fine qualcuno lo ha scoperto e gli ha chiesto di andarsene.»
«Vuole dire che… mio figlio è stato senza casa?»
«Per un periodo, sì.
Poi è sparito. Due settimane fa ha lasciato il palazzo.»
Non riuscivo a respirare.
Perché non mi aveva chiamata?
Perché non era tornato a casa?
Reena mi toccò la mano.
«A volte la vergogna pesa più della fame.
Ho visto quello sguardo altre volte.
Gente che pensa di aver deluso chi li ama.»
Mi vennero le lacrime.
«Gli mandavo soldi. Piccole somme. Ma se avesse chiesto—»
«Probabilmente non li ha mai usati,» disse lei. «Continuava a dire che voleva cavarsela da solo.»
Mi lasciò un numero — quello di sua figlia.
Disse che mi avrebbe chiamata se avesse saputo qualcosa.
Quando se ne andò, rimasi seduta con la foto in mano.
Poi arrivò la rabbia.
Non verso Nishan.
Verso me stessa.
Perché avevo cresciuto un figlio che credeva di non poter tornare a casa.
Quella sera cucinai khichdi con tanto ghee, il suo piatto preferito.
La misi in frigo.
Non sapevo dove fosse, ma volevo che la casa profumasse di “bentornato”.
Passarono cinque giorni.
Poi un altro bussare.
Corsi alla porta.
Non era lui.
Era un ragazzo, giovane, con una busta di spesa.
«Lei è la mamma di Nishan?»
«Sì,» risposi.
«Vive nel rifugio di Sundown Street.
Mi ha aiutato a compilare il curriculum.
Parlava poco, ma quando ha nominato i suoi sottaceti di guava, sorrideva.
Ho pensato che avrebbe voluto sapere che sta bene.»
Mi sentii mancare.
«È ancora lì?»
«Credo di sì,» disse il ragazzo. «Non resta mai troppo nello stesso posto, ma lo vedevo spesso.»
Lo ringraziai.
Gli infilai venti dollari in tasca.
Poi presi due portavivande: khichdi e sottaceti di guava.
E presi l’autobus.
Quando entrai nel rifugio, lo vidi subito.
Curvo su un portatile vecchio.
Indossava lo stesso giubbotto della foto.
Mi avvicinai piano.
Lui alzò lo sguardo.
I nostri occhi si incontrarono.
«Ma?»
«Ciao, beta.»
Scoppiò a piangere.
Lì, davanti a tutti.
Senza vergogna.
Solo lacrime vere, di un figlio che finalmente si lasciava abbracciare.
«Non volevo che lo sapessi,» sussurrò. «Ho rovinato tutto.»
«Non hai rovinato niente,» dissi. «Hai solo dimenticato dov’è casa.»
Sedemmo fuori.
Mangiò tutto. Anche il sottaceto.
Aveva fame. Di cibo, di affetto, di perdono.
Mi raccontò tutto.
Il lavoro perso.
Le bugie a Zahra.
La paura di deludermi.
«Meglio soffrire da solo,» disse, «che vedere la delusione nei tuoi occhi.»
Gli presi la mano.
«Delusione no.
Ma magari un ceffone, sì.»
Rise.
La prima risata vera dopo mesi.
Lo riportai a casa quella sera.
Una doccia calda.
Vestiti puliti.
Il suo vecchio letto.
Rimase con me per settimane.
Grazie alla figlia di Reena, trovò un lavoretto part-time.
Non era molto, ma era dignità.
Un nuovo inizio.
Ora cucina anche lui. Male, ma con amore.
A volte brucia il riso e ordiniamo la pizza.
Va bene così.
Mi chiama di nuovo “Ma”.
E la scorsa settimana mi ha portato fuori a mangiare dosa, nello stesso ristorante dove andavamo quando era all’università.
Ha insistito per pagare lui.
«Credevo di aver perso tutto,» ha detto mentre uscivamo. «Ma forse era solo un modo per ritrovare ciò che conta davvero.»
Gli ho sorriso.
«La vita ha modi strani di riportarci a casa.»
Forse è questo il senso.
A volte le persone spariscono non perché non ci tengono,
ma perché si vergognano di farsi vedere nel momento della loro fragilità.
Ma l’amore vero — quello ostinato, silenzioso, che non chiede nulla —
resta lì.
Ad aspettare, con una pentola di khichdi e un barattolo di sottaceti di guava.
Se anche tu hai qualcuno da cui ti sei allontanato, prova a bussare di nuovo.
Non con rabbia, ma con tenerezza.
A volte, per far tornare qualcuno, basta fargli sapere che la porta è ancora aperta.
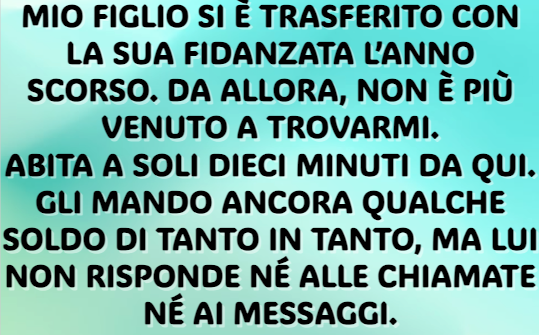



Add comment