Ieri mattina mi ha chiamato papà. Mia sorella era al pronto soccorso e serviva qualcuno che andasse a prenderla.
Papà vive in Oregon. Io sono a Manchester — venticinque minuti, al massimo, dall’ospedale. Mi ha implorato di andarci. Ho detto di no. È rimasto in silenzio, poi, all’improvviso, ha cominciato a piangere.
Mi ha completamente spiazzato.
Mio padre non piange. È uno di quei tipi “vecchia scuola”, convinti che tutto si risolva con un po’ di lavoro, amore severo e una buona tazza di tè. L’ultima volta che l’ho visto con gli occhi lucidi era il giorno in cui abbiamo seppellito il nostro cane, e anche allora si era voltato per non farsi vedere.
Ma quella volta, al telefono, ha pianto.
«Ha paura, Adam,» ha detto con la voce che tremava. «È rimasta da sola per ore prima di dire a qualcuno che stava male.»
Mi sono strofinato gli occhi, ancora intorpidito dal sonno. «Papà, ho riunioni tutto il giorno. Non posso semplicemente saltarle.»
«Pensi che il lavoro conti più di tua sorella?»
«È un’adulta. Starà bene. Se l’hanno dimessa, significa che non era grave.»
È rimasto in silenzio per qualche secondo.
Poi ha detto: «Quando ti sei rotto il polso cadendo dalla giostra a scuola, hai pianto tutto il tragitto fino al pronto soccorso. Io ero al lavoro. Tua madre era nel panico. Mara — tua sorella dodicenne — ti ha portato fino alla macchina, ti ha tenuto la mano per tutto il tempo. Non l’ha mollata nemmeno quando ti hanno fatto la lastra.»
Sono rimasto zitto.
«Ora lei è quella che soffre, e tu non riesci a trovare mezz’ora?»
«Papà…»
Ma ha riattaccato.
Sono rimasto a fissare il telefono, con lo stomaco in subbuglio. Sapevo di essere stato freddo. Ma avevo già spostato due riunioni quella settimana, e il mio capo aveva fatto una battuta velenosa sul “farsi vedere di più”. Non potevo rischiare un’altra assenza. O almeno, è quello che mi sono raccontato.
Ho mandato un messaggio a Mara: Papà mi ha detto che stai meglio. Riposati. Fammi sapere se ti serve qualcosa nei prossimi giorni.
Non ha risposto.
Ho pensato stesse dormendo. O che fosse arrabbiata. O entrambe le cose.
La sera ho chiamato nostra cugina Lydia, per senso di colpa più che altro.
«È a casa della nonna,» mi ha detto. «Non voleva tornare nel suo appartamento da sola. Diceva che era troppo silenzioso.»
«Chi l’ha accompagnata?»
«Una sua compagna di corso. Quella ragazza, Priya, te la ricordi?»
Vagamente. Alta, con la felpa del Manchester United al barbecue dell’estate scorsa.
«Ha aspettato quasi due ore che venisse a prenderla,» ha aggiunto Lydia, come se sapesse esattamente quanto mi sentissi in colpa.
Quella notte non ho chiuso occhio. Continuavo a immaginare Mara da sola nella sala d’attesa dell’ospedale, pallida, stanca, che scorreva la rubrica del telefono sperando che qualcuno — chiunque — rispondesse.
Mi sono svegliato sentendomi un idiota.
Eppure, anche allora, non l’ho chiamata.
Mi sono nascosto dietro ai fogli di calcolo e ai messaggi di lavoro, fingendo che non fosse successo nulla. È passata una settimana. Poi due. Nessuna parola da lei.
Finché papà non ha richiamato.
«Non ti ho cresciuto per essere così,» ha detto appena ho risposto.
«Così come?»
«Distaccato. Irresponsabile.»
«Sul serio?»
«È tua sorella.»
«Non l’ho mica uccisa, papà.»
È rimasto in silenzio. Poi, calmo, ha detto: «Le hai spezzato il cuore. A volte è anche peggio.»
Non ho risposto.
«Non le serve un “scusa”. Ha bisogno di sapere che ti importa ancora.»
La verità è che Mara e io non siamo sempre stati così. Da bambini eravamo inseparabili. Lei ha diciotto mesi più di me, e abbiamo condiviso la stessa stanza fino ai miei tredici anni. Parlottavamo di fantasmi, facevamo scherzi ai cugini, costruivamo tende di lenzuola che occupavano tutto il salotto. Era la mia prima amica, la mia confidente.
Poi la vita è cambiata.
Mamma è morta. Mara ha cominciato a prendersi cura di tutti perché papà si era chiuso in sé stesso. Io mi sono buttato negli studi, deciso ad andarmene il prima possibile. Lei è rimasta, ha studiato infermieristica e aiutava la nonna nei fine settimana. Io mi sono trasferito prima a Londra, poi di nuovo al nord per lavoro, convincendomi che la distanza fosse normale.
Ma non lo era.
E non mi sono reso conto di quanto fossimo lontani finché non l’ho lasciata sola in un ospedale, ad aspettare qualcuno che non sarebbe arrivato.
Quel fine settimana sono andato a casa della nonna. Non ho detto niente a nessuno. Ho comprato delle crostatine al limone, le sue preferite, sperando che fosse ancora lì.
La nonna mi ha aperto la porta, sorpresa.
«Non è qui,» ha detto. «È tornata al suo appartamento tre giorni fa.»
«Posso andare da lei?»
Ha alzato un sopracciglio. «Non a mani vuote.»
Le ho mostrato la scatola di dolci.
Ha sorriso, stanca. «Allora forse hai una possibilità.»
Ho guidato fino a casa di Mara. L’edificio era lo stesso: modesto, pulito, con quel piccolo giardino dove un tempo coltivava rosmarino e girasoli.
Ho bussato. Una, due volte.
Quando ha aperto la porta, ho dimenticato cosa volevo dire.
Era pallida, con i capelli raccolti in un nodo disordinato e una felpa troppo grande.
«Ti ho portato delle crostatine,» ho detto, sollevando la scatola.
Mi ha guardato un momento, poi mi ha fatto cenno di entrare.
Dentro profumava di agrumi e ammorbidente. Le sue piante, in fila sul davanzale, sembravano piccoli soldati verdi.
Ci siamo seduti sul divano. Lei ha aperto la scatola, ne ha presa una e mi ha passato l’altra.
Abbiamo mangiato in silenzio.
«Hai aspettato in ospedale,» ho detto infine.
«Sì.»
«Per ore.»
«Mh.»
«Mi dispiace di non essere venuto.»
Ha scrollato le spalle, come se non importasse. Ma importava.
«Mi sono detto che non era urgente. Che saresti stata bene.»
«Non lo ero,» ha detto piano. «Ma ormai ci sono abituata.»
Quelle parole mi hanno colpito come un pugno.
«Non dovresti esserlo.»
Non ha risposto.
Mi sono guardato intorno: libri di testo sul tavolo, una felpa sulla sedia, un lavoro all’uncinetto lasciato a metà.
«Hai tenuto insieme tutto da quando è morta mamma,» ho detto. «Io non ho fatto la mia parte. Lo so.»
Mi ha guardato. «Tu te ne sei andato.»
«Lo so.»
«Io sono rimasta.»
«Anche questo lo so.»
«Pensavo fossimo ancora vicini,» ha sussurrato. «Pensavo che, se avessi avuto davvero bisogno di te… saresti venuto.»
«Lo pensavo anch’io,» ho detto. «E odio aver dimostrato il contrario.»
Ha abbassato lo sguardo.
Poi ha aggiunto qualcosa che non mi aspettavo:
«Ti ricordi quando ti ho detto che avevo fatto domanda per quella borsa di studio? Quella che avrebbe coperto l’ultimo anno?»
«Sì.»
«Non l’ho ottenuta.»
«Non me l’hai detto.»
«Tu non me l’hai chiesto.»
Quelle parole mi hanno trafitto.
«Avrei dovuto,» ho ammesso.
«Ho lavorato tre turni di notte a settimana per stare a galla,» ha continuato. «Dormivo in classe, saltavo i pasti. Mi vergognavo a dirlo a papà.»
«E io non me ne sono nemmeno accorto.»
«No.»
Non potevo negarlo.
«Ma Priya se n’è accorta,» ha aggiunto. «Mi portava da mangiare. Mi accompagnava a casa. È stata lei a convincermi ad andare al pronto soccorso.»
«Sono contento che l’abbia fatto.»
«Ora è la mia coinquilina. Si è trasferita due giorni fa.»
«Ah.»
«Non potevo più permettermi l’affitto da sola. Papà non lo sa.»
«Crede ancora che tu stia bene?»
«La gente crede a ciò che vuole credere.»
Non ho detto nulla.
«Cosa vuoi, allora?» le ho chiesto infine.
Ha sorriso piano. «Voglio indietro mio fratello.»
Sono rimasto senza parole.
«Non mi serve che tu sistemi tutto,» ha aggiunto. «Solo che ci sia. Ogni tanto.»
Non sembrava una richiesta impossibile. Non più.
Così ho iniziato a esserci.
Il weekend successivo l’ho aiutata a sistemare casa per la nuova coinquilina. Abbiamo bevuto tè, chiacchierato di sciocchezze, riso ricordando la volta in cui ci eravamo chiusi per sbaglio nel capanno della nonna e avevamo fatto ombre cinesi finché qualcuno non ci aveva trovati.
Due settimane dopo, l’ho accompagnata a un colloquio in una clinica pediatrica.
Ha ottenuto il lavoro.
Alla cerimonia del diploma, mi ha fatto sedere in prima fila e mi ha passato il telefono per scattarle le foto. Io mi sono commosso. Lei ha riso, ma mi ha stretto la mano.
Quella sera, a cena dalla nonna, c’era anche papà. Mi ha preso da parte in cucina.
«Mi ha detto quello che hai fatto,» ha detto.
«Non molto.»
«Sei tornato.»
«Tardi, però.»
Mi ha guardato negli occhi. «Meglio tardi che mai.»
Mara è entrata proprio in quel momento, con una ciotola di purè. Mi ha dato una spallata ridendo.
«Papà, Adam fa un tè orribile.»
«Uso solo latte d’avena!»
«Appunto.»
Abbiamo riso. Tutti e tre.
Non è perfetto. Io sbaglio ancora, e lei si chiude quando è sotto pressione. Ma stiamo ritrovando la strada l’uno verso l’altra.
Non puoi riscrivere i momenti in cui hai sbagliato.
Ma puoi scegliere cosa scrivere dopo.
E, a volte, questo basta.
Se c’è qualcuno nella tua vita che hai deluso, non aspettare le parole perfette. Presentati. Porta una crostatina al limone. O solo un po’ del tuo tempo.
Potresti scoprire che è più di quanto pensi.
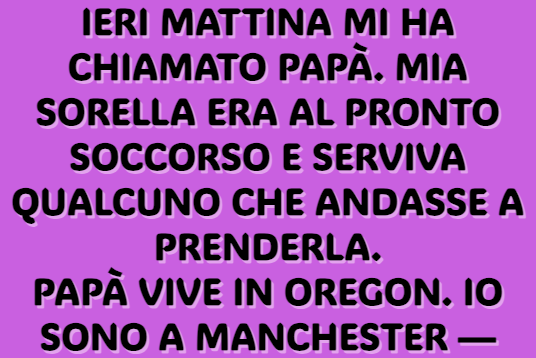



Add comment