Mi chiamo Arnold, e dopo aver vissuto per novantacinque lunghi anni, posso dire con sincerità di aver avuto una buona vita.
Ho conosciuto l’amore. Ho conosciuto la fatica. Ho visto il mondo cambiare in modi che, da giovane, non avrei mai potuto immaginare. Ho seppellito amici, cresciuto figli, lavorato fino a consumarmi le mani, e ho amato una donna per oltre sessant’anni—fino al giorno in cui ha lasciato questo mondo.
Dopo la sua scomparsa, la casa è diventata più silenziosa di quanto avrei mai pensato possibile. Da allora, siamo rimasti solo io e il mio vecchio cane, Max. Dorme ai miei piedi e mi segue da una stanza all’altra, come se temesse che potessi sparire se distogliesse lo sguardo anche solo per un momento.
Ho cinque figli—cinque anime meravigliose che ho cresciuto insieme a mia moglie. Ora sono tutti adulti, con vite proprie. Ogni tanto vengono a trovarmi. Nei giorni di festa, a volte. Una telefonata, quando si ricordano. Non li biasimo. La vita è frenetica. Lo so.
Ma il mio novantacinquesimo compleanno… sembrava diverso.
Sembrava importante.
Settimane prima del grande giorno, mi sedetti alla mia piccola scrivania di legno e scrissi cinque lettere—una per ciascun figlio. La mia calligrafia non è più quella di una volta, ma presi tutto il tempo necessario. Scrissi quanto avrebbe significato per me averli accanto. Scrissi che desideravo vedere i loro volti, abbracciarli, ridere insieme, raccontare quelle storie che avevo tenuto nel cuore per anni.
“Non voglio regali,” scrissi. “Voglio solo la vostra presenza.”
La mattina del mio compleanno mi svegliai prima del solito. Mi rasai con cura, anche se mi tagliai un po’ il mento. Indossai il mio maglione migliore—quello che mia moglie diceva mi faceva sembrare un uomo “distinto”. Apparecchiai la tavola con cinque sedie in più. Preparai una piccola torta da solo, con le mani tremanti.
Max mi osservava con la testa inclinata e la coda che sbatteva sul pavimento.
Ero al settimo cielo dall’emozione.
Ogni volta che sentivo un’auto rallentare fuori, il cuore mi balzava in petto. Sbirciai fuori dalla finestra più volte di quanto voglia ammettere. Arrivò mezzogiorno. Poi l’una. Poi le tre.
La torta rimase intatta.
Le sedie, vuote.
Con il passare delle ore, la speranza cominciò a svanire. Mi ripetevo che forse erano solo in ritardo. Forse il traffico. Forse qualcosa era successo. Controllai il telefono ancora e ancora, ma non arrivò alcun messaggio. Nessuna chiamata.
Alla sera, il sole calava tingendo le pareti d’oro e d’arancio. Sedetti solo a tavola, fissando quelle cinque sedie vuote. Mi sentii sciocco per averci creduto.
“Va tutto bene,” sussurrai a Max, anche se non sapevo davvero chi stessi cercando di rassicurare. “Sono solo impegnati. Non volevano dimenticarsi.”
Ma, nel profondo, sapevo la verità.
Avevo passato il mio novantacinquesimo compleanno da solo.
Tagliai una piccola fetta di torta e ne mangiai due morsi prima di allontanare il piatto. Non avevo più appetito. Il petto mi pesava in un modo che non sapevo spiegare. Mi appoggiai allo schienale della sedia e chiusi gli occhi, pensando a mia moglie, desiderando che fosse ancora lì a dirmi che andava tutto bene.
E poi—
Suonò il campanello.
Rimasi immobile.
Per un attimo, pensai di averlo solo immaginato. Max si alzò di scatto, abbaiando eccitato, la coda scodinzolava come quella di un cucciolo. Il campanello suonò di nuovo, più forte.
Con le mani tremanti, mi alzai e andai verso la porta.
Quando l’aprii, il fiato mi si bloccò in gola.
Davanti a me c’erano tutti e cinque i miei figli.
E dietro di loro… nipoti. Pronipoti. Palloncini. Fiori. Sorrisi misti a lacrime.
“Papà,” disse mio figlio maggiore con la voce spezzata, “ti chiediamo scusa.”
Entrarono tutti in casa, abbracciandomi con delicatezza, come se temessero che potessi spezzarmi. Una delle mie figlie si asciugò gli occhi e spiegò che avevano organizzato una sorpresa—che volevano arrivare tutti insieme, che un ritardo aveva tirato l’altro, che solo troppo tardi avevano capito quanto dovevo essermi sentito solo.
“Avremmo dovuto chiamarti,” disse piano. “Avremmo dovuto dirtelo.”
Non riuscivo a parlare. Li tenevo stretti. Tutti. A novantacinque anni, il cuore sembrava potesse esplodermi dal petto.
Sedemmo finalmente attorno alla tavola. Le sedie vuote non lo erano più. La risata tornò a riempire la casa. Qualcuno accese le candeline sulla torta, e cantarono per me—stonati, forti, meravigliosi.
Mentre li guardavo, con Max di nuovo acciambellato ai miei piedi, capii una cosa importante:
Anche quando la vita ti fa sentire dimenticato… l’amore a volte ci mette solo un po’ più tempo a bussare.
E quando lo fa, vale ogni attimo d’attesa.
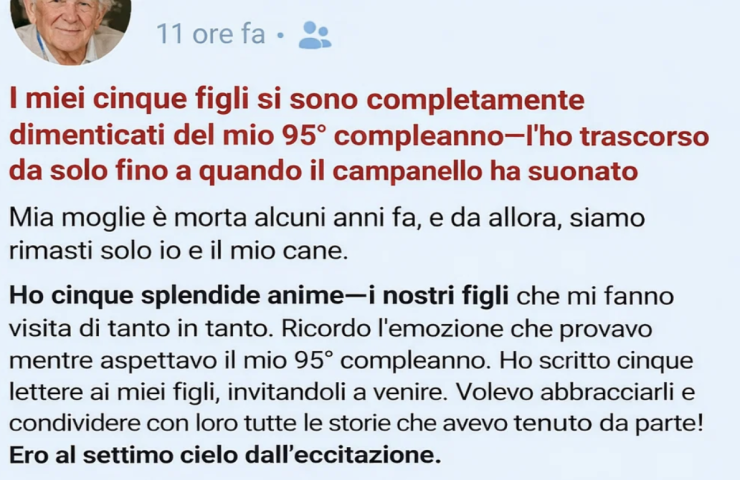



Add comment