Ricordo ancora perfettamente il suono della mia stessa voce che riecheggiava nella stanza d’ospedale — la sua durezza, la crudeltà che non mi sono nemmeno fermata ad addolcire.
«Togli le tue mani sporche da mia figlia!»
Le parole uscirono abbastanza forti da far voltare un’infermiera. Mia madre si immobilizzò, le mani sospese a pochi centimetri dalla minuscola coperta della mia neonata. Quelle mani — screpolate, callose, che odoravano vagamente di disinfettante nonostante quanto le lavasse — scesero lentamente lungo i fianchi.
Non protestò. Non pianse. Annuì soltanto una volta, sussurrò: «Mi dispiace», e uscì silenziosamente dalla stanza.
In quel momento mi sentii giustificata. Esausta. Sopraffatta. Provavo una vergogna che non sapevo nemmeno come chiamare. Mia madre puliva bagni per vivere — uffici, stazioni ferroviarie, qualsiasi posto avesse bisogno di qualcuno di invisibile che ripulisse i disastri degli altri. Avevo passato anni a fingere che non mi desse fastidio. Ma lì, in quella stanza d’ospedale immacolata, con in braccio la mia bambina perfetta, tutto il risentimento che avevo sepolto esplose in un’unica frase imperdonabile.
Da quel giorno, non chiamò più.
Passarono quattro mesi. Nessun messaggio. Nessuna domanda sulla nipotina. Nemmeno un breve SMS. Mi dissi che non le importava — che forse era arrabbiata, testarda, drammatica. Mi dissi che non avevo bisogno di lei. Ora ero una madre. Ero occupata. Stavo bene.
Eppure, quel silenzio mi rodeva dentro.
Un pomeriggio mi ritrovai a guidare nel suo quartiere senza averlo davvero pianificato. La sua casa era in fondo alla strada, proprio come la ricordavo. Entrai con la chiave di scorta che aveva insistito affinché tenessi «per ogni evenienza».
Dentro, l’aria era vuota.
Il divano era sparito. Il piccolo tavolo della cucina dove beveva il tè la sera — sparito. Le foto incorniciate, le pantofole consumate vicino alla porta, perfino i centrini all’uncinetto che amava — tutto mancava. Gli armadi erano vuoti, a parte qualche gruccia che oscillava leggermente, come se stesse aspettando qualcuno che non sarebbe tornato.
Il mio primo pensiero fu mia zia. Forse mamma stava da lei, ancora ferita, ancora bisognosa di spazio. Chiusi la porta, rimisi la chiave sotto lo zerbino e mi dissi di darle tempo. Se lo meritava.
La chiamata arrivò una settimana dopo.
Il suo nome apparve sullo schermo del telefono e il petto mi si strinse — non per la paura, ma per l’aspettativa. Pensai che fosse finalmente pronta a scusarsi. A sistemare le cose. Ad ammettere di aver esagerato.
Invece parlò la voce di uno sconosciuto.
«Qui è l’ospedale. Sono un’infermiera che si prende cura di sua madre.»
Il resto delle parole si confusero — gravemente malata, settimane, condizioni critiche. Quando l’infermiera chiese chi altro dovesse essere contattato, esitò prima di aggiungere piano: «Sua madre non voleva che la chiamassimo. Ha detto che ha una neonata e non voleva essere un peso».
Non ricordo nemmeno di aver riattaccato.
Guidai come se la strada potesse scomparire sotto di me. Quando arrivai nella sua stanza, mi fermai sulla soglia, incapace di muovermi. Sembrava più piccola di come la ricordavo, la pelle pallida, il corpo inghiottito dalle lenzuola bianche. Tubi uscivano dalle sue braccia. Le macchine emettevano bip sommessi, indifferenti al dolore che mi schiacciava il petto.
Le presi la mano. Era più sottile, più fredda — ma inconfondibilmente la sua.
«Mi dispiace», sussurrai, le lacrime che cadevano sulla coperta. «Avevo torto. Perdonami, ti prego.»
I suoi occhi si aprirono lentamente. Sorrise — appena.
«Una madre non può mai odiare suo figlio», mormorò. «Ora che sei madre, lo capirai.»
Rimasi.
Le diedi da bere con il cucchiaino. Le pettinai i capelli. Parlai della mia bambina — di come sorrideva nel sonno, di come stringeva le dita intorno alle mie. Mia madre ascoltava, serena, come se stesse conservando quelle parole in un posto sicuro.
Quattro giorni dopo, se ne andò.
Dopo, l’infermiera mi consegnò una piccola scatola. «Sua madre ci ha chiesto di darle questo.»
Dentro c’erano minuscoli vestitini lavorati a maglia — scarpine, cappellini, maglioncini — ognuno cucito con cura, con pazienza, con amore. Il nome della mia bambina era scritto su un biglietto piegato, nella grafia ordinata di mia madre.
Premetti il filato contro il viso e finalmente capii.
Quelle “mani sporche” avevano lavorato in silenzio per tutto il tempo, amandoci nell’unico modo che conoscevano — finché non hanno potuto più farlo.
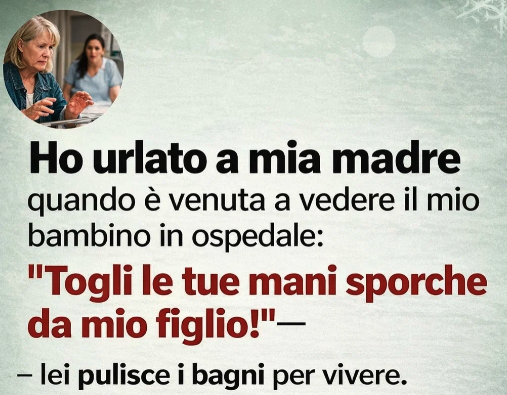



Add comment