La mia collega ed io dovevamo viaggiare per visitare le diverse filiali. Ma lei non riusciva a trovare una babysitter, così portò con sé il suo bambino. Il piccolo piangeva continuamente e faceva i capricci. Quando le feci notare la cosa, lei mi disse che non sapeva che fare. Alzai gli occhi al cielo e tornai a inviare email dal sedile del passeggero.
Avevamo sei filiali da visitare in una sola settimana, da lunedì a sabato, con un programma serrato e pochissimo margine d’errore. Mi ero immaginata un viaggio ordinato: controlli di routine, presentazioni, qualche domanda e poi relax in albergo con una tisana calda e una buona serie da guardare.
Ma dal momento in cui la vidi arrivare al parcheggio, capii che nulla di tutto questo sarebbe successo.
Suo figlio, un bimbo di tre anni di nome Elias, stava già urlando perché lei non gli permetteva di portare lo zaino con dentro il portatile. Cercò di calmarlo porgendogli una barretta ai cereali a metà, ma lui gliela strappò di mano e la gettò via. Io rimasi immobile, fingendo di controllare le email sul telefono.
«Scusa», mormorò lei, con le guance arrossate. «Da quando mia madre è partita, è più nervoso del solito. Di solito lo guarda lei, ma… le cose sono un po’ complicate adesso.»
Annuii cortesemente, senza dire molto. Non avevo voglia di drammi o storie. Volevo solo che quel viaggio finisse.
Il primo giorno fu estenuante. Elias si rifiutava di stare nel passeggino o di giocare con i giocattoli che la madre aveva portato. Pianse per gran parte delle presentazioni e fece cadere la bottiglietta del succo tre volte. Provai a tenerlo in braccio una volta, ma urlò ancora più forte. Dalia, la mia collega, sembrava sul punto di crollare più di una volta.
Quella sera bussai alla sua porta per completare il rapporto della filiale. Aprì tenendo Elias in braccio, con le guance sporche di burro d’arachidi e senza maglietta, per qualche motivo.
«Posso tornare più tardi», dissi.
«No, va bene. È solo… il solito lui.»
Lo mise giù, e lui corse subito verso le tende, tentando di tirarle giù. Dalia lo afferrò al volo, senza fiato.
Io aprii il portatile e iniziai a scrivere, in silenzio. Dopo un po’ lei si sedette accanto a me, esausta.
«So che è difficile da gestire», disse.
Annuii, continuando a digitare.
«Non volevo portarlo», aggiunse piano. «Ma non potevo permettermi di perdere questo viaggio. Ho bisogno di questo lavoro.»
Per la prima volta quel giorno la guardai davvero. Aveva occhiaie profonde, i capelli raccolti in uno chignon disordinato — non quello elegante, ma quello fatto per mancanza di tempo e forza. La camicetta era macchiata. Aveva un’aria stanca, una stanchezza che il sonno da solo non può guarire.
«Non hai nessuno che ti aiuti?» chiesi.
Scosse la testa. «Suo padre se n’è andato quando aveva un anno. Mia madre aiuta quando può, ma ora è in Texas da mia zia. Per adesso sono sola.»
Non dissi nulla. Non sapevo cosa dire. Prima di quel viaggio non la conoscevo quasi. Sapevo solo che era entrata da poco e che tutti dicevano che “si stava impegnando al massimo”.
Quella notte, tornando in camera, pensai a quanto fossi fortunata. Il mio lavoro andava bene. Non avevo figli, né grandi responsabilità, né nessuno che mi aspettasse a casa. Di solito lo consideravo un peso. Quella sera, mi sembrò una libertà preziosa.
Il secondo giorno andò peggio. Elias vomitò sul sedile posteriore. Dalia si scusò cento volte, pulendo tutto con salviette e persino con il suo maglione. Io scesi dall’auto e chiamai la filiale per dire che saremmo arrivate in ritardo. Senza spiegare il perché.
Il terzo giorno qualcosa in me iniziò a cambiare. Non perché Elias fosse migliorato — anzi, lanciò la sua macchinina contro il mio portatile, quasi rompendo lo schermo — ma per quei piccoli momenti in mezzo al caos.
Quando indicò il finestrino gridando «Uccellino!» con quella voce acuta che mi fece ridere nonostante tutto.
O quando gli diedi una penna e rimase tranquillo a scarabocchiare per venti minuti.
O quando si addormentò in braccio a me, stringendomi la manica con la sua manina.
Non sapevo come gestire quei momenti. Non sono mai stata una persona “da bambini”. Ma a Elias non importava. Entrava nel mio spazio e lo riempiva come se fosse suo.
Quella sera, a cena, mi offrii di tenerlo in braccio mentre Dalia mangiava. Lei mi guardò sorpresa, poi me lo porse.
Era appiccicoso, sapeva di pastelli e succo di mela, e cercava di afferrare la mia forchetta. Ma mi fece ridere quando cantò l’alfabeto al contrario — apposta, credo.
«Grazie», disse improvvisamente Dalia.
«Per cosa?»
«Per non giudicarci oggi. Né me, né lui.»
«Ha carattere», risposi sorridendo.
Lei ricambiò il sorriso. «È un modo carino per dirlo.»
Il quarto giorno fu quello in cui tutto cambiò.
Pioveva, e dovevamo parcheggiare lontano. Presi Elias in braccio sotto l’ombrello mentre Dalia portava la cartella. A metà del parcheggio scivolai su una pozzanghera. Non caddi, ma mi sbilanciai abbastanza da spaventare Elias, che iniziò a piangere.
«Shhh, va tutto bene», sussurrai stringendolo forte.
Dalia corse verso di noi. «Si è fatto male?»
«No, solo spaventato.»
Lei lo prese, ma lui tese le braccia verso di me.
E lì, sotto la pioggia, davanti alle vetrate della filiale, qualcosa si aprì dentro di me. Una sensazione di calore, in mezzo al freddo.
Quella sera costruimmo torri di bustine di zucchero sul pavimento dell’hotel. Lui le buttava giù e rideva fino alle lacrime.
«Perché ora sei così gentile con lui?» chiese Dalia, sorridendo.
«Non lo so. Forse mi è entrato nel cuore.»
«Fa questo effetto», rispose. «Non si affeziona a molti. Nemmeno a suo zio.»
Il quinto giorno arrivò la sorpresa. Dalia stava male: febbre, vertigini. Finimmo al pronto soccorso. Un’infezione seria. Dovevano trattenerla una notte.
Così presi Elias con me.
Fu una notte difficile. Pianse a lungo, cercando la mamma. Lo cullai, gli cantai (male), e alla fine si addormentò sul mio petto. Non dormii quasi, ma non mi importava.
La mattina dopo, andai da sola all’ultima filiale. Con Elias.
Spiegai che Dalia era malata e che avrei tenuto io la presentazione. Loro proposero di rimandare, ma insistetti.
Elias rimase tranquillo su una sedia, con i cracker e i cartoni animati sul telefono. Ogni tanto gridava “Vai, vai, vai!” quando la macchinina sullo schermo correva più veloce. Tutti risero.
La presentazione andò bene. Ero orgogliosa. Ma ancora di più, ero fiera di lui.
Quando tornammo in hotel, Dalia era sveglia, pallida ma sorridente.
«È stato bravissimo», le dissi.
Le si riempirono gli occhi di lacrime. «Non so come ringraziarti.»
«Non serve.»
Ma, in un certo senso, lo fece.
Due giorni dopo, il viaggio finì. Elias dormì per quasi tutto il tragitto di ritorno, tenendomi la mano dal seggiolino.
Quando li lasciai a casa, mi abbracciò forte.
«Vieni a casa mia?» mi sussurrò.
Sorrisi. «Forse un giorno.»
Tre mesi dopo, quel giorno arrivò.
Dalia fu promossa — l’avevo raccomandata io, e lo meritava. Ora dirige un reparto e può permettersi un aiuto part-time. Ma Elias ogni tanto viene ancora in ufficio.
Soprattutto per vedermi.
Mi chiama “Albero”, perché la prima volta non riusciva a pronunciare il mio nome, e così è rimasto.
A volte lo porto al parco o a prendere un gelato.
La settimana scorsa mi ha disegnato: io con gli occhiali grandi e lui che mi tiene la mano. Ha scritto “Albero è mio amico”.
Quel disegno è sul mio frigorifero.
Ripensandoci, credevo che quel viaggio sarebbe stato un disastro. E in parte lo fu. Ma mi cambiò.
Mi insegnò la pazienza, la compassione. Mi fece capire che dietro ogni capriccio c’è un piccolo essere umano che sta solo cercando di capire il mondo.
E che, a volte, le persone che ci sembrano il più grande fastidio… si rivelano la nostra più grande benedizione.
Se stai leggendo questo e hai mai giudicato un genitore troppo in fretta, o pensato che un bambino che piange fosse solo “maleducato” — respira. Non sai mai cosa sta affrontando qualcuno.
A volte, l’amore arriva travestito da caos.
A volte, la guarigione ha la forma di una piccola mano appiccicosa che ti stringe la manica.
E a volte, essere una “persona da bambini” non significa sapere cosa fare. Significa, semplicemente, esserci.
Se questa storia ti ha toccato, fatto sorridere o ricordare qualcuno, condividila.
Non sai mai chi potrebbe aver bisogno di essere ricordato che la gentilezza non è mai sprecata.
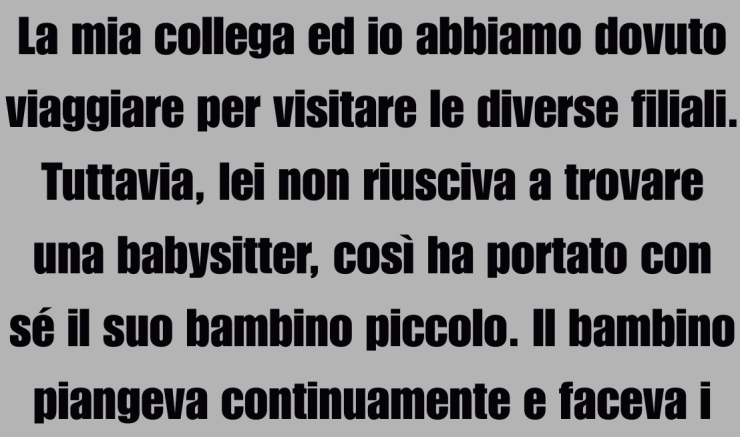
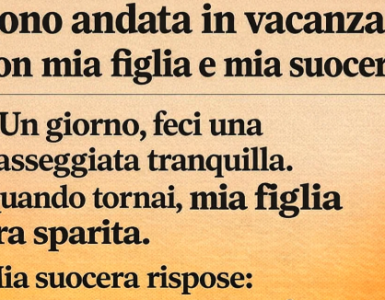
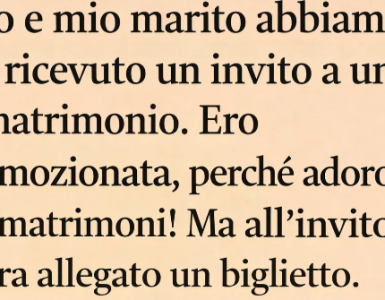
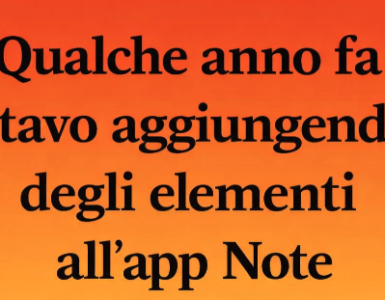
Add comment