Mio marito è diventato silenzioso da quando ha iniziato il suo nuovo “hobby”.
Ogni volta che gliene parlavo, si limitava a dire che era “liberatorio”.
Ho iniziato a notare delle macchie rosse sulla sua biancheria ogni volta che tornava dal laboratorio.
Un giorno, l’ho seguito.
Sono entrata… e mi sono bloccata quando l’ho visto essere…
tenero.
Era curvo su una sedia, intento a cucire un tessuto di velluto rosso scuro con punti minuscoli e precisi. Un abito a metà lavorazione era appeso a un manichino. Spilli conficcati in un cuscinetto a forma di pomodoro, nastri da sarta penzolanti da ganci, una macchina da cucire Singer d’epoca che ronzava dolcemente mentre lui guidava il tessuto sotto l’ago. Non mi sentì entrare: era troppo concentrato.
Quelle macchie rosse? Non era sangue. Era tintura, vernice per tessuti, a volte persino gesso.
Quest’uomo stava creando vestiti—più precisamente, abiti da sera. E non abiti qualunque.
Erano sontuosi, teatrali, da passerella o da spettacolo.
Mi vide. Sussultò.
«Cressida?» sussurrò, con gli occhi spalancati. «Che ci fai qui?»
Avrei dovuto dire qualcosa di gentile. O almeno neutro.
Ma mi uscì la prima cosa che mi venne in mente:
«Stai… facendo travestimenti?»
Sgranò gli occhi. «No. Cioè… a volte li provo per controllare la vestibilità. Ma non lo faccio per indossarli. Li sto disegnando.»
Seguì un lungo silenzio. Si massaggiò la nuca, imbarazzato come un ragazzino colto a marinare la scuola.
«Non è una crisi di mezza età,» disse. «Ho sempre voluto farlo. Fin da adolescente. Ma non mi è mai sembrato… concesso.»
Mi guardai intorno. Rotoli di tessuto, bozzetti attaccati al muro, forme da sarta.
Non aveva semplicemente trovato un passatempo. Stava costruendo un mondo. Nascosto.
«Perché non me l’hai detto?» chiesi piano.
Sospirò. «Perché non sapevo se sarei stato in grado di affrontare la tua delusione.»
Quelle parole mi colpirono più di quanto mi aspettassi.
Perché non aveva torto.
Una parte di me, quella che desiderava che mio marito rimanesse l’uomo saldo e prevedibile che avevo sposato, era delusa.
Ma quella parte era piccola e spaventata.
L’altra parte—quella che lo amava—era solo confusa.
Quel giorno uscii dal laboratorio senza dire molto. Avevo bisogno di tempo.
Per la settimana successiva, parlammo a malapena.
Lui tornava a casa, cucinava come sempre, ma c’era tensione. Nessuno menzionava il laboratorio.
Poi, un pomeriggio, trovai un sacco porta-abito appeso alla porta del mio armadio.
C’era il mio nome ricamato sull’etichetta.
Dentro, un abito verde bosco, cucito su misura: morbido, sobrio, ma splendido.
Un biglietto nella tasca diceva:
“Provalo. Nessuna pressione. Volevo solo farti sentire cosa provo io quando creo qualcosa da zero.”
Rimasi lì quindici minuti. Poi lo indossai.
Non mi aspettavo di piangere.
Non era l’abito, in realtà.
Era il pensiero dietro.
Conosceva la mia sfumatura preferita.
Si ricordava che odiavo le zip dietro.
Aveva lasciato spazio in più per le mie braccia forti, che sempre mi erano sembrate motivo d’imbarazzo.
Non era un travestimento.
Era una dichiarazione d’amore.
Quella sera entrai in salotto indossandolo.
Lui stava guardando la TV, ma si alzò lentamente, quasi avesse paura di muoversi troppo in fretta.
«L’hai fatto per me?» chiesi.
Annui.
«È bellissimo,» dissi.
Le sue spalle si rilassarono, appena.
Da quella sera iniziai a raggiungerlo nel laboratorio una volta a settimana.
All’inizio osservavo soltanto.
Poi imparai a infilare la macchina.
Lo aiutai a cercare tessuti online, a scovare bottoni vintage nei mercatini.
Divenne il nostro piccolo rito segreto.
Quello che mi sorprese di più fu il numero di persone che si rivolgevano a lui.
Un giorno si presentò una ragazza di nome Neriah. Avrà avuto vent’anni, timida, quasi senza contatto visivo.
«Ciao, ehm… hai fatto un abito per il matrimonio di mia cugina,» mormorò. «Io ho un’esibizione musicale il mese prossimo. E… vorrei qualcosa che non mi faccia sembrare un rettangolo.»
Mio marito sorrise. «Non sei un rettangolo. Vieni dentro.»
Trattava tutti allo stesso modo.
Adolescenti o madri di cinquant’anni, ascoltava.
Disegnava mentre parlavano, adattava linee e curve alla loro postura, alla loro personalità.
Una sera, mentre finiva di appuntare un prototipo su un manichino, gli chiesi:
«Hai mai pensato di farlo sul serio?»
Alzò un sopracciglio. «In che senso?»
«Tipo… un marchio. Una boutique. Anche solo online.»
Rise piano. «Sono solo un tizio con una macchina da cucire. Nessuno comprerebbe i miei abiti.»
Ma l’idea non morì lì. Rimase.
Nei mesi successivi, trasformammo parte del garage in uno studio vero.
Dipingemmo le pareti, installammo luci migliori, mensole.
Io gli creai un sito web, caricai le sue creazioni, convinsi alcune clienti a farsi fotografare con i loro abiti—con il loro consenso, ovviamente.
Arrivarono i primi ordini.
Un vestito da damigella, un abito per il ballo scolastico.
Non nuotavamo nei soldi, ma era più di quanto ci aspettassimo.
Poi arrivò la svolta.
Una cliente, Giselle, chiese se poteva disegnare l’abito da sposa per sua figlia.
Esitò. «Un abito da sposa è… una cosa seria.»
Ma lei insistette. E lui accettò.
Ci mise l’anima.
Notte dopo notte, perfezionava il pizzo delle maniche, provava fodere, testava scolli.
Lo vedevo perdere sonno, ma mai essere più felice.
Il matrimonio arrivò.
La sposa pianse davanti allo specchio.
Le foto finirono su un blog molto seguito.
Da lì, l’esplosione.
Messaggi da stilisti.
Richieste da parte dei media.
Appuntamenti, interviste.
Ma qualcosa cambiò.
Divenne ossessionato.
Annullò le nostre serate.
Dimenticava di mangiare.
Rifiutava il mio aiuto.
Quando mi offrii di gestire le email, sbottò:
«Ce la faccio da solo, Cressida, okay?»
Non sapevo più dove mi collocavo.
Mi sembrava di averlo perso di nuovo.
Finché arrivò la sera della sfilata.
Uno dei suoi abiti era stato selezionato per un evento locale.
Io indossavo l’abito verde. Ero fiera.
Dietro le quinte era nervoso.
Gli presi la mano. «Tutto bene?»
Annui. «Non ci credo di essere qui.»
La modella uscì.
Il pubblico applaudì.
Lui aveva gli occhi lucidi.
Usciti fuori, dissi:
«Ce l’hai fatta.»
Mi guardò, sorrise… poi aggrottò la fronte.
«Non ce l’avrei fatta senza di te.»
Poi vibrò il suo telefono.
Un messaggio: Jori.
“Dopo stasera, dobbiamo parlare della tua collezione personale. Sei troppo bravo per restare piccolo.”
«Chi è Jori?» chiesi.
Esitò. «Una stilista. Molto nota. Vuole collaborare.»
«Ma… vuole che tu lavori da solo?»
Non rispose.
Quella notte, restammo in silenzio.
Il mio cuore si torceva in una domanda che non riuscivo a pronunciare: lo sto perdendo a causa del suo sogno?
Due giorni dopo, mi chiamò nel soggiorno.
Solo noi due.
Né laboratorio, né abiti.
«Devo chiederti una cosa,» disse.
«Dimmi.»
«Se accetto… di lavorare con Jori… potrebbe significare viaggi, trasferte, notti fuori. È tanto.»
Lo guardai.
«Hai sempre detto di voler creare,» dissi. «Ma a che prezzo? Che ne sarà di noi?»
Tirò fuori un foglio piegato.
«Le ho detto di no,» disse.
Sgranai gli occhi. «Cosa?»
«Le ho detto che non ci sto, a meno che non sia con te. Il sito, il marchio, le prove. Tutto. Non voglio lasciare questa vita alle spalle. Voglio costruire qualcosa. Con te.»
Non piansi. Scoppiai a ridere. «Potevi dirlo subito!»


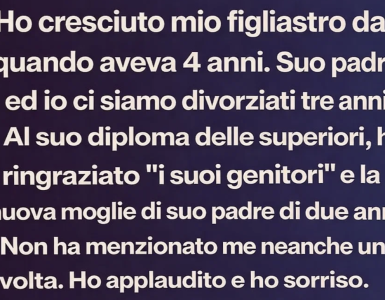
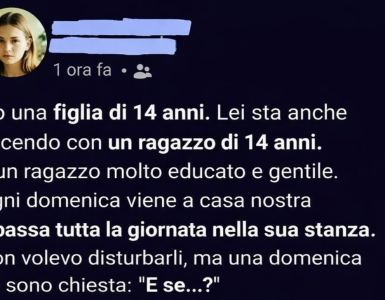
Add comment