Ero a Parigi, viaggiando da solo. Passeggiavo senza meta per le strade vicino a una stazione della metropolitana, quando notai un ragazzo con il cappuccio che camminava dietro di me. Continuava a voltarsi, come se stesse controllando me. Prima ancora che potessi dargli peso, si affiancò di colpo e disse: «Idiota.»
Per un attimo rimasi impietrito. Pensai stesse parlando con qualcun altro. Ma no—mi fissava dritto negli occhi, come se avessi fatto qualcosa di sbagliato. Aprii la bocca per rispondere, magari insultarlo o almeno chiedergli che problemi avesse, ma lui mi afferrò per un braccio e mi trascinò con forza in un vicolo laterale.
Non sono ingenuo. Sono cresciuto a Johannesburg, dove impari presto a non fidarti degli sconosciuti che ti tirano via dalla strada. Mi divincolai, pronto a urlare, ma fu allora che lui abbandonò la recita.
«Ascolta, fidati di me per cinque secondi», disse abbassando la voce. «Quel tipo dall’altra parte della strada? Ti segue da tre isolati. Non è un turista.»
Mi voltai nella direzione indicata e lo vidi: un uomo con una giacca di pelle, passo lento, occhi fissi su di me. Fingeva di guardare una mappa, ma lo faceva malissimo. Lo stomaco mi si attorcigliò.
Non mi ero neanche reso conto di essere seguito. Pensavo fosse solo il solito caos turistico.
Il ragazzo con il cappuccio—che poi scoprii chiamarsi Noam—non aveva molti più anni di me, forse sulla trentina. Barba incolta, energia nervosa, ma occhi vigili. Mi condusse con naturalezza in una via laterale, come se fossimo amici.
«Continua a camminare», sussurrò, «e per l’amor di Dio, sorridi. Come se stessimo parlando di formaggi.»
Così parlammo di formaggi. O meglio, lui elencava nomi di formaggi e io annuivo come se stessimo vivendo il momento più divertente della giornata. Camembert. Brie. Mimolette.
Dietro di noi, l’uomo con la giacca di pelle esitò, poi sparì.
Quando fummo abbastanza lontani dalla metro, Noam si fermò sotto la tettoia di un fioraio.
«Non dovresti girare da solo con quella macchina fotografica in bella vista», disse, guardando il mio zaino. «Sei praticamente un bersaglio ambulante.»
Avevo sentito gli avvertimenti, ma pensavo di essere prudente. Portavo con me la Leica vintage di mio zio, un cimelio che avevo ereditato poco prima del viaggio. Valeva più di tutto il resto del mio bagaglio messo insieme.
Poteva benissimo prendersela lui. E invece no.
Si offrì di accompagnarmi al museo verso cui stavo andando. Ero tentato di rifiutare, ma nel suo tono non c’era insistenza. Solo… preoccupazione. Protezione, forse. Alzai le spalle e dissi di sì.
Scoprii che non era neppure francese. Marocchino-israeliano, nato a Haifa, studiava architettura a Lione ed era a Parigi solo per una settimana. Aveva un umorismo asciutto e un modo tutto suo di notare dettagli che mi erano sfuggiti: incisioni nei muri, graffiti bizzarri, un caffè nascosto sotto un arco di pietra.
Il museo era chiuso per sciopero. Tipico di Parigi. Ma non mi importava.
Ci sedemmo sui gradini di una fontana, bevendo Orangina da bottiglie di vetro e raccontandoci storie di viaggio. Gli parlai di mio zio, che aveva vissuto a Parigi per dieci anni e mi aveva sempre detto di venire. Lui mi parlò dell’ossessione di sua madre per gli gnomi da giardino e della cucina disastrosa di suo padre.
Sembrava di conoscerlo da più di un’ora. Forse anche da più di un giorno.
Quando mi chiese se volevo cenare con lui quella sera, esitai.
«Non ti conosco», dissi.
«Ma sai che non ti ho derubato», rispose sollevando un sopracciglio. «È già qualcosa.»
In effetti.
Ci rivedemmo quella sera a Montmartre. Mi portò in un posticino che da solo non avrei mai trovato—niente insegna, solo gente del posto. Mangiammo confit de canard e dividemmo una crème brûlée. Tutto incredibilmente semplice. Niente pressioni. Solo risate, storie e sguardi lunghi che… facevano sentire al sicuro.
Nei giorni seguenti, continuammo a “incontrarci per caso”. Musei, librerie, caffè. Svoltavo un angolo e lui era lì, a fingere di leggere un menù o a fissare un piccione. Era un gioco. Tenero. Ma anche intenzionale.
Poi arrivò il giovedì.
Avevo in programma di andare a Versailles. Lui si offrì di venire, ma gli dissi che avevo bisogno di un po’ di tempo per me. E lo pensavo davvero. Quel viaggio era nato per ritrovare me stesso, per elaborare un lutto. Non cercavo una storia d’amore.
Sorrise. «Se cambi idea, scrivimi», disse.
Non gli scrissi.
Avrei dovuto.
Versailles, ovviamente, era magnifica. Ma affollata. Rumorosa. Tornato a Parigi, ero stanco, sudato, e desideroso di una serata tranquilla. Mi incamminai verso l’appartamento che avevo affittato a Belleville.
E notai che la porta era socchiusa.
Il cuore mi precipitò nel petto.
Feci un passo indietro nel corridoio, il battito a mille. Ero sicuro di averla chiusa. Controllo sempre due volte. Sempre.
Indietreggiai, andai in fondo alla strada e chiamai il proprietario. Niente risposta. Provai il numero della polizia per emergenze minori. Venti minuti di attesa.
Poi chiamai Noam.
Rispose al secondo squillo. «Che succede?»
Arrivò in dieci minuti. Non so come fece così in fretta. Forse era già lì vicino. Forse non aveva mai smesso davvero di tenermi d’occhio.
Entrammo insieme.
La casa era a soqquadro. La mia valigia rovistata. Cassetti aperti. Armadio svuotato. La mia Leica—sparita.
Mi sedetti sul pavimento, cercando di trattenere le lacrime.
Noam si accucciò accanto a me. «Poteva andare peggio», disse piano. «Tu non eri lì. Questo è ciò che conta.»
Scoprimmo poi che era opera di una banda specializzata nei furti ai turisti, rintracciati attraverso i geotag su Instagram. Mi avevano seguito per giorni, probabilmente. Avevano visto la macchina. Mi avevano trovato.
La polizia non fu di grande aiuto. Né il padrone di casa. Ma Noam? Non mi lasciò mai solo. Mi aiutò con la denuncia. Litigò con il padrone in francese. Mi portò persino in un negozio di vecchie macchine fotografiche e me ne comprò una economica.
«So che non è la stessa cosa», disse porgendomela con un’alzata di spalle imbarazzata. «Ma magari con questa farai foto migliori.»
Sorrisi, con le lacrime agli occhi.
Pensavo fosse finita lì. Invece, due giorni dopo, successe qualcosa di inaspettato.
Passeggiavamo vicino alla stessa stazione metro dove ci eravamo incontrati la prima volta, quando Noam si bloccò. Mi afferrò il braccio.
«È lui», sussurrò.
Era proprio l’uomo con la giacca di pelle. Stessa corporatura. Stesso passo. Sopracciglia aggrottate, come se fosse in ritardo.
Noam non esitò.
Lo seguì a distanza per due isolati, poi tirò fuori il telefono e scattò alcune foto.
«Per sicurezza», disse.
Consegnammo le foto alla polizia, che lo collegò a una nota banda di borseggiatori. A quanto pare, era già stato arrestato. La mia denuncia permise di riaprire il caso.
Non recuperarono mai la Leica. Ma l’uomo fu arrestato. E due settimane dopo, ricevetti una chiamata: avevano trovato la borsa fotografica di mio zio in un banco dei pegni. La macchina non c’era più, ma all’interno c’era un rullino non sviluppato.
Quasi piansi di nuovo.
Quando lo sviluppai, tornato a Città del Capo, vidi qualcosa che non mi aspettavo.
Foto di mio zio. Con persone che non conoscevo. Una donna sorridente dagli occhi intensi. Un bambino sulle sue spalle. Una Parigi diversa da quella che avevo visto—intima, gioiosa, delicata.
Sul retro di una delle foto, in inchiostro sbiadito, c’era scritto:
«L’amore è una città che si costruisce in due.»
La mostrai a Noam, più tardi, in videochiamata. Era tornato a Lione. Ma continuavamo a sentirci. A ridere. A pianificare il prossimo viaggio.
Quel prossimo viaggio, alla fine, divenne qualcosa di più.
Un anno dopo, venne a trovarmi in Sudafrica.
Due anni dopo, tornammo insieme a Parigi—e stavolta, non portai la macchina fotografica. Solo ricordi. E un uomo che una volta mi aveva chiamato idiota, e poi mi aveva insegnato a prestare attenzione.
Ecco cosa ho imparato: a volte, le persone che ti scuotono di più non cercano di impressionarti. Ti stanno solo osservando con attenzione. E a volte, perdere qualcosa di prezioso ti porta dritto fra le braccia di qualcosa di ancora più importante.
Se viaggi da solo, ascolta il tuo istinto—ma non temere chi ti sorprende.
E, chissà… magari presta attenzione a chi ti dà dell’idiota. Potrebbe solo cercare di salvarti.
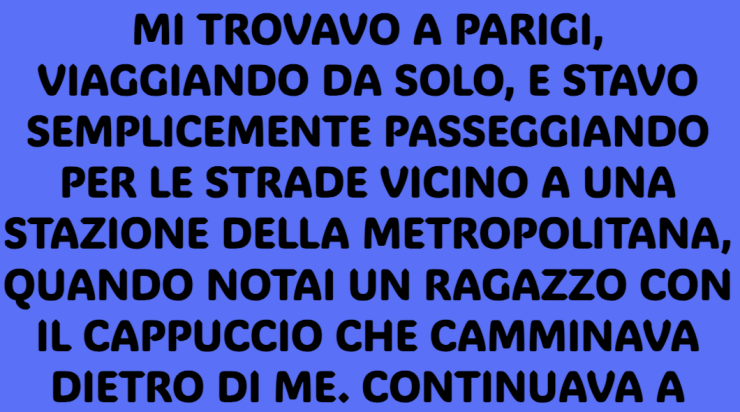

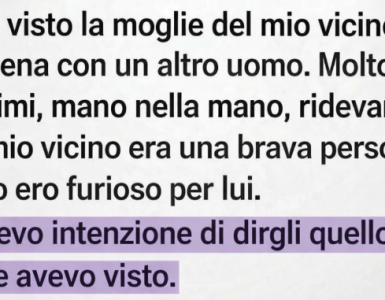

Add comment