Ero sola in un taxi alle tre del mattino. L’autista continuava a fissarmi in silenzio, incrociando i miei occhi con insistenza. Appena arrivati, scesi di corsa e mi rifugiai nel mio palazzo, salendo velocemente all’ottavo piano. Poi sentii dei passi alle mie spalle: era lui. Il tassista.
Presi dal panico, iniziai a correre su per le scale, ma lui si avvicinava sempre di più. Mi voltai, e con orrore, lui mi afferrò il polso.
«Aspetti!» ansimò, senza fiato. «Ha dimenticato questo.»
Nella sua mano: il mio portafoglio.
Rimasi lì, immobile, con il cuore che martellava nelle orecchie. Stavo stringendo la bomboletta di spray al peperoncino, il pollice già sul beccuccio, pronta a urlare. E invece mi sentivo… stupida. Lui teneva il portafoglio come fosse un’offerta di pace.
«Mi scusi se l’ho spaventata,» disse, facendo un passo indietro per lasciarmi spazio. Aveva un accento marcato, forse mediorientale, ma lo sguardo era gentile. E stanco. «L’ha lasciato sul sedile. Non volevo che qualcun altro lo trovasse.»
Sussurrai un grazie, sentendo le guance bruciare.
Lui annuì e tornò giù, scendendo le scale a due a due.
Quella notte non dormii quasi per nulla.
C’era qualcosa, in tutta quella storia, che non riuscivo a scrollarmi di dosso—non solo lo spavento, ma anche l’espressione che aveva avuto quando finalmente mi ero rilassata. Come se l’avesse già vista. Come se fosse abituato a essere temuto.
La mattina dopo, aprii il portafoglio. Non mancava nulla. Anzi, c’era un piccolo post-it infilato all’interno:
“Stia attenta. Il mondo è pieno di entrambi i tipi.”
Lo lessi almeno dieci volte. Cosa intendeva con “entrambi i tipi”?
Quella frase mi scosse profondamente.
Vivevo a Londra da poco, mi ero trasferita per lavorare in un centro d’arte comunitario a Hackney, dove insegnavo scrittura creativa. Conoscevo poche persone: qualche collega e la mia coinquilina, Anouk, che faceva i turni di notte in ospedale.
Iniziai a pensare spesso a quel tassista. Ero stata pronta a credere al peggio. Non sapeva nulla di me, eppure era salito otto piani solo per restituirmi qualcosa che nemmeno sapevo di aver perso.
Così, qualche giorno dopo, feci qualcosa che sorprese anche me.
Chiamai la compagnia di taxi e chiesi se fosse possibile risalire all’autista di quella notte. All’inizio l’operatrice fu titubante—disse che c’erano regole sulla privacy. Ma quando spiegai che volevo solo ringraziarlo, magari offrirgli un caffè, si sciolse un po’.
«Credo si chiami Idris,» disse. «È l’unico che fa quel turno sulla sua tratta.»
Mi diede un numero.
Lo fissai per ore prima di scrivere:
“Ciao, sono la ragazza dell’altra sera—quella del portafoglio. Mi piacerebbe offrirti un caffè, se ti va.”
Rispose dopo pochi minuti.
“Ho solo fatto la cosa giusta. Ma sì, mi farebbe piacere. Domani?”
Ci incontrammo in una piccola caffetteria algerina vicino Finsbury Park. Mi aspettavo imbarazzo. Invece no.
Idris era… silenzioso, ma non freddo. Parlava lentamente, con cura, come se ogni parola avesse peso. Era arrivato nel Regno Unito cinque anni prima. In Algeria era insegnante. Filosofia, addirittura.
«E perché non insegni qui?» chiesi, sorseggiando il mio tè alla menta.
Rise, con amarezza. «Pensi che mi lascino? Nessuna laurea riconosciuta. Nessun documento valido.»
Lavorava di notte per mandare soldi a casa, alla sorella più giovane che voleva studiare biologia. «Vuole fare il medico. E io credo che ce la farà.»
Qualcosa si aprì di nuovo dentro di me. Non sapevo cosa, ma volevo aiutare. O almeno… non restare indifferente.
Nei giorni successivi, continuammo a vederci. A volte in quella stessa caffetteria. Altre volte passeggiando per Clissold Park, guardando le volpi attraversare i sentieri vuoti.
Una sera gli chiesi se gli mancasse insegnare.
«Ogni giorno,» rispose.
Poi, scherzando a metà, gli proposi di tenere una lezione al centro, solo per i ragazzi più grandi. Stavamo affrontando un modulo sulle “visioni del mondo”, usando la narrazione per esplorare diverse filosofie.
Lui sgranò gli occhi. «Io? Nessuno mi vorrebbe ascoltare.»
«Io sì,» dissi.
Alla fine accettò, nervoso ma incuriosito. Riuscii a ottenere il via libera dalla mia responsabile, che fu sorprendentemente favorevole.
I ragazzi lo adorarono.
Aprì la lezione con una citazione di Rumi e concluse chiedendo a ogni studente di scrivere un racconto su un momento in cui erano stati giudicati male—o avevano giudicato male qualcun altro.
Erano incollati alle sue parole.
Dopo, uno degli studenti più difficili—Tariq—si avvicinò e gli strinse la mano. «Parli come mio zio. Ora è in prigione. Ma era intelligente. Come te.»
Idris annuì. «Allora lo è ancora.»
Quel giorno cambiò qualcosa in entrambi.
Iniziammo a frequentarci al di fuori dei “ringraziamenti” e dei “favori”. C’erano ancora complicazioni—io lavoravo di giorno, lui di notte. Io bevevo (ogni tanto), lui no. Portava con sé una tristezza silenziosa, come se avesse invecchiato più in fretta dei suoi anni.
Ma aveva anche una gentilezza che non sapevo di desiderare. Ascoltava come nessun altro. Non solo le parole, ma anche i silenzi, i sospiri, gli sguardi.
E poi—perché la vita è strana così—mi rubarono di nuovo il portafoglio.
Questa volta sulla metro. Colpa mia.
Stavolta però era stato svuotato.
Tornai a casa furiosa, camminando avanti e indietro. Non riuscivo a smettere di pensare all’ironia. L’uomo che temevo me l’aveva restituito. E ora un perfetto sconosciuto l’aveva rubato davvero.
Idris ascoltò in silenzio mentre sbottavo, poi disse qualcosa che mi rimase dentro:
«Alcuni prendono. Altri restituiscono. Il tuo compito non è indovinare chi sono—è essere tra quelli che restituiscono.»
Scoppiai a piangere. Non sapevo nemmeno perché, ma qualcosa si spezzò ancora. E si aprì.
Ci avvicinammo sempre di più. Cominciò ad assistere ad alcune lezioni di scrittura, quando poteva. Gli studenti iniziarono a chiedere di lui. Ottenne perfino un piccolo incarico come mentore per uno dei ragazzi con borsa di studio.
Poi arrivò il colpo di scena.
Una sera, Idris non si presentò al nostro solito incontro. Lo aspettai per più di un’ora. Nessuna chiamata. Nessun messaggio.
Mi preoccupai. Chiamai la compagnia di taxi. La centralinista esitò.
«Idris stasera non è in turno. Forse… sta affrontando qualcosa. Non sta a me dire di più.»
Non dormii.
La mattina dopo ricevetti un messaggio da un numero sconosciuto.
“Sono Lamis, la sorella di Idris. Mi ha chiesto di scriverle. Sta bene, ma… è in un centro di detenzione. Immigrazione.”
Il cuore mi crollò.
Il suo visto lavorativo era scaduto un mese prima. Stava cercando di rinnovarlo, senza dirlo a nessuno. Non voleva coinvolgermi.
Lo avevano fermato a caso mentre lasciava un cliente a Paddington. E portato via.
Entrai in modalità emergenza.
Chiamai ogni numero legale che trovai. Informai il mio capo. Raccogliemmo lettere da studenti, colleghi, chiunque lo avesse conosciuto al centro.
Un pacchetto: testimonianze, prove del suo contributo.
Passarono due settimane. Nessuna notizia.
Poi, un mattino, un altro messaggio da Lamis:
“Lo hanno rilasciato. In libertà vigilata. Ma non può lavorare per ora.”
Corsi da lui.
Era più magro. Sfinito. Ma quando mi vide, sorrise—appena.
«Ho parlato di te,» disse. «Della classe. Dei ragazzi. Di tutto. Credo abbia aiutato.»
E aveva ragione. Così tanto che al centro proposero di farlo entrare come volontario fino a che la situazione legale si fosse chiarita. Non pagato, ma ufficiale.
Accettammo.
I ragazzi erano entusiasti.
Alla fine, Idris ottenne un nuovo visto. Uno speciale, legato al “contributo educativo”. Non permanente, ma rinnovabile.
E il colpo di scena più grande?
Sei mesi dopo, gli offrirono un incarico come assistente all’insegnamento. Non da noi—ma da un altro centro che lo aveva visto in azione durante un workshop congiunto.
Quasi non accettò.
«Abbiamo costruito tutto questo insieme,» mi disse. «Non voglio lasciarlo indietro.»
«Non lo stai lasciando,» risposi. «Lo stai portando avanti.»
Continuammo a vederci. Una relazione tranquilla. Niente foto su Instagram. Solo colazioni lente, passeggiate nei parchi, conversazioni notturne.
Non dovevamo definirla. Lo sapevamo e basta.
E la cosa a cui torno sempre è questa:
Pensavo che la parte più spaventosa della storia fosse quella notte sulle scale.
Non lo era.
La parte più spaventosa era quanto poco ci mancava perché non ci conoscessimo affatto.
Se non avessi scritto. Se lui non avesse restituito il portafoglio. Se entrambi avessimo scelto la paura invece del gesto.
Tutti parlano del destino come di un fulmine a ciel sereno. Ma a volte, è solo un post-it nel tuo portafoglio.
“Stia attenta. Il mondo è pieno di entrambi i tipi.”
Aveva ragione.
Ma il mondo ti lascia anche scegliere a quale tipo vuoi appartenere.
Ora, ogni volta che trovo qualcosa di perso—un telefono, una sciarpa dimenticata, persino un biglietto lasciato in biblioteca—lo restituisco. Sempre.
Perché non sai mai a chi lo stai restituendo.
O cosa restituiranno a te.
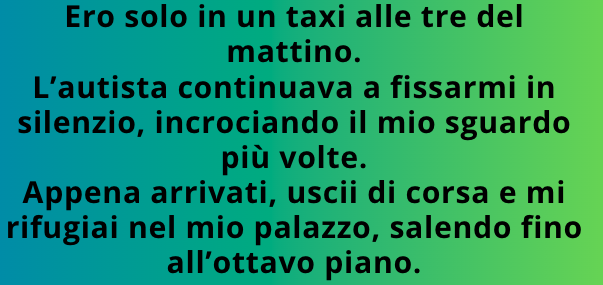



Add comment