Mia madre soffriva di demenza. Quando non sono più riuscita a prendermi cura di lei da sola, a malapena ricordava il mio nome.
Alcuni giorni pensava che fossi sua sorella. Altri mi guardava con un’educata confusione, come se fossi una sconosciuta finita nel suo salotto per sbaglio. Nei rari, preziosi momenti in cui mi riconosceva, i suoi occhi si illuminavano di una gioia fragile, che mi spezzava il cuore ogni volta da capo.
Metterla in una casa di riposo è stata la decisione più difficile della mia vita—e ancora oggi me ne faccio una colpa.
Mi dicevo che non avevo scelta. Ero esausta. Avevo paura. La stavo deludendo.
Di notte vagava, dimenticava di mangiare, una volta aveva lasciato il fornello acceso e quasi incendiato la casa.
Eppure, firmare quei documenti mi sembrava un tradimento.
Quella prima sera, quando le baciai la fronte e le dissi che sarei tornata presto, mi strinse la mano come una bambina e sussurrò:
«Non lasciarmi.»
Ma io me ne andai lo stesso.
Andavo a trovarla quando potevo, ma tra il lavoro e la distanza era difficile.
La vita non si ferma solo perché tua madre sta svanendo.
Ogni visita pesava più della precedente.
Lei piangeva ogni volta che mi alzavo per andare via, mi afferrava il cappotto, la voce tremava per un’ansia che nemmeno riusciva a spiegare.
E ogni volta, le promettevo che sarei tornata prima.
E ogni volta… non lo facevo.
Poi, una mattina presto, il telefono squillò.
La voce dell’infermiera era calma, quasi recitata. Troppo calma.
Mia madre era morta durante la notte.
«Serenamente», dissero.
Come se quella parola potesse attenuare qualcosa.
Non ricordo il viaggio.
Non ricordo come sono entrata nella casa di cura.
Ricordo solo di essermi preparata al peggio: scartoffie, condoglianze imbarazzate, una stanza ormai vuota.
Invece, trovai una giovane operatrice seduta accanto al letto di mia madre.
Le teneva la mano. La testa leggermente chinata. Gli occhi gonfi e rossi, le spalle curve dalla stanchezza. Sembrava non avesse dormito per niente.
Per un attimo restai immobile sulla soglia, come se stessi interrompendo qualcosa di sacro.
Quando si accorse di me, si alzò subito, scusandosi piano, come se avesse fatto qualcosa di sbagliato.
«Sono rimasta dopo il turno,» disse sottovoce.
«Non volevo che morisse da sola.»
Le gambe mi cedettero.
Mi raccontò di averle fatto compagnia per ore.
Le aveva letto poesie da un vecchio libro.
Le aveva spazzolato i capelli come piaceva a lei—con movimenti lenti e delicati.
Le aveva parlato del tempo, degli uccellini fuori dalla finestra, di piccole cose quotidiane, come se mia madre potesse capirla perfettamente.
«Non doveva stare da sola,» ripeté appena udibile.
Crollai in lacrime, lì, in piedi, con il senso di colpa e il dolore che mi travolgevano.
Quella sconosciuta aveva dato a mia madre qualcosa che io temetti di non essere riuscita a darle: la presenza.
Mesi dopo, mentre sistemavo le sue cose, trovai un quaderno sottile nascosto in un cassetto.
Non l’avevo mai visto prima.
La calligrafia non era quella di mia madre.
Erano brevi annotazioni, datate con cura.
Note scritte dall’operatrice.
«Le piacciono le vecchie canzoni d’amore.»
«Sorride quando le spazzoli i capelli.»
«Oggi era agitata, ma si è calmata dopo che le ho letto un po’.»
Pagina dopo pagina, il quaderno raccontava piccoli momenti a cui non avevo assistito.
Prove che mia madre, anche nei suoi ultimi giorni, era stata vista.
Era ancora conosciuta.
Sull’ultima pagina, una sola frase:
«Oggi ha parlato di sua figlia. Le voleva molto bene.»
Stringo quel quaderno al petto come la cosa più preziosa che possiedo.
Non perché abbia cancellato la mia colpa.
Ma perché mi ha ricordato che, anche quando non potevo esserci… mia madre non è mai stata veramente sola.
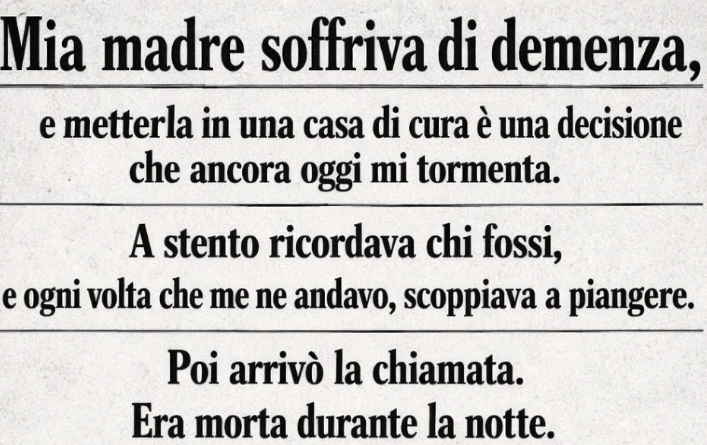



Add comment