Avevo 38 anni quando finalmente vidi quelle due lineette sul test. Dopo anni di tentativi, visite mediche, speranze spezzate, quel giorno piansi dalla gioia. Ma la mia felicità durò poco.
La madre di mio marito, Nadia, mi guardò dritta negli occhi e disse: “Se non è un maschio, puoi anche andartene da casa mia.”
Mio marito, Luca? Inutile. Borbottò qualcosa tipo “Sarebbe bello avere una bambina”, poi tornò a fissare il telefono, come se nulla fosse.
Io volevo solo un figlio sano. Maschio o femmina, che importanza aveva? Ma tra pressioni, battute velenose e quel senso continuo di non essere mai abbastanza, capii che dovevo fare qualcosa.
Organizzai una cena per la rivelazione del sesso del bambino. Ma quella non sarebbe stata una festa. Sarebbe stata la mia rivincita.
Torniamo un attimo indietro.
Io e Luca eravamo sposati da quattro anni e abitavamo nel piano superiore della villa di famiglia, “solo per risparmiare un po’”, diceva lui. Ma quei risparmi non arrivavano mai. Ogni mese spuntava una nuova spesa. Il nuovo telefono di lui. I “problemi di salute” improvvisi di lei, sempre pagati con la mia carta.
Nadia mi trattava come un’ospite indesiderata. Entrava in casa senza bussare, criticava il modo in cui piegavo gli asciugamani, il cibo che cucinavo, perfino le scarpe che portavo. Ma io tacevo. Ero stata educata alla gentilezza. Al rispetto.
Poi è arrivata la gravidanza. E qualcosa in me è cambiato.
Non potevo permettere che mia figlia—sì, dentro di me lo sentivo, era una femmina—crescesse in un ambiente dove l’amore aveva condizioni.
Quando dissi a Nadia che aspettavo un bambino, avevo preparato una scatolina con il test, avvolto in un calzino minuscolo. Lei la aprì, mi guardò con disprezzo e disse: “Speriamo che sia un maschio. Altrimenti che senso ha?”
Pensai stesse scherzando. Non lo era.
Disse che solo i maschi portano avanti il nome di famiglia. Che le femmine servono solo a sposarsi e a uscire di casa. Era come ascoltare un discorso da un altro secolo.
Raccontai tutto a Luca quella sera. Rispose: “Lo sai com’è fatta. Non darle peso.”
Ma io non potevo più ignorare.
Iniziai a prendere appunti mentali. Ogni commento sprezzante. Ogni carezza sul ventre seguita da: “Speriamo sia forte…” sottintendendo “speriamo non sia femmina.”
Due settimane prima della cena, ebbi una piccola emorragia. Niente di grave, ma abbastanza per farmi correre al pronto soccorso. Luca disse che non poteva venire, troppo lavoro. Nadia rispose con un messaggio: “Non esagerare sempre.”
Ero sola. E in quella solitudine, trovai una forza che non sapevo di avere.
La cena fu curata nei minimi dettagli. Tavola apparecchiata come per Natale. Candele. Tovaglioli di stoffa. Nadia arrivò con venti minuti d’anticipo e controllò tutto come un ispettore. Luca, in ritardo e in felpa.
Quando fu il momento, portai in tavola una scatola bianca, legata con due nastri: uno azzurro, uno rosa.
Gliela porsi. “Aprila tu.”
Nadia sorrise per la prima volta in mesi. Aprì la scatola. Dentro c’era solo un foglio. Lo aprì.
Cosa c’è scritto?, chiese Luca.
Lei lesse ad alta voce: “Prima di scoprire il sesso di questo bambino, chiediti: lo amerai comunque?”
Silenzio.
Poi Nadia sbuffò. “Ecco un’altra delle tue sceneggiate.”
Mi alzai in piedi. Ferma. Decisa.
“Non è una sceneggiata. È una domanda. Perché io non crescerò mia figlia in una casa dove l’amore dipende dal suo sesso.”
Lei cercò di interrompermi. Io continuai: “Mi hai detto di preparare le valigie se fosse stata femmina. Così l’ho fatto.”
Trascinai da dietro la tenda una valigia chiusa. Nadia sbiancò. Luca rise nervosamente. “Te ne vai davvero?”
Scossi la testa. “No. Ve ne andate voi.”
Poi gli porsi una busta. Dentro c’era un contratto d’affitto per un bilocale, intestato a me. Sei mesi già pagati.
“Sto andando via. Non domani. Oggi. E non voglio che nessuno mi segua.”
Presi un’altra busta. Quella vera. L’aprii lentamente. “È una femmina.”
E sorrisi. “E crescerà sapendo di essere amata. Senza se, senza ma.”
Me ne andai quella sera stessa.
I primi tempi non furono facili. La solitudine, la stanchezza, il peso della pancia che cresceva. Ma dormivo serena. Per la prima volta, ero padrona della mia vita.
Tre mesi dopo, arrivò una lettera. Di pugno, da Nadia.
Scrisse: “Ero nel torto. Ho creduto a quello che mi avevano insegnato, ma non è giusto. Ho perso troppo. Se me lo permetti, vorrei conoscere mia nipote. Senza pretese. Solo con amore.”
Quando nacque Luna, e la tenni tra le braccia, sapevo che avevo fatto la scelta giusta.
Mandai una sola foto. Senza parole.
Due giorni dopo, Nadia era sotto casa. In silenzio. Aspettava.
Scesi con Luna in braccio. Lei si avvicinò e sussurrò: “È perfetta.”
“Lo so.”, risposi.
Non ci fu abbraccio. Solo uno sguardo nuovo. Umano.
Da allora, stiamo ricostruendo. A piccoli passi. Ma veri.
Luca ha iniziato terapia. Si è allontanato da sua madre. Vuole esserci per Luna. Ogni giorno. E per ora… lo sta facendo.
Non è la famiglia perfetta che sognavo. Ma è la realtà. E va bene così.
Perché ho capito una cosa: l’amore vero non impone condizioni.
E mia figlia? Merita tutto l’amore del mondo. Non perché è femmina. Ma perché è mia. E basta.


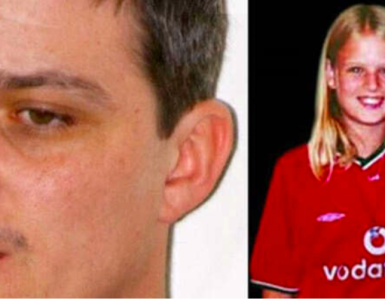

Add comment